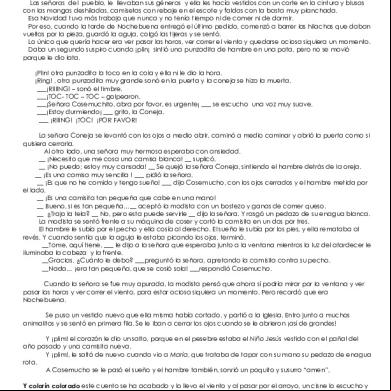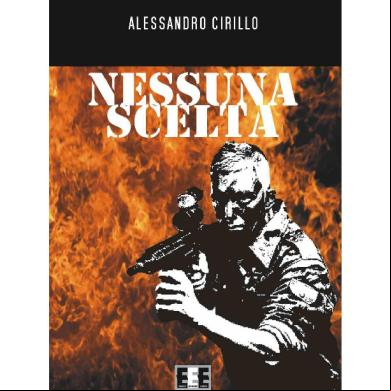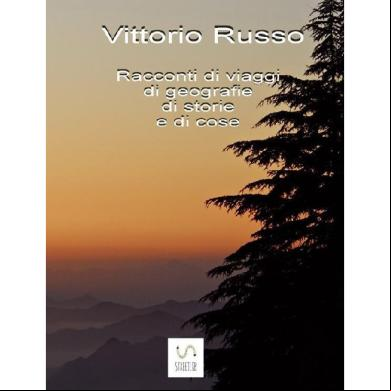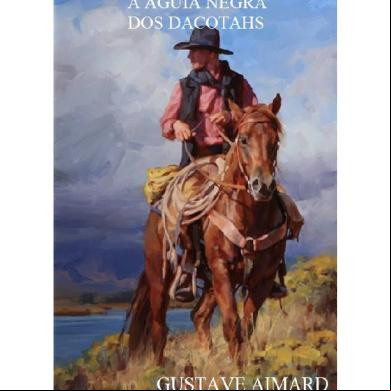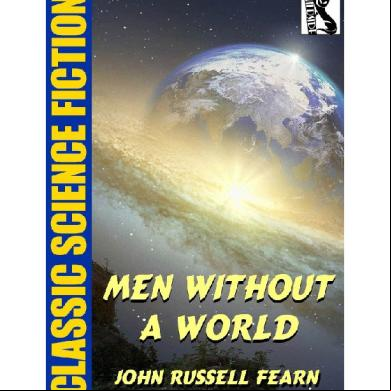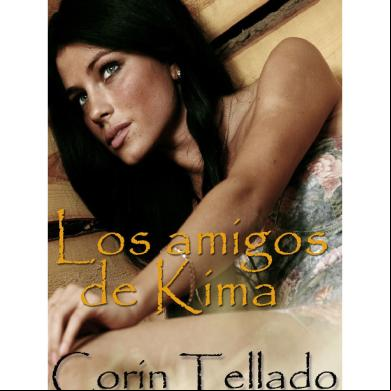Cose Minute Di Nessuna Importanza 6k6127
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View Cose Minute Di Nessuna Importanza as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 24,424
- Pages: 127
- Publisher: Meligrana Giuseppe Editore
- Released Date: 2015-02-12
- Author: Cristiano Prakash Dorigo
Cose minute di nessuna importanza
Cristiano Prakash Dorigo
racconti
Meligrana Editore – Priamo
-
Copyright Meligrana Editore, 2015 Copyright Priamo Editore, 2015 Copyright Cristiano Prakash Dorigo, 2015
Tutti i diritti riservati – All rights reserved ISBN: 9788868151164
Presentazione di Emanuele Pettener
Immagine di copertina: Marco Crestani
Meligrana Editore Via della Vittoria, 14 – 89861, Tropea (VV) Tel. (+ 39) 0963 600007 – (+ 39) 338 6157041 www.meligranaeditore.com [email protected]
Priamo www.priamoedit.it [email protected]
INDICE
Frontespizio Colophon Licenza d’uso
Cristiano Prakash Dorigo Copertina
Presentazione Premessa
Capitolo 1 (2001)
L’ultima scena (in tredici brevi atti) Scrittura e cura Verso casa Il mio nonno è un supereroe (in tuta blu)
Capitolo 2 (anni 2000)
Carnevale Cronache dai quotidiani Sto galleggiando nell’aria aggio Incontri (omaggio a Guccini e Mestre) Quaranta Segnali onirici di mezza estate (e di mezza età) Traversata Skype Piove Nero
Priamo Meligrana
Licenza d’uso
Questo ebook è concesso in uso per l’intrattenimento personale e non può essere rivenduto o ceduto ad altre persone. Se si desidera condividere questo ebook, è necessario acquistare una copia aggiuntiva per ogni destinatario. Se state leggendo questo ebook e non è stato acquisito per il vostro unico utilizzo, si prega di acquistare la vostra copia. Grazie per il rispetto all’impegnativo lavoro di questo autore.
Cristiano Prakash Dorigo
Operatore sociale da circa vent’anni, scrive racconti e testi vari da una dozzina. Prima pubblicazione nel 2002: racconto incluso nella raccolta “È da tanto che volevo dirti”, a cura di G. Caliceti e G. Mozzi, edito da Einaudi tascabili (Stile libero); racconto breve in raccolta di autori veneziani sul tema librerie in occasione dei 70 anni della libreria toletta (2003), edito da Marsilio; racconto inserito nella raccolta “Parole contro”, edito da Libreria zero, Padova (luglio 2008); co-autore (con Marco De Rosa) del libro di racconti “Biografie Incerte”, edito da Mare di Carta, Venezia (settembre 2008); autore del libro di racconti “Homo sapiens nord est”, edito da Mare di Carta (2011); “Un sinuoso contenitore smussato” (ebook), Priamo e Meligrana editori (2014); co-autore (con Marco Crestani) de “Attorno al tepore del cuore” (ebook) Priamo e Meligrana editori (2014); co-autore (con Marco Crestani) de “L’anarchico Emilio” Priamo editore (2014).
facebook: https://idoc-pub.futbolgratis.org/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="abc8d9c2d8dfc2cac5c485cfc4d9c2ccc4ebccc6cac2c785c8c4c6">[email protected]
Presentazione
’Esar e scrivar xè beo
“’Esar e scrivar xè beo,” mi scrive Cristiano Prakash Dorigo, di risposta alle mie congratulazioni per l’uscita di Un sinuoso contenitore smussato (Priamo/Meligrana, 2014). “Leggere e scrivere è bello.” È una frase che mi dà allegria: fare una cosa perché la si trova bella. E che altra ragione ci dovrebbe essere? Si noti inoltre: prima della scrittura viene la lettura, la congiunzione le mette sullo stesso piano, ma c’è poco da fare. Prima viene la lettura, ha un vantaggio di bellezza, si può dire. Che beo. Comunque, capita un anno fa che nei miei pigri vagabondaggi per la rete incontri un racconto di Cristiano Prakash Dorigo che mi piace molto, e mi piace molto anche quel nome risonante di cristianità, di India e di Venezia: insomma – malgrado si sia entrambi personcine riservate e financo timide – ci si scrive e si decide di trovarci, la scorsa estate, a Venessia naturalmente.
L’appuntamento è a Campo Santa Margherita nell’ora più dolce di un caldo pomeriggio di maggio, e Venezia è più sensuale che mai: i riflessi rosati sulle case, l’ebbrezza studentesca, le ragazze che sorridono, i libri stretti al seno, e i gatti che se ne infischiano. Noi ci sediamo al bar rosso, detto così perché è tutto dipinto di rosso, e si comincia a ciacolare, e lo so che la frase è abusata, ma è vero: mi sembra di conoscerlo da una vita! Sapete quando ci si sente a proprio agio e non c’è la necessità d’indossare una maschera? Che forse è una maschera anche quella, chi lo sa. Con Cristiano, quella volta e poi per tutta l’estate, si parla spesso di maschere. Di vanità, di poesia, di Bolaño, delle sfumature di certi avverbi, e ancora di maschere. Del resto Cristiano xè Venessian, purissimo, sestiere di Dorsoduro,
corte Mazor. Ora a Venezia non ci vive più – “purtroppo,” mi dice – ma ci lavora, e la vive attraverso la sua professione di operatore sociale, quotidianamente, profondamente, la sonda, la assorbe, vi trasfonde tutta la sua energia, le calli, i campi, i masegni son tutti suoi: poi scatta una foto e me la manda in Florida. El xè oro. Orbene, si ciacola, si beve uno spriss, poi un altro, mi fa una testa così con Bolaño. Del resto Cristiano ha, per i libri, una ione non affettata, una ione in cui non manca mai un elemento fanciullesco di stupore, soprattutto quando scopre un artista nuovo, come Bolaño appunto, che alla fine m’ha costretto a leggere. Senonché ci scambiamo pure le cose che abbiam scritto noi (Cristiano ha debuttato con un racconto inserito in un volume curato da Giuseppe Caliceti e Giulio Mozzi, È da tanto che volevo dirti, Einaudi, 2002) e grazie a Dio abbiamo entrambi superato quella fase primordiale che prevede i complimenti reciproci e lui mi dice chiaro chiaro quel che gli è piaciuto delle mie cose e quello che non gli è piaciuto, e mi fa domande, s’incuriosisce, si stupisce, e poi torna a parlar di Bolaño, ovviamente.
Io la sua raccolta di racconti Homo Sapiens Nord Est (Mare di Carta, 2011, appena riproposta in e-book dallo stesso editore) me la porto in treno per Roma, e inizialmente sono scettico, la materia mi è lontana per gusto (roba dura, da stomaci forti) e in effetti il primo racconto non mi convince del tutto. Poi però è un crescendo, un’immersione, e fondamentalmente mi entusiasmo per un motivo: Cristiano possiede un modo di scrivere che è tutto suo, originale, come chi ha l’esclusivo interesse di raccontare una storia e raccontarla nel modo più efficace possibile, lasciando risplendere ogni piccolo angolo del quadro, dal dolore dei protagonisti al portaombrelli sullo sfondo; vi è una forza viscerale nella sua scrittura (fatta di scatti, rimbalzi, ritorni), e trovo alcuni racconti davvero bellissimi (tutti quelli della seconda metà, essendo il libro architettato in due parti) e uno intitolato “Tatto” che – scusate, ma è così che sento – è formidabile, dove i sentimenti di un uomo lasciato da una donna vengono esplorati come non avevo mai letto prima. Perché Cristiano (e certo il suo lavoro gli ha dato esperienza) è un esploratore d’umanità – affascinato, partecipe, mai giudicante, mai onnisciente – e non è mai kitsch, non è mai falso. Insomma, per farla breve, come ogni volta che trovo qualcosa che mi sembra bello, chiamo subito l’editore di Priamo, Marco Crestani – di solito scrivo una
scheda, ma stavolta sono in treno, e poi si tratta di un libro già pubblicato – e chiedo a Cristiano di mandargli una copia di Homo Sapiens Nord Est, e Marco se lo legge da cima a fondo, e anche a lui il libro piace moltissimo, contatta Cristiano, gli chiede se ha dei racconti nuovi, s’incontrano anche loro a Venessia, al bar rosso (io nel frattempo me ne son già tornato in Florida) e si bevono uno spriss e parlano di maschere, di vanità, di poesia, dei libri che hanno letto, dei libri che vogliono fare, e poi Cristiano gli parla di Bolaño. Emanuele Pettener
Premessa
I quindici racconti qui raccolti sono divisi in due capitoli e offrono una visione interiore di fatti che hanno uno sfondo sociale, ambientati nel nuovo millennio.
Capitolo 1
(2001)
L’ultima scena (in tredici brevi atti)
1
È ato del tempo, tanto, troppo, mai abbastanza. Ricordo ogni particolare, anche i dettagli più stupidi, insignificanti, minimali. Era settembre, New York fremeva di incantesimi vitali, e sembrava pronta ad abbracciarti. E noi la lasciavamo fare, ricambiandola. La giornata iniziava con la luce del mattino che entrava sfacciata dalle finestre, appoggiandosi sui miei occhi stanchi, dopo una notte tormentata. Non capivo il tormento; non ce n’era ragione: eppure c’era, sfidando la logica. Ero in compagnia della felicità, che dormiva beata accanto a me, con la sua schiena nuda, dopo avermi regalato un’altra giornata di gioia. Eravamo arrivati da due giorni e forse subivo ancora il fuso orario. Ad esempio per assurdo ricordo la colazione di quella mattina e quello che ci siamo detti. Nella sala dell'hotel dove c'era il buffet self-service, ci eravamo riservati un tavolo strategico, da cui servirci senza farci troppo notare. Avevo insistito io per sederci là, con l’ombra del provinciale che si muove con circospezione. Dopo il secondo giorno, a dire il vero, avevo capito che non serviva, che eravamo tra quelli che mangiavano meno, e che gli americani non giudicano un diritto: se la prenotazione prevedeva “breakfast”, si pagava l'opzione, e si era
padroni di fare ciò che si voleva senza dover patire il sentimento dei furbi. Quella mattina ridevamo perché c'era un tipo che aveva il parrucchino, e di fianco, il suo fidanzato aveva i capelli lunghi fino alla piega delle ginocchia. Dopo colazione siamo risaliti in camera. La scena nella mia testa è cinematografica. Lei esce dalla doccia, un asciugamano legato sotto le ascelle e uno in testa. La guardo e lei capisce subito. Con l'indice fa segno di no. La guardo implorante, scherzoso. - “no che poi mia sorella mi guarda e capisce subito. E io voglio che prima ti conosca: non voglio lasciarle troppo spazio di immaginare ciò che vuole. Lei è la sorella maggiore e ha sempre detto la sua. Stavolta voglio che ti veda, che vi parliate, che tu la faccia ridere come fai ridere me, e poi tutto quello che vuoi…" Nel finire la frase compie con la mano il gesto goffo della tigre che graffia l’aria. - “va bene, vorrà dire che se i due fidanzati mi invitano... Poi non lamentartene...” Avevamo riso insieme con un'armonia complice. Amavo farla ridere, vedere il bianco dei denti, gli occhi che luccicavano, che finivano sempre col lacrimare, il corpo che si scuoteva un poco. Scusa se mi interrompo, ma ricordare il suo sorriso è più di una fitta; è un male fisico, una forza contorcente. Prima che uscisse ci siamo baciati. Un bacio innamorato è un piccolo evento, o magari una cosa da niente. Nessuno però ne parla mai, forse perché contiene un'intimità che non ha il suono delle parole, l'estetica del racconto. Ma quel bacio, quella tenerezza, quell'intesa. La sua bocca profumava di acqua di mare.
Era morbida, era vorticosa, era abissale, era totale. Lei è uscita, ma prima mi aveva scritto tutte le istruzioni coi nomi delle stazioni, mi aveva ricordato di comprare i biglietti della metro, di non dimenticare portafogli e telefono, di non guardare le altre ragazze. Eravamo teneri e stupidi, volutamente, come lo sono tutte le coppie innamorate, che sono uniche, che sono tutte uguali. Era uscita abbandonandosi a un ultimo gesto slanciato, naturale, come possedesse la naturalezza e l'agilità, e le contenesse nel corpo e nell'istinto. La vedo ancora in presa diretta - macchina in piano sequenza, senza mai staccare, da inizio a fine scena -. Appena curva sul mobile accanto alla porta, il piede destro sulla punta, il braccio che comanda il movimento della mano - una mano bellissima, affusolata, dita lunghe - che attacca il post-it sulla porta. Uscendo mi guarda un secondo appena, sorride, chiude la porta dietro sé. La scena finisce. È l’ultima scena.
2
Il foglietto con le istruzioni prevedeva qualche fermata di metropolitana. Ma a me piace guardare la città dalla strada; la metro la prenderò magari al ritorno con lei, pensavo. Volevo vedere le facce di questa città che contiene tutte le razze del mondo, volevo che mi costassero fatica, che mi costringessero all’incontro col miscuglio di umanità e alla digestione di così tanta roba. Volevo impararla, memorizzarla, riuscire a raccontarla.
Mi sono preparato, vestito come mi aveva consigliato lei per impressionare la sorella, senza insospettirla: “vola basso ma mai rasoterra”, mi aveva detto. “Non fare citazioni, ma se si tira fuori l’argomento libri, non risparmiarti; non nominare le parole “economia” o “finanza”: ricordati che lei lavora al centro del centro finanziario mondiale che deve sopportare degli stronzi superintelligenti dieci ora al giorno quando le va bene che deve fare due ore di viaggio tra andata e ritorno e che non ne può più di sentire parlare in modo generico di un mondo che combatte ogni minuto una guerra per il destino dello stesso con gente che conosce solo la verità per averla letta nei libri o sentita in tivù o vista nei film e non ha la più pallida idea di cosa sia la ferocia dei potenti che governano i nostri destini”. L’aveva pronunciata tutta senza prendere fiato, senza punteggiatura, ripetendo forse quello che la sorella le aveva detto dei rammolliti alternativi che le aveva presentato prima di me. E siccome con me voleva andare fino in fondo, voleva fermarsi e concedersi il sogno, la realizzazione di un sospetto - non il principe azzurro, ma un più concreto amore da amare-, la concreta libertà di un legame vero, il consenso della sorella era l’ultimo prerequisito per iniziare un progetto complesso e naturale: la sua nuova famiglia, l’adultità, la scommessa fatta, vinta e incassata; che tutta la fatica che aveva fatto, tutte le energie che aveva investito, erano state riconosciute e premiate. Il solo pensiero, se fosse stato solo a livello di pensiero, mi avrebbe pesato talmente tanto che me ne sarei scappato; ma invece tutto questo, era lei; la sua intelligenza, la sua bocca, il suo culo, le sue mani, il suo sorriso.
3
L’avevo conosciuta dopo averla vista un giorno a Venezia. L’avevo notata subito, e me ne ero subito, un poco, innamorato.
Una bionda coi capelli che non arrivavano alle spalle, che lasciavano il collo scoperto a metà. Il collo che avrei voluto baciare subito, in quell’istante. Eravamo in un bar all’aperto; io aspettavo un amico scrittore, lei era con un amico, uno che stava facendo un dottorato alla facoltà di chimica: un chimico, diceva lei, destinato a fallire professionalmente, visto che la chimica stava scomparendo da Venezia: Marghera è una tomba futuribile, un morto, come una palla in discesa, che sta rotolando verso la scomparsa definitiva in una discarica, aggiungeva. Ricordo il suo sorriso che evidenziava i denti, che sembravano meno bianchi di quanto siano in realtà a causa del pallore della pelle: un pallore che ho amato subito. C’era vento, vedo ancora la grazia del gesto di mettersi il cardigan leggero a coprire spalle e braccia, colpite dalle brevi raffiche di una parentesi d’estate stranamente fresca, che aveva preceduto l’afa che l’avrebbe stretta pochi giorni dopo. Lei parlava, sorrideva, rideva, e io la guardavo a tratti, distraendo lo sguardo dagli occhi dell’amico scrittore, che mi stava dicendo che Hemingway secondo il suo parere era uno sopravvalutato. E io rispondevo che sì, forse aveva ragione; e poi aggiungevo che avrei voluto leggere un romanzo in cui Kundera mi raccontasse di quella bionda che conteneva un’interiorità misteriosa e radiosa; un racconto che avrei letto, imparato a memoria, decantato ad alta voce come una poesia. Ad un tratto il cardigan era volato via; il suo amico si era subito alzato per recuperarlo, ma aveva trovato me, già pronto a consegnare il maglioncino in cotone morbido e leggero nelle mani di quella donna che mi aveva ringraziato, guardato con gli occhi sorridenti, a cui avevo sorriso ma non troppo perché, al solito, mi vergognavo di mostrare alle donne che mi piacciono, che mi piacciono. Poi avevamo ricominciato a parlare di libri con l’amico scrittore, concordando su alcuni punti, discordando su altri. Ma non era importante; l’unica cosa che contava era potersi concedere alla bellezza, all’intimità, alla sensazione che l’amicizia concede riposo e verità,
anche se non pronunciate da parole, ma da quello che si sente, che non si verbalizza per non sprecarlo. E lui aveva visto e capito, e aveva accettato il mio ascolto a tratti distratto. Non sempre si può essere al centro dell’attenzione, ma non sempre si è in grado di accettarlo.
4
Ci eravamo poi ritrovati durante una manifestazione in cui io leggevo un pezzo davvero brutto di un altro autore, cui avevo aderito per far sì che il mio nome diventasse un’abitudine a cui non rinunciare, in quell’ambiente abitudinario e conservativo e settario. “Ci siamo già visti da qualche parte?” aveva chiesto lei. "Non solo visti: ti avevo proprio guardata per almeno un’ora", rispondevo, lasciando uscire parole dalla mia bocca che non avevo ordinato al mio cervello di pronunciare. Lei aveva sorriso, mi aveva dato la mano per presentarsi: “mi chiamo Samantha con la th finale, aveva detto”. “Samantha? io Eugenio: piacere!”. Le avevo baciato la mano e avevo visto stendersi sul suo braccio la pelle d'oca; la stessa cosa che mi aveva scosso dentro, come se il solo toccarla fosse un esperimento chimico che sprigionava un'energia cui potevamo assistere, senza sottrarcene. Era arrossita un poco e subito aveva aggiunto: non mi chiamo Samantha, ma più banalmente Teresa, aveva aggiunto, senza lasciarmi la mano. È qualcosa che non dipende da noi, scegliersi: è il destino, dio, le leggi di sopravvivenza della specie, la storia già scritta.
Quando accade, lo si sente; si sa che è così, che così dev'essere, e che la verità ha una sua natura semplice, benché si manifesti raramente. E allora bisogna subito afferrarla, lasciarsi penetrare, nutrirsene. E così abbiamo iniziato ad amarci subito, perché avevamo sentito entrambi la stessa “cosa”.
5
Ero uscito e il rumore di New York mi aveva invaso. Le auto, coi loro aggeggi brutali, i tubi di scappamento, i clacson, le urla, le sirene, il giallo dei taxi; non si accorgevano che tutto questo congiurava contro la loro salute di cittadini di una città mostruosa, la cui mostruosità, in effetti, costituiva, assieme alla sua vitalità, un fascino unico. Ogni città ha dei segreti stratificati: certe città americane, contrariamente a certe altre europee, non li nascondono; te li mostrano in modo trasparente. New York contiene il meglio e il peggio che un ambiente urbano possa offrire, e non si vergogna per questo: afferra ciò che puoi ma attento: se cadi ti fai male; e se cadi, e lo vuoi, c’è sempre il modo di rialzarsi e ricominciare. Cadere, crollare, confliggere, conoscere, costruire, castrare, ricominciare. Avevo praticamente assorbito tutta quell’energia subitaneamente, e mi ero dimenticato di quanto avevo pensato pochi minuti prima. In strada si percepiva un qualcosa difficile da spiegare: facevamo tutti parte di un progetto segreto, di cui nessuno conosceva dimensione, scopo, obiettivo, ma che era decisivo per le sorti della città, e per i suoi abitanti. Una metropoli in cui ci si può sentire terribilmente soli, ma mai isolati; una città che lascia decidere a te il tuo destino, te ne offre la possibilità, te ne chiede la responsabilità, ti presenta infine il conto. Camminavo immerso in questi pensieri, di cui mi vergognavo un po’ per la loro ordinarietà, ma che non riuscivo a evitare.
Al contempo sentivo scorrere dentro me la grazia del privilegio di aver incontrato una delle donne più notevoli al mondo, che amavo e che mi amava, in modo talmente naturale, e perciò perfetto, da non sembrare vero, pur nell’evidenza della realtà, che testimoniava il contrario. Avevo messo la mano nella tasca dello zaino dopo averlo tirato giù dalle spalle, aperto la cerniera, tirato fuori il cellulare quando ho sentito un rumore lontano, un boato indistinguibile, eppure di una qualità speciale di straordinarietà. Un BOATO la cui resa onomatopeica avrebbe bisogno di lettere MAIUSCOLE: un misto tra un ruggito ROARR, e uno scoppio BUMM. Avevo guardato il cellulare, quando un ragazzo mi aveva urtato, facendomelo cadere a terra: correva, scappava, non mi aveva nemmeno guardato. Raccogliendolo da terra, e successivamente alzando lo sguardo, avevo notato la fumata nera che si alzava decisa nel cielo.
6
Ci avevo impiegato qualche secondo a collegare il rumore, il fumo, il ragazzo; avevo messo a fuoco lo sguardo e avevo visto: il fumo veniva dalla torre di fronte a quella dove lavorava Giulietta, la sorella di Teresa. A quel punto, in quel preciso istante, ego, hic et nunc, in quella città estranea a me, che non conoscevo, di cui sapevo più quello che si dice che quello che è, ho sentito che una morsa tenera mi legava agli altri, a quel ragazzo che mi aveva urtato ed era scappato, aGiulietta, a Teresa, ai suoi colleghi, a tutto il grattacielo, a tutta la città, a tutto il mondo, al cosmo, all'universo, all'infinito, alla concreta e spessa valenza del male; il male che mi faceva quell’immagine, quel rumore, quei pensieri d’amore e morte. Il tempo era durato più del solito, come sempre, come tutto il tempo, in cui il dolore è padrone e costringe il resto all’esilio. L’ufficio di Giulietta era al non so quale piano: qualche decina e rotti. Vedevo il retro del grattacielo rispetto a dove c’era l’aereo, il fumo che usciva da dietro. Cercavo di calcolare l’altezza in cui l’aereo, di cui vedevo un pezzo minimo spuntare da non capivo bene dove, si era conficcato; volevo capire se poteva essere l’altezza dell’ufficio, se potessero essere proprio lì, le due sorelle
più importanti della mia personale storia d’uomo. Non so a che distanza ero dal posto; non sapevo esattamente niente: non ero in grado di razionalizzare alcunché. L’unica cosa che so per certo è che correvo, e forte, come mai, come avevo visto fare solo nei film, verso la direttrice visibile della mia probabile tragedia. Mentre correvo, la gente era inebetita, immobile con lo sguardo rivolto alle torri, oppure correva disorientata verso un altrove che fosse distante da lì.
7
La prima volta che avevo fatto l’amore con Teresa, era stato un evento. Avevo avuto già diverse relazioni, numerosi incontri occasionali, talvolta dal punto di vista dell’immaginario erotico maschile, più eccitanti. Ricordo una ragazza che aveva voluto farsi scopare in piedi, nascosti dietro la colonna di una chiesa veneziana, eccitata all’idea di essere lì a Venezia, di poter raccontare qualcosa alle amiche americane, ma soprattutto di poter essere intravista casualmente da qualcuno: un ante, oppure un prete, o chissà chi. Ansimava in modo eclatante, e sembrava godersela davvero, benché al contempo la sentivo lontana; o forse lo ero io. Con Teresa invece non era una questione di tecnica, di bravura, di eccitazione: con lei era semplice, era spensierato, e totalizzante. Erano incursioni in zone temporalmente e spazialmente sconosciute. Un distacco dalla dimensione terrena, dove il controllo, la mente, l’abitudine, perdevano il loro senso e significato. Sembrava fosse normale, pur essendo, in modo evidente, straordinario.
8
Mentre correvo verso le torri, mi era venuto il dubbio che avessi sbagliato, e che non fosse quella, la torre: che fosse l’altra, che fosse stata l’agitazione, la paura, a indurmi a pensarlo. Mentre correvo senza sosta, pensavo che aver pensato all’amore mentre mi sentivo in guerra, era una sorta di aggiustamento biologico per pareggiare i conti. La scena nel frattempo aveva assunto la forma di una paradossale concretizzazione dell’impossibile. Un aereo di linea che si va a conficcare in uno dei grattacieli più conosciuti del mondo; a raccontarla, nessuno ci crederebbe. Il tempo era incontenibile, non si poteva calcolare; frammenti accelerati si alternavano ad altri di immobilità. Correndo avevo iniziato a sudare, mi ero tolto lo zaino dalle spalle, tolto la felpa, messo all’interno dello zaino, riposto questo sulle spalle, il sudore che si attaccava alla schiena. Correvo mentre accanto a me, i suoni, le espressioni, i movimenti, erano preda di quegli stessi sbalzi temporali che io stesso percepivo. I movimenti erano lenti, sincopati; oppure all’improvviso acceleravano in modo incontrollato: un consumo d’energia fuori misura, verticale, stroncante. Ma io dovevo correre, e correvo. Ad un certo punto si sente il suono prorompente di un aereo. Mille sirene ovunque non riuscivano a coprirlo. Poi un boato. Vetri fughe di gas incendi sirene urla fumo grigio bianco nero frammenti volteggianti pianti disperazione cemento imprecazioni cantilene catatoniche immobilità frenesia caducità limite. Un tempo di simultaneità. La descrizione di un tempo senza grammatica possibile e onnicontenente e esatto e sbagliato.
La testa agisce da sé, dirige lo sguardo verso l’alto, guidato dall’istinto, e gli occhi vedono e registrano. L’aereo arriva, curva un poco a sinistra, s’infila dentro l’atra torre, deflagra. La mente paralizza tutto, fuorché le gambe, che continuano a correre, in accordo coi muscoli involontari, e invade ogni cellula, uccidendo ogni speranza, ogni felicità futuribile, ogni prospettiva, ogni colore che non sia il nero. A quel punto il panico è la precondizione necessaria alla sopravvivenza, al non soccombere a se stessi, alla reazione. Guardo le torri gemelle, immagino le due sorelle quasi identiche, gemelle: la mia mente gioca con le parole, costruisce arzigogoli, avanza similitudini: sta evidentemente preparandosi ad affrontare la bestia del dolore feroce.
9
Ricordo la prima volta che siamo stati insieme. Il pudore pareva un orpello inutile, l’intimità era arrivata prima e ci aveva accolti con semplicità, come ospiti amici con cui è bello stare insieme. Il suo corpo ed il mio avevano perso peso e consistenza, e si fondevano senza fatica. Il letto su cui eravamo stesi roteava vigorosamente, il tempo aveva cessato il suo avanzare e lo spazio era con-fuso nei suoi normali confini, alle nostre misure. Eravamo talmente giovani ed elastici, e anche vecchi in confidenza, che la dolcezza e la foga e il vigore e la debolezza faticavano a frapporsi in quegli abbracci in cui, materia e nulla, compenetravano ogni atomo. Eravamo consapevoli di essere venuti a contatto con l’assoluto, con un genere di esperienza sovrumana.
10
La città era diventata un sospiro, una sospensione temporale. Due aerei che si infilano in due enormi grattacieli sono un evento inimmaginabile. Ogni fantasia appariva ridicola, ogni pensiero impensabile, ogni speranza disperata. Ero in una specie di guerra inutile e improvvisa, in un’angoscia senza preavviso, e ne ero invaso. Tutto vibrava, un fragore sotterraneo borbottava, un calore insopportabile si spargeva su ogni cosa. Il senso di tutto ciò non poteva esistere. C’è stato un momento in cui tutto si è fermato. A vederlo da fuori, lo si può immaginare così: sei al cinema e nel bel mezzo di una scena, la pellicola si blocca. La dinamicità della trama, il coinvolgimento emotivo, la sequenza logica si fermano a loro volta. La percezione del tempo svanisce e perde significato. All’improvviso però la scena riprende.
11
Non lo so, non so più niente. Vedo soltanto. E sento. E percepisco e incamero.
In un dato momento, il momento ics, viene giù tutto. Il crollo a vederlo sembra logico. L’aria si satura di un fragore totale. Si alza una massa enorme, che continua a gonfiarsi e crescere fino a coprire la città, il mondo, l’universo. Presto ne siamo tutti ricoperti, non si può parlare, respirare. Il mio paradiso terrestre si ricopre di detriti, di polvere, terrore, stupore, dolore, rabbia, spossatezza. Mi sforzo di ricordare il suo volto, il corpo, gli occhi, gli zigomi, le labbra, la schiena, ma non vedo niente, solo buio polveroso, anche sui ricordi. Mi pare invece di sentire l’odore del suo alito quando mi parlava la notte e mi raccontava di quando era bambina, dei giochi che faceva, delle fantasie che aveva, di cui facevo già parte, anche se non mi conosceva, ma mi sapeva già vivo e presente nella sua carne virginale e innocente.
12
Non so come, non so perché, mentre correvo, chiudevo gli occhi, abbassavo la testa e mi lanciavo a più non posso contro un immenso camion dei pompieri. L’impatto è stato devastante, ma non sentivo niente. Il sangue mi aveva riempito la faccia; ne sentivo l’odore attraverso le narici, e il gusto, mentre mi colava verso il collo. L’odore e il gusto sapevano di rosso, di infinite variazioni di tono di quel colore, avevo pensato prima di crollare a terra. Quando mi sono svegliato, circondato da facce serie, affidabili, traboccanti di pietas e comprehensio gratuite, come se l’aver partecipato tutti insieme a una catastrofe collettiva potesse, se non condividerlo, ammansire il dolore di ciascuno, affidandolo ad un dolore più grande: una sorta di fossa comune,
collettiva, in cui seppellire e commemorare il proprio lutto. Ho chiuso gli occhi arreso, e ho pianto. La sua esistenza non è mai finita.
13
Al suo funerale ho pronunciato queste parole: “ Io non credo in Dio, e ho molti dubbi sulla natura della fede. Credo e conosco la meraviglia dell’esistenza e oggi sono qui per testimoniare anche la conoscenza dell’eternità. Teresa mi ha regalato la fede nella vita, la fiducia, mi ha convinto che esiste la possibilità di incontrare la magia, la totalità, la trascendenza carnale, la felicità eterna di un istante. Auguro a tutti noi di poter incontrare ancora una persona come lei, che è unica e insostituibile, ma come ci insegna la scienza, se un fenomeno accade una volta, è per definizione ripetibile. Io sono stato fortunato, anche se non potrò mai più essere felice.
Vi voglio raccontare brevemente questo episodio: eravamo a Parigi e eggiavamo per il lungosènna. Ad un certo punto, mentre camminavamo, ci siamo fermati: eravamo circondati da una fiumana di gente, e come accade spesso anche a Venezia, c’era un brusio multilingue che ci circondava. Ci tenevamo le mani e sentivamo le stesse “cose” (come altro definire quell’insieme di tutto, che ha una sostanza e un peso, e che al tempo stesso non è visibile ed è impalpabile?). C’è stato un istante in cui siamo stati totalmente investiti da una forza immane,
di fusione e comprensione, quasi insopportabile. È difficile da spiegare a parole poiché si tratta di sensazioni, e la sua essenza, non prevede l’uso del linguaggio. Eravamo al contempo frammentati e solidi, particelle atomiche e un tutt’uno con le persone, il brusio, l’aria, il cielo, il fiume, le pietre, le stelle. E tutto ciò, era contenuto in una sorta di amore universale, globale, che non prevede giudizio, commento, pensiero, ma solo abbandono. In questo momento di commozione sento di amare tutti voi, di provare un sentimento autentico di comione, e non chiedo altro che questa sensazione, che ormai è certezza, la possiate percepire anche voi: l’eternità esiste, e può essere solo qui, ora. Teresa mi ha concesso la grazia di credere in me e in questo. E anche che tutto ciò, e cioè io e questo, in realtà non esiste, in quanto la realtà è un’illusoria costruzione mentale. Esiste solo un flusso energetico, che è, e che è amore. Grazie”
Scrittura e cura
Ci sono improvvisi momenti di lucidità in cui si percepisce che tutto è diverso da come pensiamo che sia. In questi brevissimi istanti di risveglio qualcosa, dentro, si modifica. La prospettiva da cui di solito si osserva la vita, si apre all’ignoto. E tutto è limpido, cristallino. L’ignoto, in questi frangenti, si trasforma in chiara comprensione di quanto, normalmente, non riusciamo a essere ciò che in realtà siamo: di quanto ci difendiamo, di quanto abbiamo paura di ascoltare ciò che sentiamo, di quanto siamo lontani dalla nostra verità. Comincio in modo desueto la mia lettera. Ti scrivo, come sempre, per condividere quel che sento. Il nostro rapporto epistolare non soffre la distanza; anzi, ne trae beneficio; scava una maggiore intimità, e confonde, mischiandola, la verità oggettiva da quella percepita, sottraendosi così al dovere della cronaca, aggiungendo però sostanziose digressioni. Dura da molti anni l’abitudine di scriverti. All’inizio a penna, su dei fogli rubati alla fretta, col furore inoffensivo della giovinezza. Adesso con il computer, con una più tranquilla pulizia di stile. Adesso sembriamo immobilizzati, al confronto; in realtà, e lo sappiamo bene, abbiamo solo spostato i luoghi delle frequentazioni: da fuori, estetici, scintillanti; a dentro, profondi, autentici - nelle intenzioni, almeno -. Quando eravamo più giovani, eternamente tardo adolescenti, ci raccontavamo il ato e il futuro, fantasticando continuamente sulle infinite possibilità che la vita poteva offrirci.
Che male poteva fare, rielaborare ciò che era stato o sognare il divenire? Vanagloriosi, ostentavamo con fierezza la nostra trascuratezza e l’aria un po’ sconcertante degli alternativi alla forma. Non era in verità solo la rappresentazione di una concreta scelta sociale; o almeno non la percepivamo così. Era forse più un mascheramento, che doveva testimoniare come ci sentissimo diversi, come non riuscissimo ad essere come avremmo dovuto, come le regole del mondo fossero stritolanti, e alcuni vivessero in apnea, accontentandosi di un filo di respiro, mentre noi volevamo farlo a pieni polmoni. E allora: politica, musica, droga, sesso; tutti eccessi provinciali, baldorie fittizie, mascheramenti, recitazione. Tutti perfettamente omologati ad uno stile di vita parallelo che riuniva i diversi. Come collocare il disagio se non obliando pensieri pesanti, contestando le minuzie, i particolari, spesso senza valore? Quante avventure abbiamo vissuto che meritino un posto significativo nella nostra memoria; quante volte ci siamo sentiti perdutamente vivi? Recentemente ho letto alcuni libri che mi hanno offerto alcuni interessanti spunti. Dicevano, in sintesi, che lo scopo della vita è conoscersi, bastarsi, accettare la propria solitudine ed unicità. Da quando l’ho fatto, percepisco un continuo lavorio interiore; come ospitassi una presenza roditrice che sgranocchia le mie insicure certezze. Con la mente riesco a relegare in periferia queste scomode ed irriverenti idee; ma da lontano, come il riverbero di un’eco, sento che vivono e hanno lacerato la solida corazza delle mie sicurezze. Infatti non riesco più ad ignorarle, e ad ogni bugia, finzione, furbizia, reagisco come se ne fossi allergico. Così ho deciso di accettarne l’ineluttabilità, constatando che, forse, quel vago senso di vuoto che provavamo, e che continuava con sempre maggior insistenza ultimamente, potrebbe trovare risposte.
Ma devo spiegarmi meglio a te. Quando sono fuori casa, in un qualsiasi posto, osservo le persone. Ricordi quando eravamo ragazzini? Era un vero so per noi! Era come avere un’immensa lente d’ingrandimento attraverso cui guardavamo chiunque ridendo e scherzando come pazzi. Adesso no; adesso non m’importa niente di come uno si veste, si pettina, s’atteggia; adesso la differenza è dentro, è un profondo senso d’estraneità, di non appartenenza: a niente e nessuno. Non tollero più l’ipocrisia, le maschere, la finzione. Non accetto più di continuare ad abitarle, a non riuscire a staccarmene, se non con atti di attenzione, che mi restituiscono ciò che sono: l’inquilino di un robot, uno che presta le sue maschere alla messinscena della vita formale, sociale, riconosciuta come autentico compromesso, introiettato da tutti, riconosciuto come sola soluzione all’ammaestramento della bestia che ci abita e che teniamo a freno con surrogati di felicità consolatoria. Sono sconvolto da come questi elementi siano uniti, dalla simultaneità con cui si sono manifestati: sono solo, unico. Allora, mi dico, val la pena riflettere su come è strutturata l’esistenza, sull’organigramma sociale; su chi sa e organizza, attribuendosi in malafede un potere quasi divino, creando fasulle occasioni relazionali, reciproche tentazioni a pagamento, pretestuosi vizi e bisogni indotti, inibendo al rango di potenziale cliente, la persona e il suo istinto. So perfettamente cosa diresti a questo punto, a come mi guarderesti, con quegli occhi profondi, con la testa che annuisce; non esti la voce, ma io le sentirei comunque le tue parole, i tuoi pensieri, come tu sentivi i miei: diresti, senza parlare, che è quello che dici da sempre, che sostieni fin da quando eri poco più di un bambino, con cui ti sei sempre scontrato con me fin quasi a fare a botte. Ma non è quello: è qualcosa di più, qualcosa di più grande della sociologia, della psicologia; è un seme, soffocato, spesso talmente nascosto da dimenticarcene. È una libertà che non può essere soppressa dal pensiero razionale, dalle regole
sociali, dalla mistica delle religioni: è religione pura, è nudità totale, è segreto svelato. Non serve ribellarsi e rompere tutto; ci vuole una ribellione qualitativamente diversa, più concreta che apparente, più efficace che violenta, più libera che ribelle. Ho raccolto ogni singola lettera che ho scritto e, a rileggerle facendo attenzione all’ordine cronologico, se ne ricava l’evoluzione personale, quella ambientale, la precarietà e mutevolezza di idee che sembravano, se contestualizzate, promesse di fedeltà eterna. A volerle poi interpretare con occhio smaliziato, se ne potrebbe ricavare un diario di vita, un interessante rapporto epistolare che rivela senza filtri, complice la confidenza e le reciproca benevolenza. Emergono, tra gli altri, elementi che fanno pensare allo scampato pericolo, al superamento di una precarietà romantica e tenera che rimanda ai giocolieri circensi. Come equilibristi su una corda tesa, bisognava fare attenzione a non cadere, a raggiungere l’altro capo con calma, senza sbagliare. Confesso che più vado avanti, più lascio al tempo che fu la frenesia del fare per fare, del baccano per sottolineare la presenza, del seguire l’istinto senza cercare di comprendere quale natura lo spinga, lo faccia pulsare nel corpo e nella testa. Ora, ciò che sono, corrisponde sovente a ciò che faccio: mi sento autentico, coerente. Insomma, molto di quel che eravamo, non fa più parte di quello che sono adesso; se non in forma costitutiva, latente, che magari emerge quando un sentimento forte, l’agitazione, la distrazione mi invadono: allora, in quel caso, ciò che ero viene fuori, fa un balletto, e poi torna a cuccia. Volevo dirti quello che penso ora dell’amicizia, del bisogno di stemperare le divergenze, smussare gli angoli, accettare di farsi pungere dalle nostre spine aguzze, dagli sbalzi d’umore, dalle piccole cattiverie. Più ci si conosce, più emergono le parti in ombra, gli istinti primordiali, le parti nascoste dal bisogno di estetizzare quello che non ci piace di noi.
Solo scoprendosi, osando dire il taciuto, pur temendo di farsi male, ma non rinunciando a parlare, certamente faticando, ma con bontà, si riesce a rivelare l’interezza, l’unità disgregata senza più temere il giudizio. E così il rapporto di amicizia, più di quello amoroso, verbalizza i pensieri sparsi e disordinati che pensiamo continuamente, e che risultano sempre parziali, occasionali. Sforzandosi di comunicare, di costruire ragioni, pur anche irrazionali, nude, rivelate nella loro genesi ereditaria, familiare, ambientale, e perciò incolpevoli d’esistere, accettandole, confortati dalla reciprocità. Non è facile non giudicare, tenersi a distanza di sicurezza dai propri umori, dal proprio sistema valoriale. Ma quando si è amici, e lo si è davvero, la benevolenza supera e sublima questi tratti; e le contraddizioni, le difficoltà, diventano terreno neutrale in cui confrontarsi, anziché confliggere. Ogni tanto riguardo il video di allora. Ce ne sono un’infinità, così come le tesi a o. È impressionante, lacerante, e tu, lo so, ne saresti contento. Ti piacerebbe l’estetica barricadera, il contesto, il potere evocativo subliminale, la nettezza della sproporzione dei ruoli e dei giochi di forza. Nessuno mi può controllare se io sono centrato, se sono me, se sono autenticamente integro. La ribellione, la rivoluzione, sono sempre state della borghesia illuminata; talmente illuminata, da aver portato vantaggi concreti soltanto a loro stessi. Mentre la carne da macello si faceva massacrare, loro stavano già tessendo alleanze, contandosi, sfregandosi le mani, supponendo l’incasso. Non è rompendo una vetrina, gambizzando qualcuno; no, quello serve solo a misurare i giochi di potere, a consentirgli di giocare la parte delle vittime, riciclandosi nella nuova veste di chi subisce la violenza altrui.
Io sono libero se sono me, se riconosco le sovrastrutture, se intuisco le trappole delle ideologie; se me ne libero; se accetto infine di non appartenermi, perché io non sono più, sono sparito, fuso, compreso nel gioco dell’esistenza. Lo sai bene, l’avevo promesso che da allora, da quel preciso momento, avrei cambiato la mia vita; l’avrei vissuta cercando di comprendere. Sono ancora legato a quella promessa: ho iniziato un cammino che non prevede ripensamenti, che include in sé la pazzia e il suo antidoto, che mi ha segnato rivelandosi, talvolta, faticoso e pesante ma, al tempo stesso, autentico. Da quando ho cominciato a scriverti ho allontanato e controllato il dolore; è stato il mio modo di (r)esistere, di accettare gradualmente quello che era successo, anche se ho imparato, ormai, che i cambiamenti avvengono all’improvviso, come con un salto quantico, una discesa senza freni. Non si cambia un poco alla volta, se non nei ristretti confini del preordinato, del finto destino dell’educazione formale. Già da prima della nascita abbiamo un percorso prestabilito: feto-neonatobambino-adolescente- giovane-adulto-vecchio-defunto. Un cambiamento vero invece, accade: da un momento all’altro, eravamo in un certo modo, siamo qualcun altro. Perché ciò avvenga, bisogna accettare la parte ignota di noi stessi, mollare le sicurezze, abbandonare le abitudini, vivere ciò che è senza più pensare a quello che fu, senza preoccuparsi di quel che sarà. Esordivo dicendo che ci sono momenti di lucidità che illuminano brevi istanti; che da questi momenti se ne esce con l’intuizione che esiste un modo diverso di essere. Questi mi hanno aiutato a capire che ero sopraffatto dalla paura di soffrire e che dovevo reagire. In questi anni ho comunque vissuto, sono cresciuto, ho costruito rapporti, ho lavorato. Quest’abitudine di scriverti era il mio segreto; era il luogo in cui lasciare e conservare tracce di me che non sapevo, altrimenti, come esprimere. Mi ha aiutato a capire, a dire la mia verità, a sentirmi al sicuro come avessi un
rifugio intimo e inespugnabile; come avessi uno specchio che riflette la coscienza. Poi, per caso, senza avvisare, arrivano quei momenti e cogli il senso di quello che accade, della vita; che tutto inizia e finisce. L’immagine mostra una marea umana, fumo, fuoco, vetrine distrutte, urla, pestaggi violenti, cassonetti. È il caos assoluto, sfondo ideale per giustificare qualsiasi cosa. Il terzo Battaglione Lombardia dovrebbe raggiungere i black block che stanno distruggendo tutto. Si fermano però davanti al corteo delle tute bianche. Sono isolati dalla centrale operativa. Non si dirigono verso Via Tolemaide. Due Defender rimangono isolati in Via Caffa alle 17.22. Retromarcia verso Piazza Alimonda. Incastrati da un cassonetto, una delle due jeep riesce a partire. Rimane solo quella con l’ausiliario Mario Placanica e il suo compagno alla guida. A quattro metri e diciannove dal mezzo ci sei tu, in amontagna e canottiera. Forse vedi la pistola in mano al carabiniere, sollevi un estintore che trovi in strada. Ore 17.27 di venerdì 20 settembre 2001. Uno sparo. Un urlo “ODDIO. CAZZO. NOOOOO”. La jeep guidata da Filippo Cavataglio fa retromarcia e ti calpesta due volte. I tuoi amici spostano il corpo. Io guardo il video e vomito e piango.
Sto dicendo che questo comunicare, felice ma ermeticamente chiuso, sta esaurendosi. Che questo bisogno di interiorità sta cambiando luoghi e confini, che sarà più scoperto; che sono pronto a pagare il prezzo di questa nudità. Sto tentando di dire che val la pena rischiare, aprirsi, buttarsi nel mucchio, esprimere selvatichezza e dolcezza, respirare a pieni polmoni. Sto dicendo che da quando te ne sei andato ho imparato molte cose, ho scoperto piccole verità, ne ho scartate altre, ho capito che bisogna accontentarsi di questo. Quello che so, che riconosco come immutabile, è frutto di intuizioni e non di pensieri: questi ultimi hanno il limite oggettivo di essere contenuti all’interno delle regole del gioco, dei conformismi o, al contrario, da moti di ribellione a questi. Ma, appunto, gli appartengono. La conoscenza scientifica sta dimostrando che più si approfondisce il sapere, più questo è relativo e instabile, fragile, tenuto in piedi fino alla successiva scoperta, che lo abbatterà. Sto dicendo che ho compreso a fondo che si deve cominciare da noi stessi per rivoluzionare lo status quo. Sto dicendo che solo da poco tempo ho accettato di averti perso per sempre e che devo continuare a vivere perché ho finalmente la voglia e la forza per farlo. Addio Carlo, ti ricorderò per sempre.
Verso casa
Percorrendo la strada verso casa dei miei genitori guardo a caso la strada. Rivolgo lo sguardo ai masegni, alle rive, alle case, ai canali. È un’osservazione distratta, a cui i pensieri non fanno caso, continuando a fluire inarrestabili. A volte incrociano un ricordo, pescandolo dall’immensità dell’inconscio, o da chissà dove. Se rimango anche un solo secondo in contatto con quello che sento, mi spavento e scappo verso altri pensieri inoffensivi. Trovo conforto nell’estenuante gioco della mente, che di solito mi stanca fino alla spossatezza. Dovrei preoccuparmene, penso. Dovrei. Ma non posso. Potrei aprire il portoncino di casa con le chiavi, ma avviso sempre col camlo. Regolarmente mio padre mi apre, benché ogni volta gli dica che i tre suoni brevi in sequenza, sono il mio segno distintivo: ma fanno parte delle consuetudini famigliari, quelle che niente e nessuno modifica, mai. Non vorrei disturbarlo, visto che è già occupato ventiquattro ore al giorno con mia madre, con la casa, con i farmaci, con le normali faccende che sono pane quotidiano per molti, ma un incubo per un uomo vecchio stampo, che ha sempre lavorato fuori casa, e che è vissuto in un’epoca in cui l’uomo impersonava il marito, e la donna la moglie, con ruoli precisi, distinti, rigidi. Ho sempre l’impressione che qualunque azione aggiuntiva, possa comprometterne la stabilità, fino a rompere l’equilibrio. Ma ci si adatta a tutto nella vita, soprattutto alle abitudini.
La casa dei miei è un piccolo appartamento al primo piano di una palazzina di tre, più soffitta: un tempo apparteneva tutto alla mia famiglia; al secondo ci abitava mio fratello, al terzo mia nonna. Prima dei miei ci abitava una zia, e prima di mio fratello uno zio. Nei miei pensieri, avrei voluto trasferirmici un giorno; ma i pensieri sono effimeri aggi che nascono da profondità ignote, e poi svaniscono per evaporazione. Tranne quando diventano fissi, e si trasformano in ossessioni, che tormentano e prendono possesso di tutto, fino alla dominazione tirannica: ma per fortuna non è il mio caso, che coi pensieri ci gioco, trasformandoli in parole scritte. ando per il campo col pozzo attorno al quale da bimbo correvo in bicicletta, inizio a provare una stretta al cuore e un brontolio alla pancia. Il corpo si esprime col suo linguaggio viscerale, penso. E credo che mi stia dicendo che non si può che stare così, quando si è al punto nodale. Questi giorni sono davvero brutti, e non lo sono mai abbastanza; avevo calcolato male, pensavo che sarei stato più male, che sarei dovuto svenire pur di non vedere, con gli occhi rossi, ciò che vedo quasi ogni giorno. Assistere al consumo di un’esistenza fondamentale, dovrebbe manifestarsi in modo più letterario, più cocente, più e di più di qualsiasi altra cosa si riesca a immaginare. E invece è tutto così ordinario, così banale, che il dispiacere non può che aumentare, proprio in funzione del paradosso per cui l’insopportabilità si manifesta con tanta merdosa abitudine. Forse è il conto alla rovescia, che ad ogni numero scalato, avvicina gradualmente al punto zero, al niente, alla morte. Di fatto, mentre suono il camlo con le chiavi in mano, mentre osservo per l’ultima volta il pozzo sperando di trovarvi ricordi consolatori, mentre apro la porta lentamente, per contrastare la fretta di arrivare, che coinciderà col bisogno impellente di scappare, mi dico che niente è mai come ci siamo immaginati dovesse essere, e che per scriverne, bisogna accettare di guardare quello che è, per quello che è, senza fisime né allegorie, o enfasi, o imbrogli. I gradini che mi separano dalla porta sono pochi, soltanto una normale rampa di scale; e oltre la soglia, l’anormalità avrà la sua scena mortifera e asettica, su cui potrà esibirsi in tutta la sua cruda sostanza.
Salgo i gradini lentamente, come se il tempo potesse offrirmi una tregua, un breve ristoro, una vaga distrazione; ma non è così, e lo so bene. Mio padre mi aspetta sulla soglia, come sempre. Ci scambiamo un saluto e ci guardiamo negli occhi, con lo sguardo che comunica quello che le parole non possono dire, per un taciuto senso del pudore. Ci sono anche mio fratello e mia madre, nella stanza che funge da astanteria e soggiorno. Ci salutiamo con un gesto della mano, mentre vado verso mia madre, che saluto con un timido bacio sulla guancia. Lei ha gli occhi chiusi, ma li apre, rivelando la presenza del dolore e della morfina, che agiscono assieme nell’organismo e nella coscienza, rendendola morbida e anestetizzata, seppur inaspettatamente vigile. Mi dice ciao, con una voce che fatico a riconoscerle, e che esce filtrata dalla guerra interna al suo corpo: un coacervo di cellule e molecole che battagliano furiose e silenziose. La stanza è organizzata al bisogno. Un tavolo diventato multiuso, dove mio padre mangia, legge, fa i cruciverba della settimana enigmistica, appoggia telecomandi, telefono, farmaci, pane, frutta, e una notevole quantità di altri oggetti utili ad affrontare il tempo da seduti. E poi. La libreria con lo stereo. Le sedie dove ci accomodiamo. La poltrona con appoggia-piedi dove mia madre a gran parte della giornata. E c’è anche la televisione, sempre accesa, che col suo brusio di sottofondo sostiene l’insostenibile peso del silenzio. Mio padre, mio fratello ed io ci guardiamo spesso, alternando sguardi destinati alla tivù, ad altri rivolti alle finestre, alle pareti o al pavimento.
E i più frequenti verso mia madre, la mia genitrice, colei che mi ha costruito giorno dopo giorno dentro sé, quando ancora non ero che un divenire, un futuro incistato nella carne di una giovane donna. Cercando conforto nella delicatezza, proviamo a verbalizzare parole che abbiano un peso specifico inconsistente, in quanto coscienti che ogni pensiero galleggia nel presente di quella stanza, dove il futuro sembra escluso. Appena si dice qualcosa che la riguarda, o che sembra alludere a lei, pur nell’apparente sopore, interloquisce come chi percepisce in forma diretta o indiretta, ogni lontana allusione. Assistere all’eloquio di una persona apparentemente dormiente, guizzare puntuale, scaturisce in noi, apparentemente vigili, una sorta di stupore inesorabile. Colpisce diretta quell’inaspettata lucidità, e lascia una traccia che impiega un po’ di tempo a svanire dall’aria. La televisione produce inutilità, aderendo pedissequa al suo compito di agente distraente. Ci appoggiamo a quella potente vuotezza di senso, perché l’impossibilità di trovarne qualcuno, di senso, di giustezza, di adeguatezza, ci paralizza e costringe a esserne sgomenti testimoni. Non è giusto, penso, affrontare la propria impotenza senza esserne minimamente preparati. Ma so di pensare l’ovvio, e penso che la vita costringe continuamente a convivere con le proprie imperfezioni e limiti. Il mio affetto è paralizzato, soffocato, interdetto; non riesco a convivere lucidamente coi miei sentimenti: sarebbe una strage, un massacro, un suicidio. Devo abituarmi alla rassegnazione, esercizio che non è mai stato il mio forte. Le sue gambe sono uno spettacolo inconsueto e straziante. Sono avvolte da una sorta di pellicola trasparente che va cambiata spesso, in
quanto nella parte bassa, dal ginocchio in giù, continua a secernere un liquido trasparente che parrebbe sudore, o acqua. Guardandola ho la netta percezione mnemonica di quando mi ospitava nel suo ventre rotondo, di quando galleggiavo. Quel liquido mi ipnotizza: liquido amniotico di ritorno. Vorrei ritrovare quella pace acquosa, invece del tormento solido che mi assilla. All’improvviso un’immagine incredibile: la tivù interrompe la scemenza che stava trasmettendo, per mostrare le immagini di un aereo che si infila in un grattacielo. Chiedo a mio padre di alzare un poco il volume. Sono così stanco, così confuso e insieme lucido, così nascosto dietro ai meccanismi di difesa che mi riparano dalle percezioni sensoriali, che niente può toccarmi. Eppure quelle immagini mi si aggrappano addosso, mi scuotono: è proprio così, è New York, e un aereo di linea si è conficcato in una delle torri gemelle. La stupefazione è pari a una scossa: sembriamo tutti riemergere dal torpore autoindotto del preludio al lutto. Mia madre con gli occhi sempre chiusi, chiede di spiegarle cosa sta succedendo. Glielo diciamo, ma forse non può credere alle nostre parole, e infatti apre appena gli occhi per vedere coi suoi, la materializzazione dell’impossibile. La concezione del dolore è spesso compromessa dalle immagini che ne abbiamo introiettato, le quali derivano da letture, da visioni di film, da racconti orali che ne enfatizzano la natura e la potenza. Bisognerebbe invece distinguerne le diverse gradazioni, le sue varie manifestazioni. Mia madre si era accorta di non stare bene perché aveva un dolore sordo, nascosto da qualche parte, che più che sfogarsi in modo devastante, esisteva e si faceva notare con la sua onnipresenza.
Fatti esami, scoperte cellule tumorali: incontro diretto con l’inconsistenza del futuro. Eppure il dolore, quel genere di dolore - come se esigesse un genere -, quasi paralizza. Ferma la progettualità riducendola a capriccio. Sbaraglia la mistica del momento presente trasformandola in condanna subitanea. Vorrei avvicinarmi a lei, toccarla, dare consistenza e precedenza al tatto, ma non riesco. Guardo quelle gambe che continuano a spurgare liquido, e penso che deve trattarsi di energia che abbandona il corpo, in quanto ormai inutile. La distanza andrebbe ridotta e trasformata in occasione di vicinanza, prima che diventi rimpianto. Dovrei non solo ascoltarmi, cosa che riesco a fare a tratti, ma anche ubbidire a quei bisogni di contatto, a quella tenerezza che infonde imbarazzo, a quella debolezza che comunica perentoria che ci si deve abbandonare a ciò che si sente, senza indugi. Ma non lo faccio. Spesso nella vita non ho fatto ciò che avrei voluto e dovuto, e quasi sempre ho fatto quello che ho potuto, potendo purtroppo troppo poco. L’attenzione viene attratta verso lo schermo della tivù: il fumo esce dal grattacielo e tutti i canali trasmettono la medesima scena; qui e nel mondo, perché New York è la città mondiale per eccellenza, e perché non si sa, non si capisce, non ci si raccapezza: la sorpresa però non impedisce, al massimo rallenta, la sensazione di tragedia. Sento una sorta di sollievo per quello che provo, e me ne vergogno: la condivisione in mondovisione della precarietà dell’esistenza. L’inevitabile deflagrazione del dolore intimo e pubblico e condiviso, eppure non
per questo sopito: al massimo distratto da quello altrui. All’improvviso mio padre si alza dalla sedia, si veste, dice di dover uscire per andare al supermercato. Non mancano tante cose a dire il vero, dice. Noi annuiamo: quello che manca là dentro è la distrazione, l’aria pura, la luce del sole, il profumo di settembre, il bisogno di vedere altre persone, la voglia di scambiare due chiacchiere leggere. Lui è presente giorno e notte, da mesi ormai. Ha solo bisogno di una parentesi di assenza. Appena chiusa la porta di sotto, in perfetta coincidenza temporale, guardando le immagini delle torri, arriva un altro aereo che si schianta contro l’altra torre. L’impatto accade nel momento esatto in cui si chiude il portoncino, come se fosse un doppiaggio surreale. Stavolta l’impatto è molto più basso rispetto all’altro. Il fumo nero che continua a fuoriuscire dalla prima torre viene investito da una fiammata; il commentatore è impazzito, non sa cosa dire e ciancia parole come fosse una sorta di lallazione, di balbettio: è la conferma che non ci sono parole che possano descrivere l’impossibile. Io e mio fratello ci guardiamo sgomenti, impietriti. Ci voltiamo in simultanea verso mia madre che ha gli occhi aperti. Capiamo che ha visto anche lei tutta la scena. Li richiude subito, pronunciando con una voce accartocciata dalla gola secca, cinque parole che sembrano una sorta di autoprofezia: “È la fine della vita”. Lei è sempre stata fulminea, a volte annichilente: frasi pronunciate senza premure e censure. Quel che si pensa va detto, saranno gli altri a farne ciò che vogliono o possono. In questo caso quello che posso, confligge aspramente con quello che voglio.
Vorrei risolvere la questione, mi piacerebbe sconfiggere il male invisibile eppure così solido, attenuarne la potenza nefasta e distruttiva e trasformarla in energia che guarisce; ma quello che posso è solo accettare ciò che è, e quel che è, mi è tuttavia quasi insopportabile. Ritorna mio padre dalla eggiata mascherata dal bisogno della spesa frugale. Ha un’espressione riposata, o forse meno tirata del solito. Mentre svuota il sacchetto lo guardo, e mi viene in mente che quando l’ho visto entrare ho pensato a lui come ad uno speleologo, che dalla terra si cala nelle viscere del pianeta dove tutto è scuro, silenzioso, eterno e precario, senza appoggi sicuri. Gli raccontiamo del secondo aereo, e lui ci guarda con stupore e stanchezza, rispondendoci che secondo lui il caso non esiste, e qualsiasi fenomeno ha una spiegazione, che però spesso rimane inaccessibile. Questa volta, aggiunge, però, non c’è nessun mistero: si tratta di qualcosa di grosso, di importante, di un evento che erà alla storia, e che ci ricorderà per sempre dov’eravamo e cosa facevamo, nel momento in cui tutto ciò è accaduto: “In una matrioska di dolore privato e diffuso”, dice. Mette via la spesa e torna al suo posto, dopo aver dato un’occhiata a mia madre, in particolare alle gambe. Si siede sulla sua sedia, sposta per poi rimettere al loro posto gli oggetti sopra il tavolo, prendendo il telecomando, abbassando di una tacca il volume. Da una torre si vede una macchiolina nera che scende. È un uomo che si butta nel vuoto dal grattacielo in fiamme. Per un istante, brevissimo, ho colto il silenzio che galleggia nella stanza. Un silenzio pesante, gravoso; il prodromo del mutismo che riempie la solitudine, il dolore forzoso, il lutto. Dev’essere stata una condizione condivisa, poiché da subito, a partire da un colpo di tosse appena accennato, ricominciamo a riempirlo con le chiacchiere, con la televisione, col movimento involontario del corpo che rifiuta l’immobilità.
Mia madre apre appena gli occhi, ci guarda, e con un filo di voce pronuncia queste poche parole: “Vorrei potervi consolare, ma non riesco a farlo nemmeno con me. Mi manca l’energia”. Prima di chiudere gli occhi, accortasi che la stiamo guardando tutti, con un cenno del viso ci indica la tivù. La prima torre sta crollando. Una catastrofe di polvere, di detriti, di fumo, di debolezza, di odio, di disfatta. Sento che la mia gamba sinistra cedere, facendomi perdere l’equilibrio. Poi l’altra torre, stessa scena al rallentatore. L’altra gamba mi si piega. Le torri crollano e io cado a mia volta, in una simultaneità paradossale. Guardo le torri, poi mia madre, e sento un dolore abnorme che mi stringe la carne, che mi contorce gli organi interni, che mi squassa la testa. Guardo da terra quell’ammasso di polvere indescrivibile, che copre tutto, che nasconde ogni cosa, che sembra fuoriuscire dallo schermo ed entrare nelle case, nelle narici, nei polmoni fino a interrompere il respiro. Penso all’ecatombe, alla catastrofe, al numero di morti. Penso che mia madre sta lasciandomi e che tutte quelle morti, tutto quel dolore, tutta quell’oscena e pornografica rappresentazione della disperazione, sono niente rispetto a quel che sento, e che mi piega ancor più all’evidenza che la sofferenza è inevitabile, incontrollabile, onnipotente. E non è niente di quello che ho immaginato, che ho pensato, creduto, supposto, prefigurato; no, è molto peggio e molto meglio, è materica e spirituale, è preghiera e bestemmia, è fine e inizio, è tutto e nulla. Striscio verso la poltrona, prendo la sua mano, la carezzo con la guancia. Sento che mi sta lasciando e che non posso fare niente.
Capisco che così è, e così dev’essere, e provo finalmente una sorta di liberazione, di leggerezza, di soavità, di pace, di pienezza. Era l’11 settembre 2001. Ho letto e scritto molto da allora. Ho cercato di capire, di affondare nel mistero e nel senso. Ma l’unica lezione che ho imparato è che bisogna accettare tutto.
Il mio nonno è un supereroe (in tuta blu)
Definizione di salute dell'OMS (organizzazione mondiale di sanità): stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia",
Dal settimo piano di un palazzo di Campalto posso vedere la laguna e i suoi due estremi: la città vecchia dal ato glorioso, il porto turistico con quegli assurdi mastodonti bianchi, e la zona industriale, che un tempo fu modernità futuribile, e ora soltanto una mortificazione estetica. Gli estremi mi hanno sempre attratto, e ne riconosco l’evidenza in ciascuno di noi, benché sia tutt’altro che facile accettarne la presenza. Tutti noi conviviamo con la parte buona e quella cattiva, che spesso reprimiamo e nascondiamo in zone d’ombra.
… scusate… sento dei i… Mia figlia arriva, mi strattona un poco i pantaloni; dal basso dei suoi pochi anni, vuole uscire in bicicletta: io pedalo e lei sul seggiolino; io parlo e costruisco concreti mondi immaginari, e lei ascolta, perdendovisi. Vuole la favola che mi raccontava mio nonno. Scendiamo in garage, prendiamo la bici, usciamo. La laguna da una parte, in silenzio, e l’innocenza perduta per sempre, sin da quando il veleno delle fabbriche, portato dal vento, depositava una polvere biancastra, simile al talco. Lei mi guarda, braccia conserte, occhi severi, come a dire: allora, mi racconti la
favola della tuta blu e i guanti bianchi? Sì amore, hai ragione. Eccola…
Questa che ora racconterò, è una sorta di favola: quella che mi raccontava sempre mio nonno quando ero bambino, e che ora sentirete. Ho pensato che, adesso che sono adulto, la cosa migliore sia usare le parole, ma anche le immagini dei luoghi in cui è ambientata. Vi ci accompagnerò in bicicletta: la bicicletta rossa di mio nonno. Dovreste fare un ultimo sforzo: immaginare me bambino, e lui, mentre siamo ai margini della laguna e guardiamo l’acqua e i pesci. I pesci non parlano, lo sappiamo tutti. Eppure a volte, mentre lui parlava, pensavo che eravamo anche noi là con loro; e uno di loro iniziava a raccontare… Dunque…
C'era una volta una città piena di fabbriche che fumavano tanto. Facevano talmente tanto fumo che sembrava che andassero a fuoco.
Ecco, iniziava così la favola preferita di mio nonno. Dovete sapere che mio nonno era una specie di eroe, ma guai a chiamarlo così; si arrabbiava proprio: lui diceva di essere una persona semplice, che faceva il suo dovere fino in fondo, e che purtroppo, non essendocene tanti, che fanno così, lui sembrava esserlo. Ma appunto, non lo era.
Vi dico un segreto a bassa voce, che rimanga tra noi: per me, dentro di me, io lo vedevo con la sua tuta blu e i suoi guanti bianchi, che combatteva contro avversari potentissimi, apparentemente invincibili, che però non riuscivano mai a batterlo. Ma non gliel'ho mai detto. E non so se avrei dovuto.
Dunque… dicevo: c'era una volta una città piena di fabbriche che fumavano tanto. Facevano talmente tanto fumo che sembrava che andassero a fuoco. Dentro queste fabbriche ci lavoravano tante persone. C'erano attività diverse tra loro, che servivano a costruire molte cose. In alcune si trasformava il petrolio in carburante per far funzionare le automobili, le moto, gli autobus, i camion, eccetera. In altre si facevano altre cose, le più incredibili. Mio nonno lavorava in una che produceva CVM, che serviva a fare il PVC, il quale si usa per fare tantissimi oggetti di plastica. Ma voi lo sapete che dalla plastica si riesce a costruire di tutto? Ma proprio tutto tutto. Qualche esempio? Vi presento il biberon, il tubetto di colla vinavil, i dischi in vinile, il computer, l’ipod, il vecchio stereo, il divano in Moplen, le tapparelle, il linoleum, i piatti di plastica, i farmaci e le bottiglie d’acqua. E in fin dei conti nessuno pensa di rinunciare al computer, al biberon, di
comprare l’acqua con le bottiglie di vetro che pesano tanto, solo perché la produzione industriale è pericolosa. Eh no! La modernità ha le sue regole, i suoi costi, le sue seduzioni, i suoi riti, e nessuno sembra più farci caso. Adesso tutto corre, sempre, senza sapere dove va e perché, e senza pensare se questa corsa faccia bene o meno, se serva a qualcosa, se non sia inutile. Se fimo un esperimento e togliessimo tutto ciò che in quest'epoca è inutile, rimarrebbe quasi niente.
C’è però un’eccezione, diceva. La follia degli uomini a volte si trasforma in qualcosa di buono e di bello. E iniziava a fischiettare: poche note, distanti l’una dall’altra, semplici come la verità, leggere e profonde; lo faceva chiudendo gli occhi, come si perdesse per un istante in un luogo magico, dove tutto è armonioso, liscio, pulito; il suo volto si rilassava e per pochi istanti la felicità sembrava abbracciarlo. Succedeva solo quando fischiettava i brani di Satie, un musicista se ormai morto, amico di un poeta, un certo Cocteau. I dischi di vinile, diceva, a volte rendono la vita spensierata e musicale.
Ma dicevo della plastica. Il problema è che la plastica inquina molto, ma molto molto. C'è un'isola nell'oceano pacifico, grandissima, formata da rifiuti di plastica. L’acqua è l’elemento originale, da cui tutti proveniamo, e pensare che una parte di noi potrebbe essere plasticosa è davvero brutto.
Ecco, mio nonno lavorava in questa fabbrica.
Bisogna dire che lui e i suoi colleghi erano molto contenti di poterci lavorare. A quei tempi un posto di lavoro in fabbrica significava poter vivere la propria vita, abitare in una casa dignitosa, crescere i figli, comprarsi la televisione, fare i regali ai loro nipoti. E così, con le loro tute blu, andavano in queste fabbriche immense a lavorare, felici di sentirsi utili al sistema produttivo della vita, in cui c’è posto per tutti, dove si hanno diritti e doveri, e bisogna rispettarsi l’un l’altro.
Pensate che aveva un collega che era addirittura un poeta: si chiamava Ferruccio. Andava in fabbrica e scriveva le poesie, le leggeva a tutti i suoi colleghi, che erano contenti di farsi accompagnare in mondi immaginari costruiti dalle parole. Che poi, aggiungeva sempre mio nonno, la poesia è una specie di mezzo di trasporto che ti conduce alla verità: e questa è un po’ difficile da capire, ma ha un buon sapore.
Nel suo lavoro a volte bisognava pulire le autoclavi, che erano degli enormi contenitori dove venivano lavorate le sostanze chimiche. Ricordava che appena entrati, appesi letteralmente a delle corde, lui e i suoi compagni, erano stati colpiti dalle esalazioni come se invece che gas, fossero sostanze solide che li prendevano a schiaffi, da quanto forti erano. Colpivano gli occhi, il naso, la bocca, la gola, i polmoni. Ti penetravano come fossero dei vermi che strisciavano dentro il tuo corpo; vermi che ferivano, che facevano male non solo al corpo, ma anche alla mente, all'orgoglio, annientando l'onore, la volontà, il sentirsi esseri umani. Avrebbero voluto scappare, uscirsene, ma se uno di loro lo avesse fatto, avrebbe messo in pericolo l'equilibrio e la vita dei compagni di lavoro. Quando tutto era finito, rimanevano solo tracce di polvere bianca, apparentemente innocua, simile a talco, o zucchero a velo. E lacrime, che uscivano dagli occhi di tutti i presenti. Ma non erano lacrime di pianto: le lacrime erano finite, ingoiate dal mostro che ormai li possedeva tutti, che abitava la loro carne, che scuoteva i loro nervi, che beveva il loro sangue.
Che abitava e ammalava i loro corpi.
E così, a un certo punto, il numero di tute blu, cominciava a diminuire. Non se ne accorgeva quasi nessuno, perché erano in tantissimi là dentro, all’inizio; ma mio nonno aveva iniziato a farci caso. Gli sembrava strano che tutti avessero male: lo stesso male per tutti. E così non tornavano più a lavorare, e l’allegria in fabbrica diminuiva. Un giorno era tornato in spogliatoio da solo, e gli pareva che il silenzio fosse veramente pesante. Aveva aperto il suo armadietto e aveva trovato una bellissima tuta blu tutta nuova, e dei guanti bianchi immacolati. Al momento non capiva chi poteva averli messi; non sapendo bene cosa fare, l’aveva indossata, si era messo i guanti, per vedere se la misura era giusta. Appena messa, si sera sentito subito leggero. E sulle mani, che da un po’ di tempo erano sempre fredde, sentiva un bel tepore. Era una sensazione strana, un poco magica. Senza farci caso, aveva pensato al sogno che aveva fatto quella notte: volava sopra le fabbriche! Ebbene, proprio in quel momento, mentre stava pensando al sogno, gli capitò di alzarsi da terra, di dirigersi verso una finestra aperta, e di volare sopra la fabbrica, e poi ancor più in alto, fino ad arrivare alle nuvole. Quasi non ci credeva, eppure era vero.
Lui non amava i furbi, diceva che la furbizia viene quasi sempre usata per prevalere sugli altri.
E si sentiva crescere dentro la sensazione che ci fossero tante persone furbe che nascondevano la verità. Persone a cui importava solo la produzione della fabbrica; persone che credevano che se anche un operaio sta male, ce ne sono tanti altri; persone che non badavano tanto ai fumi che facevano respirare alla città; persone che dicevano che il lavoro porta benessere per tutti, e quei pochi che non ne godevano perché poi stavano male, erano in fin dei conti pochi. Mio nonno, invece, pensava che la vita è la cosa più importante che ciascuno ha, e che ha una data di scadenza naturale, e che nessuno ha il diritto di metterci le mani e modificarla a causa dei propri interessi.
E a un certo punto ha deciso di alzare la voce per esprimere le sue idee. Io pensavo che alzasse la voce perché la fabbrica faceva un gran chiasso, ma non era così: “ alzare la voce ha più di un significato: quello che intendi tu, o anche quello di interrompere un silenzio che ai furbi di cui ti parlavo, conviene mantenere”, mi diceva. Così quando finiva il turno di lavoro, si metteva gli abiti normali perché nessuno lo potesse riconoscere, e ha iniziato a fare una super inchiesta da vero investigatore. Non so se usava la lente di ingrandimento come mostrano nei cartoni, ma so che la sua inchiesta è stata molto importante, e ha cambiato il modo di intendere il lavoro, la salute, la sicurezza. La sua idea era semplice semplice: pensava che il lavoro fosse importante, ma che anche la salute lo era, e che ci doveva pur essere un sistema per far sì che questo potesse conciliarsi. Insomma, diceva: se il lavoro serve a produrre dei beni per tutti, perché qualcuno di questi deve rimetterci la salute? Perché non si studia un modo - CHE C’È, CAVOLO! - per far sì che si facciano le cose per bene? Diceva poi, sconsolato, che la risposta era semplice e complicata insieme.
Come la natura intima degli esseri umani.
Una volta gli ho detto che la notte prima avevo fatto un sogno. Lui mi aveva chiesto se mi faceva piacere raccontarglielo. Io gli ho subito risposto di sì! Bene, allora: fallo, raccontamelo, mi aveva detto. “... Stavo camminando da solo in mezzo a costruzioni enormi, con degli altissimi camini. Attorno a me uno strano silenzio, talmente forte, da farmi sentire i rumori dei i che facevo, come se rimbalzassero nei muri esterni degli edifici. Al tempo stesso sapevo che intorno a me tutto funzionava; appena oltre il silenzio, il rumore dei i, sapevo che c'erano persone, che però non riuscivo a vedere. Iniziavo ad avere paura, anche se non sapevo di cosa o di chi, e pensavo " sarebbe bello che ci fosse qui con me nonno”. E in quel momento, come se avessi sentito le parole che stavo pensando, arrivavi tu. Scendevi dal cielo con la tua tuta blu, i tuoi guanti bianchi come la neve, e avevi anche un mantello dello stesso colore. Mi chiedevi se avevo voglia di fare un giro con te, che mi avresti fatto vedere tutto quello che volevo. Senza parlare, ma solo pensandolo, rispondevo di sì! Tu allora mi prendevi in braccio, e insieme volavamo; all'inizio alto alto, così potevo vedere la vastità della zona, e poi giù in picchiata verso le costruzioni, che tra le tue braccia, ora mi sembravano meno imponenti. Entravamo dentro ciascuna di queste e stavamo vicini al soffitto, mentre tutti ci salutavano sorridendo e facendo ciao con la mano. Mi sentivo sicuro e felice e pensavo che quello fosse il momento più bello di tutta la mia vita, e che avrei voluto raccontarlo ai miei genitori, agli amici, alle maestre. Gli avrei detto che avevo volato con te, e che tutti, quando avamo, erano felici nello stesso modo in cui lo eravamo noi”. Al risveglio ho pensato che, più per il volo, ero felice perché ero stato insieme a te.
Lui aveva distolto un momento lo sguardo, aveva raccolto i pensieri, e aveva detto che la felicità, così come la tristezza, sono stati d'animo che vengono e vanno, che durano poco tempo, e che l'importante era saperli accogliere dentro sé, sapendo appunto che durano poco. I sentimenti invece, come l'amore, sono meno frequenti ma più lunghi e importanti. Anch'io sono felice quando sto con te, aggiungeva; e se lo sono, è appunto perché ti voglio tanto bene.
Non so se questa è una favola. Nelle favole ci sono i buoni, i cattivi, il bene, il male. Nelle favole i buoni e il bene stanno da una parte, i cattivi e il male dall'altra. Ma mio nonno diceva che nel mondo reale, è tutto più confuso, mischiato. Ognuno ha in sé il bene e il male, e può scegliere, anche se non sempre è così semplice. Ora che sono cresciuto, ho capito cosa voleva dire.
In breve, ecco cos'è successo. Mio nonno si toglie la tuta blu e i guanti bianchi, si veste normale, e studia. Vuole capire perché molti suoi amici si sono ammalati della stessa malattia. E comincia a capire che proprio nella fabbrica dove lavora, c'è qualcosa che non va. Loro sono continuamente a contatto con sostanze velenose, le quali, con gli anni, possono portare alla morte. Comincia a parlarne, a confrontarsi, ma quasi nessuno gli dà ragione: gli dicono che è pazzo, che si sta mettendo nei guai, che non ci sono prove, che c'è bisogno di lavoro, che se insiste, si rovinerà la vita.
Ma lui pensava che una vita ben vissuta, è una vita in cui il rimpianto ha un piccolo spazio, in cui quello che conviene non è sempre quello che si fa; in cui sentire quello che si fa è giusto, anche se appunto poco conveniente, ma fa vivere bene con se stessi. E infatti ha continuato a studiare, da solo; a informarsi, a tentare di capire. Fino a quando ha iniziato a comprendere.
Mi raccontava che di notte sognava che le fabbriche si animavano, che sputavano fumo nero, che le ciminiere diventavano come braccia e lo attaccavano, ma lui riusciva sempre a scappare perché indossava la sua tuta blu e i guanti bianchi, con cui volava via, giusto in tempo per svegliarsi dall’incubo. Diceva che gli incubi e i sogni sono materiale nostro, che lasciamo là a riposare, o che nascondiamo, o che dimentichiamo. Di giorno mentre noi siamo svegli, loro dormono; di notte quando noi dormiamo, loro si svegliano e ci vengono a trovare. Dopo, mi diceva, si sentiva ancora più forte, determinato, convinto, di fare quello che era giusto fare. Come si fa a sapere che è giusto fare qualcosa?, gli avevo chiesto. Come al solito, non rispondeva mai subito: ci doveva pensare... È giusto fare qualcosa quando senti che non la fai perché è comoda, perché ti conviene, o perché la fanno tutti; no, una cosa è giusta quando nasce dentro di te e non ti abbandona mai; perché sai che non è solo per te, ma che è toccata a te, e fa parte di quelle cose che fanno bene a tutti.
Un giorno, quando nonostante i vestiti con cui si travestiva da persona normale, fu scoperto, venne chiamato negli uffici del direttore. Diceva di essere molto in difficoltà, di sentirsi piccolo, timido, indifeso in quei lunghi corridoi, in quegli uffici grandi come la sua casa.
Mi diceva però che aveva un segreto: aveva nascosto nel suo borsello, la tuta blu e i guanti bianchi; lo faceva sentire al sicuro: in caso di bisogno li avrebbe usati per volare via. Il direttore con tono sicuro e pacato, gli aveva detto che l’azienda gli avrebbe risparmiato qualche anno di lavoro, regalandogli la pensione prima del tempo, e così avrebbe potuto dedicarsi ai figli, alla bicicletta, alla lettura, che erano le sue ioni. Aveva concluso dicendo che era sicuro che lui sarebbe stato grato ad un’azienda così generosa.
Quando gli ho chiesto cosa significava, mi aveva risposto che probabilmente avevano scoperto che lui si era messo a indagare, e che speravano che, offrendogli dei privilegi, avrebbe smesso. Ma lui non poteva smettere, anche perché se aveva trovato la tuta blu e i guanti bianchi che facevano volare, voleva dire che era stato scelto dal destino per portare a termine quella missione. Allora gli ho chiesto cos’era il destino. Ci aveva pensato, e aveva risposto che era la vita che ci tocca, e che dovremmo tutti accettare. E poi ha aggiunto che accettare non significa subire, anzi; significa piuttosto che proviamo una forma di gratitudine nei confronti della nostra esistenza, qualunque cosa ci succeda durante il percorso di vita.
E da quel momento la sua vita la ava in mezzo ai documenti. Non trascurava mai la nonna, e nemmeno suo figlio e sua figlia, ma sapeva anche che certe missioni segrete richiedono dei sacrifici. Certe volte non ne poteva più e prendeva la bici e se ne andava a fare tanti chilometri in campagna.
Diceva che l'aria era piena di odori, a volte anche forti, aspri, ma che avevano sempre una qualità naturale; non come quelli artificiali della zona industriale. Oppure certe notti, facendo piano piano, scendeva dal letto, prendeva la tuta e i guanti, saliva sul tetto di casa, e volava in alto, sopra la città. Dall’alto tutto ha una prospettiva diversa: questo vale per le case, le auto, le persone, che sembrano formiche indaffarate. E poi andava sempre là, sopra le fabbriche, e si sentiva avvolto dalla nostalgia. Poi tornava a casa, si rimetteva sotto le coperte, e finalmente riposava, sentendosi leggero.
Mettendo insieme tutti i documenti aveva scoperto fatti gravissimi. Le fabbriche oltre al lavoro e all’amicizia, potevano procurare malattie molto gravi. Immaginava queste malattie come un mostro, che però, essendo all’interno delle persone, non poteva essere combattuto. Lui pensava che il lavoro e gli amici fossero importanti per tutte le persone del mondo, ma ancor di più la vita e la salute. E allora aveva ato un brutto periodo, carico di pensieri pesanti, di dubbi, di incertezze, dilemmi. Si immaginava di parlare col direttore, coi padroni dell’azienda, col mostro che abitava i corpi degli operai. Avrebbe voluto fargli capire che sbagliavano, che c’erano sicuramente dei sistemi che potevano mettere d’accordo tutti: tutti tranne il mostro, forse.
In realtà lui sapeva cos’era giusto fare, ma temeva che nessuno l’avrebbe capito. Un giorno indossò la tuta blu, i guanti bianchi, prese il telefono, chiamò un
magistrato e gli disse che doveva parlargli. lo andò a prendere, lo portò in volo sopra le fabbriche e poi entrò in casa e si chiuse con lui dentro la sua stanza. Stettero insieme per ore. Da fuori si sentivano appena le voci, la carta dei fogli dei documenti che leggevano. Poi uscirono, si strinsero le mani, e salutarono tutti. Volarono di nuovo sopra le fabbriche prima di tornare nell’ufficio del magistrato.
Il resto è diventato storia. Ci furono dei processi. Una prima assoluzione, che fece gridare di rabbia e piangere tante persone. Poi una condanna, ma senza condannati. La giustizia ha vinto, senza trionfare.
Mio nonno ha preso la tuta blu, i guanti bianchi li ha sotterrati in un posto segreto (perché aveva concluso la sua missione, diceva), e aveva ricominciato ad andare in bicicletta.
Un giorno un camion lo ha urtato. È caduto, e non si è più risvegliato.
C'era una volta una città piena di fabbriche che fumavano tanto.
Facevano talmente tanto fumo che sembrava che andassero a fuoco. Col are del tempo però fumavano sempre meno, gli operai erano sempre meno. E di notte, guardando il cielo con grande attenzione, si può vedere un puntino blu che saluta con la mano. Poi il puntino se ne va e torna ad abitare vicino alle stelle, dove si sta davvero bene: eh già, là non ci sono fabbriche. E nemmeno mostri.
questa favoletta è ispirata a Gabriele Bortolozzo, morto il 12.09.1995. Grazie a lui, dopo varie traversie giudiziarie, il primo grado risale al 2001, si è iniziato a discutere del rapporto tra salute e lavoro.
Capitolo 2
(anni 2000)
Carnevale
Mercoledì. Il carnevale è finito ieri. ... Ieri la follia conclamata, oggi quella ufficiosa. Per terra tracce di festa: coriandoli, stelle filanti, bottiglie rotte, vomito. Nell’aria si percepisce la piega di stanchezza, dopo una notte forzatamente festosa; divertirsi non ha più un significato, è solo un agito, un ordine perentorio, un modo di distrarsi da sé. Venezia è morta da tanto, e vive solo grazie alla decadente bellezza cui non si può non perdonare tutto. Compresa la volontà politica di un’ignobile svendita, un tot a metro quadro. Suoi unici abitanti, vecchi piegati dall’umidità, ricchi mercenari, ignoranti inebetiti dagli spritz, universitari protempore, poca gioventù isolata: tutti apparentemente vivi, ma mai vitali. La strada straripa di donne e uomini, turisti, sviliti dalla sagacia immorale di commercianti di souvenir della nostalgia. Maschere, vetri, scarpe, bottiglierie, pizzerie, occhialerie, alberghi, fast-food, cucina tradizionale, cinese, araba. Cammino zigzagando tra trolley grandi come tir e zaini misura camper. La festa è finita senza mai iniziare, ma nessuno se ne è accorto. Tutti accettano l’illusione se possono così evitare la delusione. Rido e canto canzoni che fingo di ascoltare da cuffiette che non emettono suono, e sento parlare idiomi incomprensibili dai toni stanchi, impastati e notturni.
Cinesi avanzano a grumi: si distinguono per il loro rimanere compatti, e per i vestiti di chi latita dalla fantasia. Giapponesi a piccoli gruppi, da due a cinque, camminano con borsette, o, pettinature e vestiti da sfilata. Si scattano foto con espressioni standard: sembrano manga che lanciano urletti isterici. Non guardano mai negli occhi. Americani si distinguono tra obesi e muscolosi. Arrotondano le parole con dei versi che sembrano scivolare sulla loro stessa parodia. Hanno bei denti, sguardi felici di chi antepone l’ottimismo semplice, alla pedante complessità. Sono evidentemente quel che sembrano. Bengalesi pettinati con righe in parte iperboliche lasciano scie speziate. Inglesi pallidi portano con sé una nobiltà decadente, umiliata da giovani che non nascondono una disperazione penetrata fin dentro le viscere. Sanno di pioggia, cielo grigio, case marrone a perdita d’occhio, socialità costrette dentro uffici o pub, e birra a gonfiare il ventre. Tedeschi a misura di famiglia che non si vergognano di niente. Purché sia efficiente e affidabile. si che sembrano italiani con l’erre moscia, con la stronzaggine intrinseca di chi eggia in centro. Spagnoli che sembrano italiani che se ne fregano di non essere sempre e comunque vestiti alla moda, e parlano ad alta voce e ridono sguaiati. Olandesi biondi e impermeabili alle emozioni che leggono guide turistiche dalle loro altezze siderali che compensano il fatto che vengono dai paesi bassi. Coreani che sorridono, e che sono in modo netto la prossima modernità. Ai lati, africani robusti vendono borse finte. Parlano gutturale, ridono sempre tra loro e uccidono afflati di simpatia pur di vendere qualcosa. Altri vendono altro. Zingari rumeni mendicano comione ai sensi di colpa.
Veneziani vendono ritratti stereotipati di angoli cittadini inesistenti, commissionati in Cina e Vietnam; oppure si lamentano della marea umana che non gli permette di vivere; oppure trascinano carrelli stracarichi di merci che questi stessi ominidi hanno consumato, e consumeranno, facendosi largo a suon di urla e improperi dialettali. Come tutto e tutti a Venezia, hanno ragione e torto insieme, confusi, smarriti, perduti tra altezze siderali e profondi abissi. Io sono il mondo, anche. Il primo, il secondo, il terzo e finanche il quarto. Contengo tutti i mondi, in scala gerarchica, e ordine misto. Mondi che coesistono detestandosi, scaricando sull’amministratore - il mio ridicolo ego - l’onere di tante contraddizioni. Tutti hanno le stesse scarpe da ginnastica. Alcuni, scarponi neri. Altri imitazioni di scarpe. Altri i sandali. Certi indossano scarpe italiane. Tutti hanno scarpe provenienti da altri paesi, prodotte in fabbriche fatiscenti, assemblate da bambini schiavi che non visiteranno mai Venezia. Maglie e camicie sudate. Piumini, pellicce, cappotti. Giacche, giubbotti, soprabiti. Grandi marche, grandi prese per il culo, firme vere e fasulle. Lusso, lussuria, consumo, depressione, panico, arte, bellezza, metafisica, internet. Non ce l’ho con nessuno di loro come persone; non li sopporto in quanto massa. M’hanno rotto i coglioni!, penso.
Mi posiziono a un lato della strada. Appoggio la borsa sui masegni. Tolgo il giubbotto che porto sopra il vestito, rimanendo in completo gessato. Fingendo di ascoltare musica, mi metto a ballare breack-dance e poi faccio il robotino che si muove a scatti. Poi fingo di raccontarmi una barzelletta e rido a voce altissima, il tutto col silenzio del mimo. Poi mi sposto in un campo attiguo, prendo posizione e comincio a roteare su me stesso; prima piano poi sempre più veloce sino a non distinguere più l’immobilità e l’imponenza dei palazzi che mi circondano. Roteo danzando come i dervisci. Dopo qualche minuto mi fermo. La testa gira, mi lascio cadere morbidamente a terra. Mi si avvicina una bella e giovane bionda vestita con una gonna lunga e una camicia leggera. Mi appoggia le labbra sulle labbra, leggera, senza impegno. Mi guarda con gli occhi azzurri e chiari e ingenui di chi ha non più di venticinque anni. Mi sussurra ad un orecchio: “I understand you”, e se ne va, dopo avermi leccato l’orecchio destro. Mi rialzo. Mi spazzolo i vestiti senza polvere. Vedo un paio di decine di occhi che mi fissano incuriositi. Sulla borsa appoggiata a terra, qualche € di caritatevole predisposizione all’arte che non ho manifestato. La prendo, metto in tasca i soldi e vado salutando con un gesto della mano che
accompagna in modo teatrale un inchino. Squilla il telefonino. “Sì, pronto” dico. “Dottor Persepolis, sono Comin. Sto male, ho bisogno di vederla. La prego, posso venire oggi?” “Comin, sono ancora per strada. Appena arrivo in studio controllo con Clara gli appuntamenti, e se ho un buco la ricevo. Se non è oggi, sarà per domani. Ha preso gli ansiolitici che le avevo prescritto? Sì, bene. Ci sentiamo più tardi”. “Clara, sono io, sto arrivando. Se qualcuno telefona, prenda appunti che poi sistemiamo gli impegni. Sì, a tra poco”. Butto fuori l'aria dai polmoni e mi avvio incontro al giorno.
Cronache dai quotidiani
Brescia 1 Il lunedì mattina era piovoso. Strade e cielo, stesso grigio, pensavi. Andavi in bagno, ti specchiavi, pisciavi, non pensavi. Poi in cucina, preparavi la moka da due, una fetta di pane fatto in casa con la macchina apposita vinta coi punti del supermercato, e marmellata di fragola della suocera. Svegliavi tua moglie alle sei e un quarto, il caffè e il pane pronti anche per lei sul tavolo della cucina. Lei faceva colazione, tu ascoltavi la radio in bagno, mentre ti facevi la barba. Poi uscivi tu e entrava lei. Alle sei e cinquantatré usciva da casa per recarsi al lavoro, autobus delle sei e cinquantanove, come ogni santo giorno. Oggi però non c’era santità nell’aria.
Sant’Agostino, FE 1 Il turno del sabato notte, pensava, era pesante. Era pur vero che alzava lo stipendio, e che i suoi sabati avevano smesso di essere euforia, e quindi rimpianto, ma sarebbe comunque stato meglio a casa sua. Doveva andare in pensione ma la nuova normativa di quella nuova ministra tecnica, così borghese e indecente, aveva allontanato la meta. Aveva girato tutti i concessionari di camper di Ferrara e Bologna.
Con il TFR se ne sarebbe comprato uno e avrebbe girato tutta l’Italia. Sarebbe tornato verso la sua adorata Napoli, come primo viaggio; poi avrebbe continuato, chilometro dopo chilometro. Sarebbe ato anche per Brindisi, dove la ragazzina era stata ammazzata davanti alla scuola. Aveva comprato una cartina geografica, segnato il tragitto, fatto i conti a mano dei chilometri, del costo dell’autostrada, o in alternativa delle statali, e ci stava dentro. Avrebbe rimandato di qualche anno, pazienza. A questo pensava a quasi fine turno, quando aveva sentito il primo rombo profondo, sordo, che sembrava provenire dalle viscere della terra. Contemporaneamente, la fonderia aveva tremato, come fosse stata investita da un brivido.
Brescia 2 Eravate riusciti a non parlarvi anche stamattina. Il dialogo con tua moglie consisteva ormai nei soli impegni da sbrigare: la spesa, i bambini, il lavoro, la tivù. Ti eri fatto un altro caffè e l’avevi bevuto guardando le estrazioni del Superenalotto al televideo. Questa volta avevi fatto 3. Ti eri vestito con i jeans, la camicia bianca, messo i mocassini, eri andato in camera dei bambini e ti eri fermato un momento. Dormivano sereni, l’aria odorava di tenerezza. Avevi un dubbio: chi avresti scelto per primo? Eri rimasto in piedi, appoggiato allo stipite della porta a guardare il respiro lento del sonno innocente, e per un attimo avevi dimenticato la stanchezza. Eri tornato in cucina, avevi messo la lettera che avevi preparato il giorno prima
sul tavolo, appoggiata a una tazza da colazione in modo che si potesse vedere appena entrati nella stanza: poche parole che parlavano di scuse, paura, tradimento, fine. Prima di tornare in camera dei bambini avevi verificato attraverso la finestra del bagno che nel cortile condominiale non ci fosse nessuno. Fuori la città iniziava a svegliarsi, a secernere la sua puzza, a invadere coi suoi rumori, a affannarsi inutilmente. Non c’era nessuno. Bene, era il momento. Andavi da Luca, due anni, che ti aveva guardato un attimo e poi aveva chiuso di nuovo gli occhi, fiducioso. Gli avevi fatto sshh con la bocca, come a dire che non era niente, che eri tu, suo papà. Aprivi la finestra, guardavi i sei piani di sotto e facevi un movimento come di ninna nanna mentre le braccia lo lasciavano andare. Poi Piero, sei mesi. Gli avevi baciato il volto, in particolare gli occhi, l’avevi annusato e ti eri voltato per non guardare mentre non sentivi più il suo poco peso nelle mani. Ti eri aiutato con le mani sulle finestre per alzarti, stando attento a non fare danni. Mentre precipitavi, pensavi che finalmente era finita.
Sant’Agostino, FE 2 Non si capisce subito che è un terremoto, ci si mette sempre un po’ a realizzare. Qualcuno aveva urlato, e lui aveva infine compreso. Era il capoturno, il più anziano; “Fuori, tutti fuori, uscite subito” aveva urlato. Il forno tremava, come avesse freddo, pensava mentre si voltava per uscire. Era
caduta una trave dal soffitto, l’aveva colpito alla testa, era caduto. Sarà durato un attimo, forse: ma un attimo è comunque tempo. Tra la rottura della scatola cranica e l’incoscienza, era riuscito a percepire lo scricchiolio delle ossa che si frantumano sotto il peso del tetto. Non sentiva dolore, non aveva paura. Pensava al destino che lo aveva privato della soddisfazione di girare in camper: pensava all’Irpinia, all’Aquila, alla finale di coppa Italia, alla sua famiglia, alla pensione, alla fine di tutto.
Sto galleggiando nell’aria
Piove, marzo. Sono a casa, sto bevendo un tè, leggendo il romanzo di uno scrittore russo. Sento il ritmo regolare della pioggia contro il vetro della finestra: un sottofondo piacevole. Squilla il cellulare, è Haruki. Rispondo. Una voce dal tono scosso, dal respiro affannoso; le parole sembrano pronunciate casualmente, tanto sono confuse; dice che ha il corpo ricoperto di segni rossi: è uno sfogo cutaneo. Mi chiede, per favore, di raggiungerlo. Arrivo davanti casa sua. Suono, mi apre il portoncino. È vestito con una brutta tuta da ginnastica. È sciupato, ha il viso macchiato e gonfio. Entro con circospezione, gli chiedo cosa sia successo, forse troppo frettolosamente. La stanza è in ordine, fin troppo; pare inanimata. I dischi e i libri sono al loro posto, i quadri anche, la televisione, il computer portatile , sul tavolino davanti al divano. C’è però un’atmosfera mortifera che copre ogni oggetto; è solo una sensazione, eppure mi penetra, glaciale e netta. Mi fa sedere, porta un tè e finalmente parla. “Da cinque mesi sto facendo una terapia per dei seri problemi al fegato e al pancreas. Ho cambiato diversi farmaci, ma non si sa a quale sia allergico. Devo farmi ricoverare per accertamenti”.
“Cinque mesi che fai la terapia? Ma io non sapevo niente, e... scusa ma sono sconvolto... Sei sempre stato solo, ti sei tenuto tutto dentro... cinque mesi di totale solitudine”, dico io. “Lo so, è vero! E adesso; adesso ho una fottuta paura. Mia moglie non sa niente, non ho avuto il coraggio di parlarle, e non so come affrontare questo casino... Scusa ... scusate tutti”. La voce è debole, condizionata dalla commozione e dall’umiliazione; nasconde tra le mani il pianto di chi non è abituato a farsi vedere in questo stato, e corre verso il bagno trascinando le ciabatte. Lo seguo, busso, entro e l’abbraccio. “Sono qui con te... Ti voglio bene...”, dico mentre gli occhi mi si riempiono di lacrime e la voce mi si strozza. Lo abbraccio con gli occhi chiusi. E non sento niente. È la persona con cui sono cresciuto, con cui ho condiviso viaggi e storie. E non provo niente. Vorrei provare dolore, sentire l’apprensione soffocarmi, immaginare il peggio: ma niente. Lo stringo e lui diventa di gomma morbida, mi si modella addosso fino a non sentirlo più. Poi lo scheletro scricchiola un poco; poi come fosse in decomposizione; poi come cenere di brace che si polverizza. Non sento male, non provo nulla. Poi riapro gli occhi e lui è lì; evitiamo di guardarci negli occhi per non umiliarci ancor di più. “Torniamo di là e chiamiamo l’ospedale”, dico. Chiama lui, spiega la sua posizione. È ingegnere nucleare, lavora in centrale da sette anni e sì, forse c’è stata una
piccola fuga di uranio; o forse è successo quando è andato con la squadra di tecnici volontari a ripristinare la corrente elettrica dopo lo tsunami. In azienda dicono che non ha tracce di radioattività, che non è contagioso, che non si può escludere che si tratti di un effetto collaterale dovuto alla missione. Gli dicono che manderanno un’ambulanza. Ascolto in silenzio la telefonata. Gli dico di non preoccuparsi per la moglie; chiederemo consiglio ai medici. Nel frattempo, diremo che è uno sfogo allergico. Si rilassa un poco. La realtà ci impone di essere forti. Si fa silenzio. La casa ne è invasa. Usciamo, dobbiamo andare, l’ambulanza sarà qui a momenti. Fuori piove. S’alza il vento, sempre più forte. Mi volto verso la casa. Un lampo improvviso, inaspettato, si accende dall’appartamento di Haruki. Uno scoppio, una deflagrazione fa volare pezzi di vetro, carne, schegge di plastica, legno. Il condominio si gonfia, scoppia, s’accartoccia, s’incendia, si ripiega e infine si disintegra. Il tutto dura pochi secondi. Lo spostamento d’aria mi scaraventa verso l’alto con un’energia tale, che non avrei mai potuto immaginare nemmeno col pensiero; non c’è più nulla né davanti né dietro me. Non c’è più Haruki, non c’è l’ambulanza, la strada, la città, il mondo, il pensiero, il sentimento, l’emozione. Tutto ormai è soltanto niente. Sto galleggiando nell’aria. Volteggio e roteo.
Mi perdo nella non dimensione cui appartengo: né vivo, né morto.
Mi sveglio sudato. Mi guardo attorno sconvolto. La camera è piena di brandine. La camera non è una camera: è una palestra. È marzo, è il 2011. Mi chiamo Yamaguchi e, se potessi esprimere un desiderio concreto, vorrei riuscire a dormire senza dover sognare questi incubi.
aggio
Il mio corpo sta assumendo un disegno strano, più curvo, rotondo: ora è un sinuoso contenitore smussato, la scatola magica che contiene il mistero biologico della vita. Eppure guardandolo così, come ritorno immediato, me ne sento offesa, disgustata. Non mi piace la figura che vedo allo specchio quando mi guardo: questa è la verità. Perché io debba pagare un prezzo così alto, non mi è dato di saperlo; e niente e nessuno, comunque, potrebbe convincermi che un ritorno alla normalità in pochi mesi, sia una promessa che compenserà questo disagio, questo degrado. Il mio posto nel mondo, il mio ruolo, quello che sono certa di rappresentare, sono compromessi da un’estetica sconveniente e sproporzionata; le mie già precarie sicurezze, conquistate in anni di fatica, di studio, sono minate, da dentro, da una percezione contorsionista che fa le capriole, che mi fa perdere e ritrovare, direzione e padronanza. Ho letto molto e so che posso avere degli scompensi, alti e bassi, che non sono altro che il risultato di impulsi elettrici, reazioni chimiche, battaglie ormonali, lotte psicologiche. Sono un laboratorio; un grosso tondo laboratorio che girovaga senza agilità per un mondo che osserva e giudica. Chilogrammi, taglie elefantiache di mutande e reggiseni, vestiti larghi a caduta perpendicolare, mutazioni e trasformazioni. Leggo i pensieri degli altri e vedo scritte parole sarcastiche quando pensano a me. Lo so sì, lo so da me che sembro un pallone con testa-braccia-gambe. Eppure tutto questo svanisce con un calcio, un impercettibile movimento, un cambiamento di posizione. Tu, immersa nel liquido, nel silenzio reale e irreale del misterioso mondo
sferiforme, galleggi, circoli liberamente, fai piroette circensi. Mi pare che te la si, e sento una sorta di gelosia mista a contentezza, per questo. Il tuo pubblico siamo io e te; solo io e te. E per uno strano sentimento di sufficienza, tu ed io, siamo tutto ciò che desideriamo; siamo un piccolo mondo, ma mai vorremmo che qualcuno venisse a curiosare tra i nostri segreti, che venisse a farci domande cui mai risponderemmo, in quanto sono solo affari nostri. Nella situazione complessa in cui ci troviamo, regna la semplicità e governa la delicata legge della natura e dell’istinto. Io mangio, tu mangi. Io rido, tu godi l’allegria. Io piango, tu scimmiotti rattristandoti. Non sono mai sola così; non posso nascondere segreti; tu in qualche modo sai, senza sentire: il contatto diretto ci unisce, il cordone è un megafono. Mi ritrovo sempre innanzi a salite e discese, alti e bassi, precipitosi cambi d’umore, repentini, improvvisi, temporali e tuoni e fulmini e ventate fresche nel caldo d’estate. Non c’è mai una stabilità stabile: soltanto le mille piccole instabilità che senza volerlo, mi causi; che hanno una strana forma di disciplina, un equilibrio da tiro alla fune. E il mio corpo è sempre un segnale da codificare, un’attività perpetua, composta di scatti, frammentata, disordinata ma viva, saporosa, odorosa, vitale. Quando mi fai stancare tanto, la schiena mi duole, i piedi come braci, il sudore che bagna la pelle. Non riesco a razionalizzare il sentimento. So a malapena collocarlo nel delicatissimo disegno universale, che si autoalimenta, che basta a se stesso e che provvede al mantenimento della specie. E credo questo ci preparerà al dopo.
Ci sono gli alti e i bassi, e occorrono forza e gioia per introiettare le contraddizioni della vita. Noi ci stiamo allenando insieme a separarci; a are dalla beatitudine dell’unità, al lutto della separazione; dall’eliminazione della dualità, al dispiacere di sentirci vicine ma pur sempre lontane rispetto al prima: al nostro adesso. A me spetta il dolore del corpo dilatato, che espelle una parte di sé che diverrà un’altra esistenza che non sono più io, ma tu. Ore a lavorare sodo, a respirare con ordine, col diaframma; lenta, su e giù, pancia in fuori inspiro, pancia in dentro espiro. E sarò maschera di sudore, bocca spalancata che urla, forte, come a sputare il dolore; forte, fortissimo, insopportabile. E tu dovrai lavorare, spingere, comprendere quando è il momento. Sarai ancora in contatto con me, ma saranno le ultime volte prima di affrontare lo scivolo delle viscere e terminare il viaggio, che inizierà proprio allora. Contemporaneamente uscirai ed entrerai; dal mondo perfetto a quello imperfetto. Dal silenzio magnifico della felicità assoluta, al frastuono, alle luci. E piangerai perché non saprai perché; non subito almeno. Poi erai da mani che non conosci, che fanno paura ad un posto morbido; riconoscerai un odore acre mai sentito ma familiare, una voce mai udita con quelle tonalità, ma dolce. Piangerai con forza, con totalità; ma quella voce, quella sofficità, quel profumo ti calmeranno. Per la prima volta sarai nel momento, nel punto esatto, dove qualcosa finisce per ricominciare subito dopo, in altro modo: tutto da imparare, capire, tradurre. Adesso, se appoggio le mani sulla curva rotonda della pancia, sento un piede e riconosco la tua risposta. Questi pensieri non erano solo miei; li hai indotti tu con la tua ingombrante presenza, con l’alfabeto del tuo movimento, con la danza acquatica che mi
disegni dentro. So che arriveremo alla fine esauste, ma resisteremo e trasformeremo la nostra unione in qualcosa di nuovo, forte, complice. In questo continuo rutilante miscuglio di emozioni sonore come schiaffi, fragorose come il silenzio assoluto, si aprono dei piccoli varchi e io, in quei piccolissimi pertugi, posso depositare amore; amore senza ragioni, perché uscito vivo da lotte leggendarie e leggi universali. L’altro giorno ho visto la tua prima fotografia in bianco e nero. Nel monitor, come in un film, ti muovevi senza fretta, con grazia. Ti sei mostrata nuda e libera e fluttuante. E ho anche sentito il tuo primo suono: un galoppare frenetico, un tambureggiare tribale; il tuo cuore echeggiava nel mio mare, la tua casa, la mia pancia. Dopo un po’, non subito, ho continuato a sentirti, a percepire il tuo linguaggio delicato e ho sentito una stretta fortissima al cuore, una morsa d’acciaio, improvvisa e ho capito che per sempre saremmo state legate, pur nella nostra unicità, avremmo condiviso per sempre un legame che è semplice e vitale e assolutamente involontario; è un marchio a fuoco che non abbiamo deciso, ma che abbiamo ereditato. Ora non resta che aspettare che si compia il meccanismo naturale. Uscirai da me, ma non preoccupartene: sarò lì ad accoglierti e stringerti. E ti nutrirò e rassicurerò. Sarò sempre con te fino a quando servirà, poi spero di riuscire a lasciarti andare. E un giorno ti leggerò queste righe e insieme ne sapremo ridere, con spensieratezza e leggerezza. Ti aspetto. Buon viaggio.
Incontri (omaggio a Guccini e Mestre)
È in ritardo, come sempre, unica certezza della sua vita incerta. Chiude il portoncino con quattro mandate, con un automatismo robotico. Scende i gradini tre alla volta e correndo la incontra lungo le scale. La riconosce subito, uguale all’immagine che coltiva nei ricordi, con dieci anni in più, ben distribuiti, nonostante la curva della loro età sia ormai parabola discendente. Sono due bei quarantenni, e quasi nulla gli sembra cambiato in lei. Subito, l’impatto della sua presenza, nei suoi circuiti neuronali. Pensa a tutto quello che sa, e sa che tutto quello che pensa non vale niente, appena più di poco, forse nemmeno quel poco e quel niente. Quello che sa, che pensa, è relativizzato dalla circolazione sanguigna, dal caos delle cellule che corrono qua e là, su e giù, come non avesse più semafori a dirigere il traffico interiore, sempre controllato e pacato. Vaffanculo pacatezza e controllo. Il corpo s’impone, frena deciso: inversione a U. -“Sei tu”, dice. -“Sì”, risponde lei. -“Cosa fai qui?” aggiunge d’istinto, pentendosi subito delle parole e del tono con cui ha pronunciato la frase. -“Sono venuta a pagare il terapeuta del secondo piano”, dice lei, guardando il pavimento del pianerottolo con un movimento involontario: un riflesso del suo pudore. -“Ti va un caffè, qui vicino c’è una pasticceria?” chiede lui.
-“Sì, certo che sì. Se puoi aspettare cinque minuti” risponde. L’aspetta fuori, camminando avanti e indietro sotto i portici, in attesa. Il portone si apre, lei esce. Vanno senza parlare verso la pasticceria, raggiungendo la saletta interna. Si siedono, lei sul divanetto e lui sulla sedia; lei appoggia le borse, si toglie il cappotto e lui si accorge di aver notato solo in quel momento com’era vestita e pettinata: aveva guardato solo i suoi occhi azzurro chiaro, riconoscendone la dimensione insondabile, benché trasparente nell’esprimere i suoi stati d’animo. Sono seduti vicini, le gambe si toccano a tratti, sprigionando piccole cariche elettriche che corrono lungo i loro corpi. L’eccitazione è un’inesauribile fonte emozionale: ricorda gli elementi chimici pronti a fondersi, a reagire, a trasformarsi in altro da sé. Ordina lui, d’istinto, senza chiederle conferma. -“Non hai sbagliato: ricordi ancora”, dice lei, sottolineando, senza dirlo, che le sembra sintomatico quell’automatismo. Non dicono, ma sentono la contrazione del tempo: dieci anni di vite separate, ati e vissuti come tra parentesi. -“Che strano trovarti oggi”, inizia a dire lei, “sono sette mesi che vengo in terapia in questo condominio e non ci siamo mai incrociati”. -“Pensa che ci abito da tre anni e non conosco ancora tutti i vicini”, dice lui. -“Ho iniziato la terapia dopo un periodo buio, in cui non riuscivo a vedere alcuna luce. Quanti figli hai?”, gli chiede. -“Ho due figlie, una di sette e una di tre anni. Se vuoi dopo ti faccio vedere le foto, le ho qui sul cellulare. Mi spiace per il tuo brutto periodo, e spero che la terapia ti aiuti”, dice. -“Scrivi ancora? Pensavo proprio a te quando mi sono detta, senza allegria, che
la mia vita sembra un romanzo. Quando ci siamo lasciati, dieci anni fa, era natale: la strada, le bancarelle chiuse, nessuno in giro e uno stupore bianco, come la neve che cadeva pigra quel giorno. Ti eri allontanato senza dire una parola e non eri più tornato. E per confermare la teoria delle coincidenze, come in un romanzo scritto male, lui si è ucciso per natale. Ora io e mia figlia, a natale, ci concediamo le vacanze in paesi che non lo festeggiano, per allontanarci dai ricordi”, fa lei. Silenzio. I loro occhi si incontrano, si catturano, fuggono, si ritrovano, rifuggono. Le loro gambe si sfiorano, e basta un tocco leggero e fugace a scatenare un’energia insostenibile: una massa di ricordi, rimpianti, sentimenti, sensi di colpa, coscienza, fuga, chiarezza, nausea, paura. Silenzio, occhi che roteano e fissano dettagli inutili: scatole di cioccolatini, focaccine, le divise delle banconiere, le scarpe di uno che beve un caffè, la borsa firmata di una ragazza. Non sono più stati felici, si sono mancati da morire, sono morti e rinati monchi; sono nati per stare insieme e hanno sputato sul loro destino: sono un solo organismo vivente ormai moribondo, sono solo un banale lui e una triste lei. Sono qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa. Lui si alza dal tavolino con una fatica di secoli sulle gambe, va verso la cassa con piedi pesanti di piombo, paga con mani arrugginite e tremolanti. Non capisce cosa dice la cassiera: le orecchie non distinguono suoni: producono solo brusio. Si volta, lei non c’è più. Si guarda allo specchio di una vetrinetta, non vede nessuno. Esce in strada e respira a pieni polmoni, mentre si avvia verso il nulla che ha riempito di parvenza di vita che, in quel momento, si dissolve.
Guarda alla sua destra perché nota solo ora che la sua figura non produce ombra. “Almeno lei ha sempre avuto il coraggio di vivere, dopo: io solo di fingere”, si ritrova a pensare mentre corre verso l’autobus che riparte, incurante di lui e della sua vita incerta.
Quaranta
Questa giornata è una bella giornata e io devo pigliare quel che viene con la grazia di chi non giudica, ma accoglie e sorride. Sembra oramai un mantra, questo. Non giudicare, accogliere e sorridere; non giudicare, accogliere e sorridere; non giudicare, accogliere e sorridere: ad infinitum. Ma perché non dovrei accettare i consigli del terapeuta? Una formula salvifica, è positività; ci metterà del tempo ma crescerà e lascerà un segno inciso nell’anima. Un giorno gli ho chiesto cosa fosse, e cosa intendeva per “anima”. Mi ha guardato col solito sorriso di chi la sa lunga, lui; e invece tu che fai ste domande, la sai corta corta. L’anima è una convenzione sociale - mi fa -; serve a fondare negli individui l’idea che abbiano un’interiorità, e che questa spesso non è in sincrono con quello che poi dicono, fanno, pensano, manifestano, agiscono: insomma, l’anima serve a giustificare Dio, la psicologia, la religione, le credenze, le sovrastrutture, le menate orientali, lo yoga, eccetera. In questo caso - aggiunge -, serve a contrastare ciò che lei - che sarei io - ha introiettato e considera immodificabile, pur non essendolo. E cosa considererei immodificabile? - faccio io -. Il suo destino di persona sola - fa lui con tono dolce e affabile -.
Quest’altro consiglio invece, non lo so accettare e alla mattina, appena alzata, mi prendo solo un caffè, nero e dolce, e fanculo. Dovrei are ai cereali e alle fette biscottate integrali con la marmellata biologica e il tè verde.
Dovrei ma non c’entra. Quello che dovrei è una costruzione artificiale e irraggiungibile di buoni propositi e adempimenti e fioretti e rotture di palle. E quelli che ti dicono quello che dovresti, sono di solito infelici anche se lo nascondono dietro quei sorrisi e quei modi così a posto che ti verrebbe voglia di prenderli a schiaffi.
Poi subito la sigaretta, tanto per far andar via quell’oppressione ai polmoni che schiaccia col vigore d’una pressa. La prima cicca è una delle cose belle della mia vita: tiro forte, tirate luuunghee, che occupano immediatamente tutte le distonie dei polmoni che si lamentano. Voglio un figlio, cazzo.
Onomatopee della prima: Sssssssss (aspiro), ffffffffff (butto fuori). E poi la pace, l’ansia che si placa e ridiscende dentro fino a diventare lontano ricordo che ogni tanto ricompare. Non è molto elegante, ma lo dico lo stesso, tanto mica va su un giornale rosa sta specie di diario a pezzi: la sigaretta me la fumo in bagno, mentre faccio i bisogni. E tanto per dirla tutta, ma proprio tutta, è la più grande liberazione sfinterica che si possa immaginare, e io me la godo tutta tutta, prima di ridiventare un essere con sembianze umane. È il vantaggio di abitare in campagna, in case grandi che hanno almeno tre bagni. E questo è solo mio. Mia madre e mia sorella ne hanno anche loro uno ciascuna; e così ci posso fare
quello che voglio qua dentro. Il bagno è mio e lo gestisco io. Vorrei un amore che dividesse il bagno con me.
Finalmente riconquisto la libertà dopo anni di sacrificio; mi sono tenuta dentro tutto, tutto soffocato là sotto, perfino a cagare ci andavo quando ero sicura che non c’era nessuno in casa; per paura di far rumori molesti, o puzza. La femminilità si misura ancora oggi secondo canoni onomatopeici secolari: la donna dev'essere silenziosa, discreta, efficiente, ubbidiente. Certo, come no; mal di pancia, mal di piedi, schiena, testa: chi bella vuol apparire, in silenzio deve soffrire. Proprio pensieri da cesso mi vengono alla mattina, altro che bella giornata. Mi piacerebbe essere una donna, non una femmina.
C’è questa rabbia che esplode così senza preavviso e che mi impone pensieri che non vorrei pensare e mi fa dire, nel silenzio di questi, parole che mai vorrei udire da alcuno; specialmente da me stessa. Ma poi ano; “è forse la tazza che evoca il piacere anale che ritorna con la sua semplicità, complicata ad arte dalla morale e dalla cultura occidentale”. Ma che bei pensierini da convegno che mi vengono mentre me ne sto qua seduta, con sta cicca fumante tra le dita, mentre faccio tiri lunghi, potenti, che mi riempiono e quietano. Desidero una carezza.
Finito! Adesso via sotto la doccia.
“Sono un corpo umido d’acqua e vapore/sono nascosta dentro a questa nebbia/mi vedi e non mi vedi/ ci sono o forse no/sono solo un sogno/ che si rivela un poco/ per suscitare domande/ per scaturire risposte”. C’è chi canta, in doccia; io no, m’immagino d’essere una che scrive canzoni, o poesie, e a seconda di chi me la commissiona, scelgo un particolare stile. E anche perché ho sempre freddo e questo comporre canzoni e versi mi distrae dalla temperatura che mi penetra la pelle e arriva fino alle ossa e poi ancora oltre, ad allarmare le interiora. Ambirei talvolta alla superficialità.
Terminata la doccia inizia il supplizio: devo decidere cosa mettermi addosso; ed è una logorante guerra quotidiana, una di quelle cose che, in certe giornate, mi spossano ancor prima d’uscire. Oggi non dovrei avere riunioni quindi una qualsiasi cosa dovrebbe andar bene, a patto che sia almeno decente. Che poi lo so che non sono gli uomini che s’accorgono come mi vesto o se tutto è intonato, ma quelle mezze vacche delle mie colleghe; le regine del brusio, le star del chiacchiericcio. Va bene, decido per il blu, che tutti mi dicono mi sta bene e basta. Questi jeans mi stanno proprio bene, con quello che son costati, ci mancherebbe; e poi sono di moda e coordinati con i gemelli blu scuro sono a posto. Adoro sentire questa lana pregiata sulla pelle, arci le mani sopra facendo finta di sistemarmi, ma in realtà soltanto per posarci le mie mani sopra e affondare sul morbido. Un trucco leggero e una spazzolata ai capelli che speriamo resistano fino a sabato che ho appuntamento dal parrucchiere. Datemi una corazza.
Prima di uscire devo dare un’occhiata all’agenda e fare il punto della situazione; l’altro giorno Gianluca e Susi mi hanno invitato al cinema con tutta la compagnia e io, come una scema, a dire sì, sì; con una faccia che si vedeva lontano un chilometro che non ho mai niente di bello da fare, solo impegni, e corsi, e palestra, e teatro, e basta. Il teatro, un posto e un tempo per provare emozioni vere, per farmi uscire da questa monotonia, da questo appiattimento cui assisto come fossi a teatro; spettatrice al di qua del proscenio della mia vita: uno spettacolo scadente, con pochi applausi di un pubblico immaginario feticista e vagamente depresso. Un applauso alla mia vita, vi prego.
E insomma quella sera dovevo andare al cinema e poi, magari, a sarebbe stato bello fare tutti insieme uno strip poker: io che avrei perso apposta, e davanti a tutti, un pezzo alla volta, avrei tolto con la finta calma pacchiana delle spogliarelliste, gli indumenti. E sentire che quelli che mi guardano si eccitano, gli si gonfiano i pantaloni. E le donnine gelose, perché sentono quest’elettricità che investe tutti. E invece sono uscita e ho visto il film senza perdere una scena. Ho anche pianto verso la fine, e con una scusa sono dovuta andare in bagno a truccarmi di nuovo. Poi come al solito, casualmente, tutti se ne vanno e io rimango col fesso di turno che ci prova. Se ci provasse un uomo con me, invece dei soliti fessi.
Il tenore di certi discorsi, fatti senza pensare, senza esserci, senza esistere. Lui: - “La fortuna di essere femmina, di poter scegliere chi voglio quando ne ho voglia”
Io: - “Ma la mia voglia ha una qualità diversa, e sorge solo se sono desiderata” Lui: - “Non so come fate, ma quando volete, inducete il desiderio in noi maschi” Io: - “Sono solo parole e pensieri tipicamente maschili. La realtà è molto più complicata e difficile” Lui: - “La realtà è la rappresentazione che noi diamo della nostra soggettiva visione delle cose” Io: - “Certo, hai proprio ragione. Senti, sono un po’ stanca, ti spiacerebbe riaccompagnarmi al parcheggio della pizzeria che prendo la macchina e torno a casa?” Lui: - “veramente speravo riuscissimo a stare un po’ insieme stasera” Io: - “anch’io, ma non mi sento tanto bene. Scusa” Aiutatemi a scoraggiare la noia.
Mentre raggiungo la macchina per andare al lavoro penso che ormai ho superato i quaranta, che i miei sogni stanno diventando materiale effimero fuori moda, che se non mi muovo non diventerò mai madre, che continuerò a vivere con mia sorella e mia madre, che il calore e l’amore di cui penso di aver bisogno, li leggerò sui romanzi. E che magari adottando un figlio smetterò di fumare. Nel frattempo mi accendo una cicca. In macchina mia decido io: qui si può fumare!
Segnali onirici di mezza estate (e di mezza età)
Lido di Venezia, zona San Nicoletto, nel pezzo di spiaggia libera non distante dalla diga. Davanti al mare, seduto, un tardo pomeriggio di agosto, guardo e ascolto. Mi immergo nel moto perpetuo, l’eterno su e giù delle onde. Sto così un minuto, cinque, dieci. Rilasso le spalle, che mi accorgo essere tese. In posizione a gambe incrociate, sciolgo i muscoli.
Mesi fa, incalzato dall’insistenza di amici e conoscenti e colleghi, ho finito per assecondarli, organizzandomi una festa a sorpresa. Ho mandato dei biglietti, firmandoli col nome di qualcun altro di loro, inducendoli così a pensare che qualche buon’anima si fosse finalmente deciso a organizzarla, 'sta festa. " il 22 agosto alle 18 festa a sorpresa di Cristiano per il suo cinquantesimo compleanno. Giavera del Montello, al Macondo. Bada bene a non farne parola con il diretto interessato!" C’è sempre bisogno di uno così, che si prende la briga di fare concretamente qualcosa, avranno pensato tutti. E perciò ho concretamente fatto: adesso staranno già arrivando i primi. Loro sono a circa settanta chilometri da qui, in collina: ho preferito non correre rischi e li ho piazzati lontani da dove sono io. Qualcuno avrà già mandato giù più di un aperitivo. Me li vedo, quelli e quelle;
abituati a comandare le parole, a gestire i gesti, a inventarsi nuovi sé i più lontani possibile dall’originale. Guarderanno l'ora su orologi e cellulari, tra un aperitivo e l’altro dissimulando le ovvie domande sull'assenza del festeggiato. Si distribuiranno sorrisi eleganti, parole di circostanza, allegrie simpatiche, pensieri pornografici. Mentre io sono qui.
Seduto così ho quasi l'impressione di sentire sulla nuca il peso leggero dello sguardo degli altri. In un momentaneo istante di follia transitoria, immagino un dialogo con i mandanti di quegli sguardi. - “ cosa sta facendo, perché sta così: che stia così per posa, per farsi guardare? ” - “ sto nullando, sto nientendo ”, risponderei loro. - “ e dovreste provarci, qualche volta ”, aggiungerei. - “ sapeste quanto sia ricco questo apparente nulla immutabile, questo rumore di onde, questa schiuma, quest’orizzonte, questa bellezza evidente eppure mesta, disinteressata all’esibizione ”, gli vorrei dire. - ” Basterebbe fare attenzione, e tutto sarebbe infinito orizzonte, realtà pura, visuale pulita ”, pronuncerei se avessi voglia di parlare. E invece taccio. E ristoro la mente, quieto i pensieri, smusso gli angoli, tradisco la fretta, aborrisco l’inutilità, sposo e bacio e lecco l’essenza. Oggi è il ventidue agosto duemilaquattordici e compio cinquant’anni.
L’ultima volta che sono stato a una festa di compleanno di un amico che ha compiuto i cinquanta, qualche mese fa, poiché non riuscivo a sostenere emotivamente la puerile oscenità delle scene che mi si presentavano davanti, ho dovuto ricorrere ad una strategia mentale: sei uno scrittore, mi sono detto, fai quello che fanno quelli che sono quello che anche tu sei. E così sono entrato nella parte: ho iniziato a muovermi, a interagire, a dire a qualche orecchio distratto che ero uno scrittore. Subito qualcuno si è precipitato da me a chiedermi telefono e mail per sottopormi manoscritti dopo aver girato attorno ai discorsi. Ho avuto un rapporto orale con una della mia età che si era rifatta le labbra: le aveva gonfie e di profilo sembrava tragicamente Paperina. Mentre era là, inginocchiata con un asciugamano sotto le ginocchia, in uno dei bagni liberi della bivilla con giardino del festeggiato, pensavo che erano anni che non leggevo più Topolino, e che non ne sentivo la mancanza, se non per il fatto che quando lo leggevo ero molto più giovane. Alla fine lei mi guardava con occhi desiderosi di gratificazione. Le ho detto “grazie”, e sono tornato alla festa. Se fossi stato me invece di essere lo scrittore, sarei voluto sprofondare, sparire, scoppiare lì in bagno, per l’indifferenza che provavo. Uno scoppio che avrebbe prodotto uno schiocco come se fossero state le sue labbra a scoppiare, piuttosto che io. Ma istintivamente mi sono detto “ segnatela questa ”, dimostrandomi così di essere lo scrittore e non me.
All’improvviso mi alzo, sento la sabbia umida sul costume, e me la tolgo con le mani. Lo faccio quando m’accorgo che la gioia di prima e i pensieri che ne sono seguiti, stanno per diventare posa. Quando l’orgoglio di saper talvolta vedere e sentire, diventa orgoglio. L’ego non dà tregua. E mi riporta al sonno delle abitudini.
Sono stato bene con me. Quando mi sono dimenticato di me, e sono stato in uno stato ignoto e amico, in comunione con quello che c’era. E io non c’ero.
Quella volta della festa dell’amico cinquantenne - “ mezzo secolo eh!? “, gli dicevano indistintamente tutti con tono soddisfatto come fosse una frase di cui darsi vanto -, quando dimenticavo di essere uno scrittore, rientravo in ciò che ero. Immaginavo la mia, di festa; vedevo tutti avvicinarmisi, farmi gli auguri, e dirmi immancabilmente “mezzo secolo eh!?“. Non riuscivo a mantenere sempre distinte le personalità. Prima di rientrare nell’identità dello scrittore, c’è stato un momento in cui mi sono estraniato dal salone della bivilla - penso si possa definire un fenomeno extracorporale, quello che mi è successo -, e come se il mio udito fosse stato a livello del soffitto, sentivo un unico continuo brusio: un chicchiericcio, un cicaleccio, un bla bla bla, con qualche acuto ogni tanto. Sei uno scrittore, mi dico. Lo so, mi rispondo. Torna giù, appoggia i piedi al pavimento, scrivi due appunti, immergiti nella parte. Uno scrittore può immedesimarsi in qualsiasi situazione e uscirne indenne, con una storia in tasca. Anche nei panni di un cinquantenne che vorrebbe essere ovunque, ma non dove si trova; ivi compreso questa festa di gente che dissimula la delusione e l’amarezza che li ha ormai invasi e condizionati, scambiandosi sorrisi, frasi di circostanza, gesti consumati. Ecco, scrivi così, calca la mano, esagera: tu puoi, sei autorizzato a farlo.
Raggiungo a i calmi l'acqua, sento il contrasto del freddo sui piedi accaldati dal sole.
Avanzo a i regolari nonostante le conchiglie sotto i piedi. Ad altezza inguine mi immergo, con uno slancio in avanti. L'impatto è piacevole, come fosse un ritorno alle origini, ormai dimenticate, causa inutili occupazioni quotidiane. Nuoto alternando gli stili, cercando di mantenere uno stile rigoroso, ma rilassato. Raggiungo il largo forzando fiato e muscoli. Ora sono solo, distante dalla riva. Il vociare continuo e frenetico che disturbava la quiete interiore, viene sostituito da un vociare lontano, indistinguibile.
A un certo punto mi si è avvicinato il festeggiato: senza capelli, con la pancia che sporge dai pantaloni, coi mocassini in tinta, le braccia coi muscoli della palestra, la camicia bianca aperta sul petto coi peli bianchi. AH AH! Ride sguaiato, mi abbraccia: odora di profumo buono. “ Mezzo secolo, eh!?, anche tu fra poco! Ma io sto bene, mai stato meglio e questo, e si tocca il prima il suo, e poi il mio, funziona ancora AH AH! “. È questo l’importante!, dice ridendo. a davanti a noi la figlia di un nostro amico: avrà venticinque anni, tatuaggi, piercing, testa rasata, bellissima. Eh!, e mi dà una botta col gomito; “ se non fosse la figlia di Bruno Buoso, questa me la porterei in taverna e glielo farei vedere io il tatuaggio AH AH! ”. Sorrido a bocca stretta. Annuisco. Mi da una botta sulle spalle, e va verso sua moglie, invitata anche se sono separati da tre anni e mai pacificati del tutto. A quanto dicono, lui sarebbe costantemente sul filo della bancarotta, circondato da gentaglia, stretto nella morsa di equitalia e ndrangheta di cui sarebbe ormai un prestanome. Tira su col naso e quando si allontana mi accorgo che è senza culo.
Tutte notizie sapute stasera, da gente che non vedevo da qualche decennio. Chissà cosa dicono di noi, mi sussurra in testa il me scrittore.
Mi metto in posizione del morto: viso in su, braccia e gambe allargate, come l'uomo vitruviano in orizzontale. Gli orecchi sott'acqua condizionano l'udito rendendo ogni rumore sordo, filtrato. Lentamente un onomatopeico, morbido blo blo blo mi rilassa, chiudo gli occhi, la presenza lucente del sole s'affievolisce, fino a sparire. Sento la presenza soprannaturale di mia madre: oggi avremmo festeggiato insieme il mio compleanno.
La ex moglie del festeggiato mi si avvicina, ondeggia un poco. Ha in mano un flute di prosecco, mi fa cin. Mi prende sottobraccio, mi conduce nel giardinetto della bivilla. Mi offre una sigaretta che accetto; lo scrittore, mi dico, può anche fumare una sigaretta, benché il quasi cinquantenne non fumi più da decenni. “ da quando ci siamo separati la mia vita è finita e ricominciata. All’inizio non mi sembrava possibile: pensavo ai venticinque anni ati insieme, buttati via come spazzatura. Poi invece ho capito: se non ce n’è, perché continuare? Pensavo di essere ormai esaurita come donna e invece, senti qua ”. Mi prende la mano, se la mette dentro alle mutande per farmi sentire che è bagnata. Poi la toglie. Si volta, fa per andarsene. Si rigira, mi guarda, sorride. “ tu sì che ti sei tenuto in forma ”, e poi va. Non l’ho più rivista per tutta la sera.
Sono un cosino grande così. Un esserino che galleggia nel liquido amniotico, che fa le capriole, riposa; sono nell'ambiente più perfetto che si riesca ad immaginare: una sorta di paradiso acquatico. Fa buio, ma non mi manca la luce. S'intravede la curva del ventre materno, la sua rotondità sinuosa, la sua dilatazione naturale. Il silenzio è padrone, interrotto solo, a tratti, da qualche eco lontana. Il tempo è un concetto inutile, un frammento, un particolare ininfluente di questa umida eternità. Improvvisamente una sorta di gorgo mi attira, mi pone in verticale, a testa in giù. Il liquido fuoriesce nella stessa direzione verso cui sono attratto. o attraverso un corridoio stretto, fino a giungere verso un'apertura che s'allarga poco alla volta. Combatto contro una forza superiore che mi sospinge verso la cavità pelvica. Una luce abbagliante oltre la barriera della vulva che s'apre, s"allarga, m'inghiotte. Non so se sto andando incontro alla vita, o alla morte.
Guardavo l’ora. Era l’una di notte. Avevo piedi e gambe doloranti: la vena varicosa, pensavo. In sala c’era un nostro compagno di ragioneria che faceva il dj, metteva musica anni ottanta, quando eravamo ventenni e pensavamo al futuro e a scopare. C’erano una quindicina di persone che ballavano, con le stesse movenze di allora, rese ancor più nostalgiche dai corpi appesantiti. Guardavo le gambe, i pantaloni, le scarpe, le acconciature, le calvizie, le risa, le rughe, la voglia irrefrenabile di futuro e di scopate.
Trent’anni dopo, come trent’anni prima: in mezzo soltanto tempo, ato a rimpiangere quello appena ato. Rivedo in quei volti sudati, i volti di allora. Non provo nostalgia, non provo niente: sono uno scrittore, e in quanto tale un bugiardo, un venditore di cronache e suggestioni vere, miste a finzione. Ecco, tocca il trenino. Tocca farlo, scrittore, mi dico. Inventa qualcosa, scrivi che dietro c’era una che ti toccava il culo e che davanti c’era uno che appena poteva frenava per farsi toccare il suo. Quanto tempo a bramare e raccontare sesso. Ecco un argomento da scrittori. Il dj spara “ people from Ibiza “ e tutti ridono e sculettano. Fatevi travolgere!, dice al microfono il ragionier dj Guidi. Suda in modo imbarazzante e sorride, tutto preso nella parte. È talmente ridicolo da risultare simpatico.
Apro gli occhi, guardo sotto di me, sul fondo sabbioso, in cerca di cavità: niente. Immagino sia stata una suggestione, un’allucinazione, un colpo di calore. Mi rimetto in moto, muovo braccia e gambe in direzione riva. Pochi minuti dopo arrivo, gli ultimi i pesanti sull'acqua bassa.
Prima di uscire, o in bagno a lavarmi le mani. Dentro una stanzetta vedo la sagoma "der pantagruelico", il Ciccio arrivato da Roma quando eravamo in terza; ci ha messo tre giorni a conquistare la simpatia di tutti e diventare uno di noi. Guardo meglio e vedo anche Seghetti, omino ormai untuoso, che fa il commercialista del festeggiato; ci sono anche Emma
Tuorlo, che gestisce un negozio di parrucchiera in periferia, Oreste Fragile, che lavora come facchino dopo aver chiuso l'azienda di traslochi di famiglia e la figlia di Bruno Buoso: non vedo bene, ma sento distintamente il movimento di narici. Questo non scriverlo, provo a dire allo scrittore, il quale annuisce, come a dire "certo come no, figurati". Mi lavo le mani, poi urino. Mi guardo allo specchio: lo scrittore mi osserva divertito; probabilmente sarò patetico nel dissimulare età e giudizio, mentre lui se ne fotte. E ci ride su.
Cosa scriverebbe uno scrittore di queste brevissime allucinazioni? Cosa direbbe di uno di mezza età che finge di accettare l’idea di una festa per sè, e non vi partecipa? Come scriverebbe di una giornata di sole, solitudine e silenzio?
Mi arriva come uno schiaffo il chiacchiericcio della gente stesa al sole. Mi irrigidisco, sento tornare in forza le difese verso il mondo ostile, percepisco la scomparsa della dolcezza, l'arroganza dell'istinto di sopravvivenza alle regole. Mi volto per un ultimo sguardo verso il mare. Ma la grazia è transitoria, e vedo solo sabbia e acqua.
Traversata
Mia madre insisteva con forza. Più era debole, fragile, sola, più s’impuntava e insisteva. Lo sai che tuo cugino è già andato, che se la cava bene, diceva sempre. E io rispondevo che era vero, ma che non potevo andare così, senza sapere cos’avrebbe fatto lei, da sola, senza appoggi, senza un uomo che la proteggesse. E lei diceva che non dovevo preoccuparmi, che i parenti le sarebbero stati vicini. Vai, è il tuo viaggio: ti spetta!
Nel nostro quartiere abitava uno che prestava i soldi: non si parte per un viaggio, senza; e lui te li prestava. Bisognava pensarci bene: guai a non restituirglieli, con gli interessi: avrebbe perseguitato tutta la famiglia, nessuno escluso, senza pietà. Aveva una memoria contabile infinita, e una crudeltà negli affari senza requie.
Per arrivare al punto ics bisognava partire almeno un giorno prima. Mia madre mi aveva preparato il bagaglio. Avevamo preso uno zaino, perché era grande come una valigia ed era più comodo da portare in viaggio. L’avevo abbracciata forte, le avevo giurato che l’avrei chiamata appena arrivato; avevo nascosto il mio viso al suo sguardo perché un uomo non si fa vedere quando piange. Lei invece non si era nascosta e mi aveva dedicato una bellissima poesia
d’amore, attraverso il suo sguardo. Volevo chiederle di dirmi la verità, volevo sapere dove fosse mio padre, perché era sparito, ma avevo taciuto: le avevo promesso di non parlarne più, e io mantengo le promesse. Il suo ultimo gesto era stato una carezza delicata sui miei capelli neri come la notte, come amava ripetere lei quando ero bambino.
Sono partito. Ho attraversato la pianura arida, il deserto, con un pullman vecchio e rumoroso, così pieno di gente che quasi mancava l’aria. Eravamo tutti sudati, stufi, tramortiti dalla polvere, dalle buche, dal caldo insopportabile, dalla mancanza di futuro, dall’evidenza del presente. Alla frontiera bisognava mettere un po’ di soldi dentro il documento e si ava senza problemi. A me è andata bene; a molte persone, soprattutto alle donne, invece, è andata male. Le hanno lasciate lì, al confine, senza documenti, senza bagaglio, senza più niente. Qualcuna invece, è stata portata via, dove si dice che, se va bene, escono sfigurate, incinte, ma vive. Se una di queste fosse mia sorella, mia cugina o mia madre cosa farei? Non mi sono risposto: ho solo chiuso gli occhi e pregato che certi pensieri non mi toccassero più.
Quando sono arrivato in centro città, sono andato al mercato, mi sono mischiato alla folla, ho camminato tutto il giorno da un banchetto all’altro, cercando di non farmi notare e tenendo sempre stretto lo zaino.
Quando ha iniziato a calare il sole, aiutato dall’odore di salso, mi sono incamminato verso il mare. Non avevo più molto tempo, non potevo permettermi di sbagliare posizione, né parlare con nessuno: mi avevano avvisato che qui è pieno di spie della polizia che, in cambio di poco, o perché costretti, denunciano chiunque.
Ho raggiunto la spiaggia, invisibile come tutti quelli come me. Ci siamo tutti nascosti tra gli alberi in attesa del segnale. La spiaggia era deserta, il mare era un immobile tappeto nero, il cielo, dapprima luminoso di stelle, si è via via incupito fino a sparire nel suo stesso buio. Il rumore delle onde si faceva sempre più rabbioso, il vento sparava la sabbia con violenza, l’elettricità dell’aria s’accoppiava alla nostra tensione.
All’improvviso il segnale. Dei colpi di luce ondeggiavano al largo. Siamo usciti di corsa, a decine: visti dall’alto saremmo sembrati formiche. Abbiamo raggiunto il peschereccio superando onde sempre più violente. Una volta saliti a bordo, tutti seduti sul ponte, gli spruzzi del mare, il gonfiarsi del vento, la pioggia che iniziava a scendere violenta. Il mio ultimo pensiero a te, madre, che mi proteggi col tuo amore che, lo giuro, ricambierò coi fatti: coi soldi per la casa e per il debito. Tornerò per rimanere: mi sposerò e farò figli che saranno nipoti felici. Sperando i in fretta questa notte di tempesta.
Era il 13 ottobre 2013, data in cui sono morte 363 persone
Skype
Ci sentiamo via skype. Il mio schermo mi fa vedere la mia faccia e la sua, in formati diversi, tridimensionali; oltre ai nostri volti, di contorno, le stanze dove abbiamo i computer. Da circa un anno ho cambiato residenza; lui da pochi giorni soltanto. Prima, a casa mia, la stanza dove leggevo e scrivevo, era più stretta e lunga, con le travi del sottotetto che scendevano da due metri e venti a un metro e dieci; ora è quasi quadrata, più ordinata, con scaffali di libri che non stanno nelle librerie in soggiorno, e che dovrei riordinare per autore e casa editrice senza riuscire a farlo mai. Da decenni, con gli ebook, è automatico: si sistemano da soli, basta indicare il criterio; volendo, si possono creare librerie virtuali a grandezza 1:1, con gli ologrammi. La mia collezione è antica, e per alcuni obsoleta; per me rappresenta il legame con quella che un tempo era la mia vita. Sogno di lasciarli ai miei nipoti, sperando riescano a cogliere l’amore con cui li ho raccolti: un amore che non è pratico, né conveniente; come dovrebbero essere tutti gli amori.
La stanza che vedo attorno a lui invece, è ancora precaria, fresca di trasloco; riconosco scatoloni, con scritte in inglese, con forme e colori diverse da quelli italiani. Mi capita di chiedermi se siamo noi a distinguerci da loro o viceversa. Nel periodo post-globalizzazione sono tornate in auge le forti caratterizzazioni nazionali, per chi può permetterselo. A lui piace parlare con me, tirare fuori da angoli nascosti, l’italiano: lo pronuncia con accento straniero per i primi minuti, poi si scioglie e torna l’uomo che un tempo era il mio migliore amico.
Skype ci costringe a primi piani che a tratti mi mettono in imbarazzo: nessuno dei due ci è abituato. Ricordo certi film che tentavano di ipotizzare il futuro, e che tra le tecnologie futuribili, c’erano videotelefoni; ricordo che mi chiedevo, allora, come sarebbe stato chiamare qualcuno e vederlo: ora che è possibile, da decenni, addirittura in 4D volendo, capisco che il sapore tra come si immagina qualcosa di futuribile, e quando l’immaginazione diventa concreta, cambia, e di molto. L’abitudine accelera e corrompe ogni novità.
Piove, tanto. Qui e là. Più là di qua. La pioggia scroscia talmente forte che dobbiamo alzare il tono della voce. Ad un certo punto il rumore invade ogni pensiero e ci lascia interdetti. Sento delle voci provenire da un’altra stanza. Lui si scusa, mi dice che lo chiamano, che lascia un momento la chiamata. Si alza, lascia la postazione, mi fa un gesto con la mano, come a dire che torna subito.
Osservo lo spazio lasciato libero: vedo scatoloni, la sedia sopra cui sedeva, la luce della lampada da tavolo, e poco altro, in penombra. Lo scroscio aumenta di intensità, diventa furioso. Lo schermo emette scariche elettriche, sembra un vecchio televisore che non trova il canale.
Il rumore diventa un rombo che si alterna al suono artificiale delle scariche grigionere dello schermo, e sembra preludere alla catastrofe. Sento frasi concitate provenire da altre stanze, voci che diventano improvvisamente urla e imprecazioni multilingue. Riconosco la voce del mio amico che grida “ le bambine, le bambine, forza usciamo, svelte”.
Prima che lo schermo diventi nero, mi pare di vedere porte e finestre che rinculano, costrette da una massa d'acqua potente e definitiva. Poi più niente. Deduco che la corrente è saltata, e che la vita del mio amico, in questo preciso momento, è pura emergenza vitale.
Anche qui piove a dirotto, e la temperatura, pur con la tara di umido, è primaverile. Sono almeno tre decenni che non torna l'inverno, e il mio corpo ormai vecchio, benché ancora totalmente immune da qualsivoglia malattia, ne risente. C'è stata la revisione del calendario, che ha ridotto le stagioni da quattro a due: primavera e estate. I miei nipoti sono nati e cresciuti in questa dimensione temporale, e la considerano naturale e ovvia. Ma il mio corpo ricorda, e soffre di una sorta di nostalgia biologica. Quello che mi manca di più è l’odore dell’aria fredda: puro, perfetto.
Si è tanto discusso di riscaldamento del pianeta, senza agire di conseguenza; ci si era divisi, tra chi voleva il contenimento dell'inquinamento ambientale, e chi lo
negava, adducendo idee di progresso tecnologico, il quale avrebbe fermato il progressivo ed evidente disfacimento climatico del pianeta. E mentre il futuro avanzava sempre più in fretta, l'imputridimento terrestre procedeva, accelerando anch'esso. E così, dei pochi testimoni del mondo che fu, siamo rimasti solo noi, vecchi tacciati di nostalgia, nutriti da futurviagra 4.0, da antidepressivi con effetto antimnemonico, rappresentati politicamente da leader ininfluenti, messi all'angolo dal ricatto delle comfort-community residenziali, obbligatorie per chi supera i settant'anni.
E non preoccupatevi per il mio amico. È già successo altre volte che la sua casa sia stata invasa dalle piene fluviali e dalle piogge incessanti. Ogni abitazione è costituita da elementi intercambiabili, e le fondamenta fungono da vasche raccogli acqua, che viene poi ripulita, sterilizzata, rimessa in circolo. Nel giro di un paio di giorni mi chiamerà, ci rimetteremo in videoconferenza con gli amici, e finiremo la partita di scopone scientifico che abbiamo interrotto causa forza maggiore. Tanto, con i nuovi farmaci antireumatici che ci somministrano qui assieme a quell'altra medicina che ci mantiene sessualmente attivi e mai depressi, rischiamo l'immortalità. Per fortuna siamo attrezzati, e chi non ne ha più voglia, di vivere, l'eutanasia legalizzata la si può scegliere tra diverse modalità di applicazione: sono tutte indolori, ovviamente, e si differenziano soltanto per la durata.
Ora però devo lasciarvi. Stanno arrivando i miei due nipoti, che staranno con me le tre ore settimanali,
utili a raccontare il mondo che fu, consentendo lo sviluppo della memoria affettiva, diventata ormai pedagogia riconosciuta. La cosa più difficile è quando parlo loro della neve: non riescono, se non in termini di fantasia favolistica, o di ologrammi, o di parchi a tema, a credere che esisteva in natura. Del resto, mi viene da aggiungere, perfino io e il mio amico, un tempo, siamo esistiti.
Piove
Piove una pioggia svogliata, cielo grigio, poca luce, nuvole basse a far da cappa alla città. L'autobus si ferma, salgo con altre diciannove persone. Sento un urlo, un'offesa a sentire i commenti, pronunciata con tono e linguaggio primordiale. Non ho capito cosa è stato detto, ma vedo correre il ragazzo che l'ha pronunciato, il quale fa gesti inconsulti all'autista. Tolgo le cuffiette, voglio capire. Sento solo brusio e non capisco niente. Arriviamo al semaforo, dei rumeni commentano tra loro l'episodio, il ragazzo continua a correre accanto al bus, accelerando e frenando, mantenendo una traiettoria parallela. Semaforo rosso, l'autista apre le porte, scende, l'altro scappa. Vieni qua, gli dice, se hai coraggio. Stronzo, aggiunge poi. Risale soddisfatto di sé, della fuga dell’altro, dell’apparente dominanza momentanea. Per tutta la strada, il ragazzo corre, l'autista lo guarda, mentre parla con una biondona russa coi jeans che le segnano il culo abbondante. Attorno a noi, uno dopo l'altro, negozi chiusi con scritto vendesi o affittasi. Su una trentina di negozi, almeno quindici hanno il cartello in vetrina e le serrande abbassate. E siamo in centro. Una zona dove pochi anni fa la vita pulsava. Ora è abitata per lo più da stranieri, il valore delle case ha subito un tracollo verticale, i negozi chiudono perché non ci sono più clienti.
Ogni tanto si vede qualche bar chiuso per intervento giudiziario. Il rapporto causa-effetto ottiene una concretezza stridente, e servono colpevoli a portata di mano.
Il ragazzo continua a correre. Ha un giubbotto di due misure più grandi, un cappello col frontino in testa, lo zaino, un paio di braghe larghe, scarpe da ginnastica. È trasandato, pare sporco. Continuano a guardarsi inscenando una sfida piena di tensione e allo stesso tempo ridicola. La natura del conflitto tra gli esseri, intrinseca ma negata, e perciò pronta ad esplodere improvvisa, è quasi palpabile. Fantastico che al prossimo semaforo il ragazzo prenderà a calci e sputi il bus, o che gli lancerà un sasso, che estrarrà la pistola e sparerà all'autista, che si trasformerà in martire suicida e compirà un'azione kamikaze, o chissà che. E corre, continua a correre, pur non avendo l'aspetto di uno che fa sport, che ha fiato e gambe buone, se non per scappare quando gli corrono dietro.
Le fermate si susseguono, la biondona col culo scende, i rumeni parlano tra loro, coi loro giubbotti in pelle fuori moda, seguendo con lo sguardo la donna. Piove, il cielo è grigio, i negozi in affitto o in vendita; uno aperto e uno chiuso, uno aperto e uno chiuso, e via così. L'autista guida nervoso, è tutto un susseguirsi di frenate e accelerazioni brusche, di commenti spigolosi. Siamo quasi arrivati a Venezia, le fabbriche di porto Marghera non soffiano più fumo mortifero. Questa città sta morendo, penso. Questo Paese sta marcendo, penso.
E qualcuno pensa che sia a causa degli stranieri. E molti non sanno che l'idiozia li abita, ed è indigena. Siamo quasi arrivati, mi rimetto le cuffiette. Guardo l'acqua bassa della laguna, le rotaie arrugginite del tram, ascolto gli Smiths che cantano " it's time the tale were told/ of how you took a child/ and you made him old...". All'improvviso una botta, una frenata, una donna senza culo col segno bianco della ricrescita, urla. Tolgo le cuffie. Davanti al bus il ragazzo giace a terra immobile.
Nero
Senti le mani impiastricciate, l’odore come di ferro, il silenzio perfetto, profondo, nero. Ti senti sfinito, pronto a rinascere.
Se mi dedichi la tua attenzione ti descrivo com’è il mio nero. Lo so che sei curiosa, che vorresti chiedermelo ma non ne hai il coraggio: sai stare al mondo, sai quello che si deve dire e quello che non è il caso di pronunciare, e sai che c'è un limite oltre il quale si scade nella maleducazione. Ma io mi ti concedo, ti esonero dalla fatica di esporti, dall’approfittare di me per soddisfare una tua curiosità; di cui però io sento il rumore, l’eco, lo scalpitio che procede a o di marcia, e che tu domi come fosse una bestia feroce, anziché una parte di te.
Hai visto che lei non vuole stare con sé? Hai visto come scarta quel che non le piace, come fosse un corpo estraneo? Vedi che ti consiglio sempre il giusto, che la tua è comione?
Ascoltami: il mio nero è come il buio assoluto, è come essere in una stanza senza finestre, senza porte, senza luce: non c’è altro che quel nero profondissimo. Se vuoi davvero immaginarlo, se desideri immergertene totalmente per un poco, in concreto, ti devo chiedere di provare a diventare me, e per far questo devi lasciarti andare e guidare. Ti chiedo uno sforzo: cerca di essere completamente qui, ora, senza pensare ad
altro. Ecco: ora sei me. Immagina di essere in quella stanza di cui ti dicevo, in quel buio; e di non essere più solo. Accanto a te c’è una persona, una donna. Se ti va di giocare fino in fondo, chiudi gli occhi, ascoltami, seguimi: ecco sei con me in quella stanza totalmente buia, di una tinta di nero che così non l’avevi mai nemmeno immaginata.
A volte arriva come un lampo, è una voce, un dolore, una distrazione, ma a subito. È una scossa che squassa e annulla ogni pensiero.
E sai che c’è qualcuno con te. Lo sai perché l’aria è diversa, c’è ora un odore nuovo, che cerchi da subito di codificare, che respiri facendolo scorrere tra le pareti delle narici, che arriva alla mente, che corre giù fino al diaframma. E poi ascolti, senti il suo respiro, ne segui il ritmo, provi a sincronizzarti con esso, fino a che, poco alla volta, lo penetri, lo interiorizzi, diventi amico dei suoi segreti biologici. E ancora, immagina le mani che cercano il suo corpo: inizi dall’alto, coi polpastrelli, dai capelli e piano scendi verso il viso, collo, spalle, seno, pancia, la fessura che piano s’inumidisce, le cosce, ginocchia, piedi; e da lì risali da dietro, dal basso verso l’alto stavolta. Senti i pori della sua pelle farsi evidenza a contatto con le tue mani, senti il sudore, il calore, le vibrazioni dell’eccitazione.
E poi con la lingua e la bocca rifai il percorso perché vuoi conoscere il suo sapore. Labbra e lingua ti trasmettono il suo sapore. Rotei, infili, sfiori, lasci scie. Ora sai tutto di lei. Conosci il suo profumo, il suo respiro, il suo corpo, il gusto della sua pelle. E ora tocca a lei. Ti annusa, ti ascolta, ti tasta, ti assaggia. Alla fine sapete tutto quello che c’è da sapere, tranne l’aspetto formale, perché il nero impedisce qualsiasi immagine, ma tanto non serve, non più: l’intimità annulla la forma. I vostri corpi si bastano, la mente lavora con gli altri sensi, le sono sufficienti. La vista è un senso sopravvalutato, di cui però si può fare senza, solo se acuisci gli altri. E se tutto fosse così, risponderebbe allo stesso meccanismo di conoscenza neurologica e sensoriale. Se il mondo fosse nero, sarebbe comunque il mondo. Il mio nero è così, si accende senza colori, si adegua ad un modo altro di esistere, fino a tararlo alle sue necessità.
E tornano ancora quei lampi, quelle voci, la bava della rabbia ti colpisce, ti penetra e improvvisamente scompare. Tienila a bada, domala e gustala: ancora per poco.
Questo è il mio nero, il mio buio felice, la mia scala di valori non visiva, la mia consuetudine esistenziale. E adesso ti dirò il resto, quello che non potevo dire prima. È stato semplice dopo che eri venuta, dopo che ti avevo saziata, ti avevo resa felice, condurti al di là. Stringere un poco, sentire lo spessore della giugulare, il sangue che scorreva, stringere ancora un po’ fino alla fine del respiro, della circolazione, della coscienza. Sei ata dagli spasmi dell’orgasmo alle convulsioni, alla scomparsa definitiva della luce, alla pace, in un unicum spazio-temporale. Ho infilato le dita nelle tue orbite, ho estratto le due palle mollicce, me le sono ate sulla pelle, le ho toccate, annusate, leccate, le ho inghiottite, e poi basta. Ho soltanto voluto regalarti un’esperienza, una morte felice, dopo il culmine del piacere. Così non subirai la violenza della vita, la sua decadenza, la sua progressiva e inarrestabile fine.
Hai solo ubbidito alle scosse violente procurate da quelle voci che ti ordinavano il da farsi.
Ora conosci anche tu la profondità, la consistenza del mio nero.
Addio
Visita www.priamoedit.it
o segui Priamo su
Twitter
Meligrana Editore Via della Vittoria, 14 – 89861, Tropea (VV) Tel. (+ 39) 0963 600007 – (+ 39) 338 6157041 www.meligranaeditore.com [email protected]
Scopri tutti i nostri ebook su
Smashwords.com
Cristiano Prakash Dorigo
racconti
Meligrana Editore – Priamo
-
Copyright Meligrana Editore, 2015 Copyright Priamo Editore, 2015 Copyright Cristiano Prakash Dorigo, 2015
Tutti i diritti riservati – All rights reserved ISBN: 9788868151164
Presentazione di Emanuele Pettener
Immagine di copertina: Marco Crestani
Meligrana Editore Via della Vittoria, 14 – 89861, Tropea (VV) Tel. (+ 39) 0963 600007 – (+ 39) 338 6157041 www.meligranaeditore.com [email protected]
Priamo www.priamoedit.it [email protected]
INDICE
Frontespizio Colophon Licenza d’uso
Cristiano Prakash Dorigo Copertina
Presentazione Premessa
Capitolo 1 (2001)
L’ultima scena (in tredici brevi atti) Scrittura e cura Verso casa Il mio nonno è un supereroe (in tuta blu)
Capitolo 2 (anni 2000)
Carnevale Cronache dai quotidiani Sto galleggiando nell’aria aggio Incontri (omaggio a Guccini e Mestre) Quaranta Segnali onirici di mezza estate (e di mezza età) Traversata Skype Piove Nero
Priamo Meligrana
Licenza d’uso
Questo ebook è concesso in uso per l’intrattenimento personale e non può essere rivenduto o ceduto ad altre persone. Se si desidera condividere questo ebook, è necessario acquistare una copia aggiuntiva per ogni destinatario. Se state leggendo questo ebook e non è stato acquisito per il vostro unico utilizzo, si prega di acquistare la vostra copia. Grazie per il rispetto all’impegnativo lavoro di questo autore.
Cristiano Prakash Dorigo
Operatore sociale da circa vent’anni, scrive racconti e testi vari da una dozzina. Prima pubblicazione nel 2002: racconto incluso nella raccolta “È da tanto che volevo dirti”, a cura di G. Caliceti e G. Mozzi, edito da Einaudi tascabili (Stile libero); racconto breve in raccolta di autori veneziani sul tema librerie in occasione dei 70 anni della libreria toletta (2003), edito da Marsilio; racconto inserito nella raccolta “Parole contro”, edito da Libreria zero, Padova (luglio 2008); co-autore (con Marco De Rosa) del libro di racconti “Biografie Incerte”, edito da Mare di Carta, Venezia (settembre 2008); autore del libro di racconti “Homo sapiens nord est”, edito da Mare di Carta (2011); “Un sinuoso contenitore smussato” (ebook), Priamo e Meligrana editori (2014); co-autore (con Marco Crestani) de “Attorno al tepore del cuore” (ebook) Priamo e Meligrana editori (2014); co-autore (con Marco Crestani) de “L’anarchico Emilio” Priamo editore (2014).
facebook: https://idoc-pub.futbolgratis.org/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="abc8d9c2d8dfc2cac5c485cfc4d9c2ccc4ebccc6cac2c785c8c4c6">[email protected]
Presentazione
’Esar e scrivar xè beo
“’Esar e scrivar xè beo,” mi scrive Cristiano Prakash Dorigo, di risposta alle mie congratulazioni per l’uscita di Un sinuoso contenitore smussato (Priamo/Meligrana, 2014). “Leggere e scrivere è bello.” È una frase che mi dà allegria: fare una cosa perché la si trova bella. E che altra ragione ci dovrebbe essere? Si noti inoltre: prima della scrittura viene la lettura, la congiunzione le mette sullo stesso piano, ma c’è poco da fare. Prima viene la lettura, ha un vantaggio di bellezza, si può dire. Che beo. Comunque, capita un anno fa che nei miei pigri vagabondaggi per la rete incontri un racconto di Cristiano Prakash Dorigo che mi piace molto, e mi piace molto anche quel nome risonante di cristianità, di India e di Venezia: insomma – malgrado si sia entrambi personcine riservate e financo timide – ci si scrive e si decide di trovarci, la scorsa estate, a Venessia naturalmente.
L’appuntamento è a Campo Santa Margherita nell’ora più dolce di un caldo pomeriggio di maggio, e Venezia è più sensuale che mai: i riflessi rosati sulle case, l’ebbrezza studentesca, le ragazze che sorridono, i libri stretti al seno, e i gatti che se ne infischiano. Noi ci sediamo al bar rosso, detto così perché è tutto dipinto di rosso, e si comincia a ciacolare, e lo so che la frase è abusata, ma è vero: mi sembra di conoscerlo da una vita! Sapete quando ci si sente a proprio agio e non c’è la necessità d’indossare una maschera? Che forse è una maschera anche quella, chi lo sa. Con Cristiano, quella volta e poi per tutta l’estate, si parla spesso di maschere. Di vanità, di poesia, di Bolaño, delle sfumature di certi avverbi, e ancora di maschere. Del resto Cristiano xè Venessian, purissimo, sestiere di Dorsoduro,
corte Mazor. Ora a Venezia non ci vive più – “purtroppo,” mi dice – ma ci lavora, e la vive attraverso la sua professione di operatore sociale, quotidianamente, profondamente, la sonda, la assorbe, vi trasfonde tutta la sua energia, le calli, i campi, i masegni son tutti suoi: poi scatta una foto e me la manda in Florida. El xè oro. Orbene, si ciacola, si beve uno spriss, poi un altro, mi fa una testa così con Bolaño. Del resto Cristiano ha, per i libri, una ione non affettata, una ione in cui non manca mai un elemento fanciullesco di stupore, soprattutto quando scopre un artista nuovo, come Bolaño appunto, che alla fine m’ha costretto a leggere. Senonché ci scambiamo pure le cose che abbiam scritto noi (Cristiano ha debuttato con un racconto inserito in un volume curato da Giuseppe Caliceti e Giulio Mozzi, È da tanto che volevo dirti, Einaudi, 2002) e grazie a Dio abbiamo entrambi superato quella fase primordiale che prevede i complimenti reciproci e lui mi dice chiaro chiaro quel che gli è piaciuto delle mie cose e quello che non gli è piaciuto, e mi fa domande, s’incuriosisce, si stupisce, e poi torna a parlar di Bolaño, ovviamente.
Io la sua raccolta di racconti Homo Sapiens Nord Est (Mare di Carta, 2011, appena riproposta in e-book dallo stesso editore) me la porto in treno per Roma, e inizialmente sono scettico, la materia mi è lontana per gusto (roba dura, da stomaci forti) e in effetti il primo racconto non mi convince del tutto. Poi però è un crescendo, un’immersione, e fondamentalmente mi entusiasmo per un motivo: Cristiano possiede un modo di scrivere che è tutto suo, originale, come chi ha l’esclusivo interesse di raccontare una storia e raccontarla nel modo più efficace possibile, lasciando risplendere ogni piccolo angolo del quadro, dal dolore dei protagonisti al portaombrelli sullo sfondo; vi è una forza viscerale nella sua scrittura (fatta di scatti, rimbalzi, ritorni), e trovo alcuni racconti davvero bellissimi (tutti quelli della seconda metà, essendo il libro architettato in due parti) e uno intitolato “Tatto” che – scusate, ma è così che sento – è formidabile, dove i sentimenti di un uomo lasciato da una donna vengono esplorati come non avevo mai letto prima. Perché Cristiano (e certo il suo lavoro gli ha dato esperienza) è un esploratore d’umanità – affascinato, partecipe, mai giudicante, mai onnisciente – e non è mai kitsch, non è mai falso. Insomma, per farla breve, come ogni volta che trovo qualcosa che mi sembra bello, chiamo subito l’editore di Priamo, Marco Crestani – di solito scrivo una
scheda, ma stavolta sono in treno, e poi si tratta di un libro già pubblicato – e chiedo a Cristiano di mandargli una copia di Homo Sapiens Nord Est, e Marco se lo legge da cima a fondo, e anche a lui il libro piace moltissimo, contatta Cristiano, gli chiede se ha dei racconti nuovi, s’incontrano anche loro a Venessia, al bar rosso (io nel frattempo me ne son già tornato in Florida) e si bevono uno spriss e parlano di maschere, di vanità, di poesia, dei libri che hanno letto, dei libri che vogliono fare, e poi Cristiano gli parla di Bolaño. Emanuele Pettener
Premessa
I quindici racconti qui raccolti sono divisi in due capitoli e offrono una visione interiore di fatti che hanno uno sfondo sociale, ambientati nel nuovo millennio.
Capitolo 1
(2001)
L’ultima scena (in tredici brevi atti)
1
È ato del tempo, tanto, troppo, mai abbastanza. Ricordo ogni particolare, anche i dettagli più stupidi, insignificanti, minimali. Era settembre, New York fremeva di incantesimi vitali, e sembrava pronta ad abbracciarti. E noi la lasciavamo fare, ricambiandola. La giornata iniziava con la luce del mattino che entrava sfacciata dalle finestre, appoggiandosi sui miei occhi stanchi, dopo una notte tormentata. Non capivo il tormento; non ce n’era ragione: eppure c’era, sfidando la logica. Ero in compagnia della felicità, che dormiva beata accanto a me, con la sua schiena nuda, dopo avermi regalato un’altra giornata di gioia. Eravamo arrivati da due giorni e forse subivo ancora il fuso orario. Ad esempio per assurdo ricordo la colazione di quella mattina e quello che ci siamo detti. Nella sala dell'hotel dove c'era il buffet self-service, ci eravamo riservati un tavolo strategico, da cui servirci senza farci troppo notare. Avevo insistito io per sederci là, con l’ombra del provinciale che si muove con circospezione. Dopo il secondo giorno, a dire il vero, avevo capito che non serviva, che eravamo tra quelli che mangiavano meno, e che gli americani non giudicano un diritto: se la prenotazione prevedeva “breakfast”, si pagava l'opzione, e si era
padroni di fare ciò che si voleva senza dover patire il sentimento dei furbi. Quella mattina ridevamo perché c'era un tipo che aveva il parrucchino, e di fianco, il suo fidanzato aveva i capelli lunghi fino alla piega delle ginocchia. Dopo colazione siamo risaliti in camera. La scena nella mia testa è cinematografica. Lei esce dalla doccia, un asciugamano legato sotto le ascelle e uno in testa. La guardo e lei capisce subito. Con l'indice fa segno di no. La guardo implorante, scherzoso. - “no che poi mia sorella mi guarda e capisce subito. E io voglio che prima ti conosca: non voglio lasciarle troppo spazio di immaginare ciò che vuole. Lei è la sorella maggiore e ha sempre detto la sua. Stavolta voglio che ti veda, che vi parliate, che tu la faccia ridere come fai ridere me, e poi tutto quello che vuoi…" Nel finire la frase compie con la mano il gesto goffo della tigre che graffia l’aria. - “va bene, vorrà dire che se i due fidanzati mi invitano... Poi non lamentartene...” Avevamo riso insieme con un'armonia complice. Amavo farla ridere, vedere il bianco dei denti, gli occhi che luccicavano, che finivano sempre col lacrimare, il corpo che si scuoteva un poco. Scusa se mi interrompo, ma ricordare il suo sorriso è più di una fitta; è un male fisico, una forza contorcente. Prima che uscisse ci siamo baciati. Un bacio innamorato è un piccolo evento, o magari una cosa da niente. Nessuno però ne parla mai, forse perché contiene un'intimità che non ha il suono delle parole, l'estetica del racconto. Ma quel bacio, quella tenerezza, quell'intesa. La sua bocca profumava di acqua di mare.
Era morbida, era vorticosa, era abissale, era totale. Lei è uscita, ma prima mi aveva scritto tutte le istruzioni coi nomi delle stazioni, mi aveva ricordato di comprare i biglietti della metro, di non dimenticare portafogli e telefono, di non guardare le altre ragazze. Eravamo teneri e stupidi, volutamente, come lo sono tutte le coppie innamorate, che sono uniche, che sono tutte uguali. Era uscita abbandonandosi a un ultimo gesto slanciato, naturale, come possedesse la naturalezza e l'agilità, e le contenesse nel corpo e nell'istinto. La vedo ancora in presa diretta - macchina in piano sequenza, senza mai staccare, da inizio a fine scena -. Appena curva sul mobile accanto alla porta, il piede destro sulla punta, il braccio che comanda il movimento della mano - una mano bellissima, affusolata, dita lunghe - che attacca il post-it sulla porta. Uscendo mi guarda un secondo appena, sorride, chiude la porta dietro sé. La scena finisce. È l’ultima scena.
2
Il foglietto con le istruzioni prevedeva qualche fermata di metropolitana. Ma a me piace guardare la città dalla strada; la metro la prenderò magari al ritorno con lei, pensavo. Volevo vedere le facce di questa città che contiene tutte le razze del mondo, volevo che mi costassero fatica, che mi costringessero all’incontro col miscuglio di umanità e alla digestione di così tanta roba. Volevo impararla, memorizzarla, riuscire a raccontarla.
Mi sono preparato, vestito come mi aveva consigliato lei per impressionare la sorella, senza insospettirla: “vola basso ma mai rasoterra”, mi aveva detto. “Non fare citazioni, ma se si tira fuori l’argomento libri, non risparmiarti; non nominare le parole “economia” o “finanza”: ricordati che lei lavora al centro del centro finanziario mondiale che deve sopportare degli stronzi superintelligenti dieci ora al giorno quando le va bene che deve fare due ore di viaggio tra andata e ritorno e che non ne può più di sentire parlare in modo generico di un mondo che combatte ogni minuto una guerra per il destino dello stesso con gente che conosce solo la verità per averla letta nei libri o sentita in tivù o vista nei film e non ha la più pallida idea di cosa sia la ferocia dei potenti che governano i nostri destini”. L’aveva pronunciata tutta senza prendere fiato, senza punteggiatura, ripetendo forse quello che la sorella le aveva detto dei rammolliti alternativi che le aveva presentato prima di me. E siccome con me voleva andare fino in fondo, voleva fermarsi e concedersi il sogno, la realizzazione di un sospetto - non il principe azzurro, ma un più concreto amore da amare-, la concreta libertà di un legame vero, il consenso della sorella era l’ultimo prerequisito per iniziare un progetto complesso e naturale: la sua nuova famiglia, l’adultità, la scommessa fatta, vinta e incassata; che tutta la fatica che aveva fatto, tutte le energie che aveva investito, erano state riconosciute e premiate. Il solo pensiero, se fosse stato solo a livello di pensiero, mi avrebbe pesato talmente tanto che me ne sarei scappato; ma invece tutto questo, era lei; la sua intelligenza, la sua bocca, il suo culo, le sue mani, il suo sorriso.
3
L’avevo conosciuta dopo averla vista un giorno a Venezia. L’avevo notata subito, e me ne ero subito, un poco, innamorato.
Una bionda coi capelli che non arrivavano alle spalle, che lasciavano il collo scoperto a metà. Il collo che avrei voluto baciare subito, in quell’istante. Eravamo in un bar all’aperto; io aspettavo un amico scrittore, lei era con un amico, uno che stava facendo un dottorato alla facoltà di chimica: un chimico, diceva lei, destinato a fallire professionalmente, visto che la chimica stava scomparendo da Venezia: Marghera è una tomba futuribile, un morto, come una palla in discesa, che sta rotolando verso la scomparsa definitiva in una discarica, aggiungeva. Ricordo il suo sorriso che evidenziava i denti, che sembravano meno bianchi di quanto siano in realtà a causa del pallore della pelle: un pallore che ho amato subito. C’era vento, vedo ancora la grazia del gesto di mettersi il cardigan leggero a coprire spalle e braccia, colpite dalle brevi raffiche di una parentesi d’estate stranamente fresca, che aveva preceduto l’afa che l’avrebbe stretta pochi giorni dopo. Lei parlava, sorrideva, rideva, e io la guardavo a tratti, distraendo lo sguardo dagli occhi dell’amico scrittore, che mi stava dicendo che Hemingway secondo il suo parere era uno sopravvalutato. E io rispondevo che sì, forse aveva ragione; e poi aggiungevo che avrei voluto leggere un romanzo in cui Kundera mi raccontasse di quella bionda che conteneva un’interiorità misteriosa e radiosa; un racconto che avrei letto, imparato a memoria, decantato ad alta voce come una poesia. Ad un tratto il cardigan era volato via; il suo amico si era subito alzato per recuperarlo, ma aveva trovato me, già pronto a consegnare il maglioncino in cotone morbido e leggero nelle mani di quella donna che mi aveva ringraziato, guardato con gli occhi sorridenti, a cui avevo sorriso ma non troppo perché, al solito, mi vergognavo di mostrare alle donne che mi piacciono, che mi piacciono. Poi avevamo ricominciato a parlare di libri con l’amico scrittore, concordando su alcuni punti, discordando su altri. Ma non era importante; l’unica cosa che contava era potersi concedere alla bellezza, all’intimità, alla sensazione che l’amicizia concede riposo e verità,
anche se non pronunciate da parole, ma da quello che si sente, che non si verbalizza per non sprecarlo. E lui aveva visto e capito, e aveva accettato il mio ascolto a tratti distratto. Non sempre si può essere al centro dell’attenzione, ma non sempre si è in grado di accettarlo.
4
Ci eravamo poi ritrovati durante una manifestazione in cui io leggevo un pezzo davvero brutto di un altro autore, cui avevo aderito per far sì che il mio nome diventasse un’abitudine a cui non rinunciare, in quell’ambiente abitudinario e conservativo e settario. “Ci siamo già visti da qualche parte?” aveva chiesto lei. "Non solo visti: ti avevo proprio guardata per almeno un’ora", rispondevo, lasciando uscire parole dalla mia bocca che non avevo ordinato al mio cervello di pronunciare. Lei aveva sorriso, mi aveva dato la mano per presentarsi: “mi chiamo Samantha con la th finale, aveva detto”. “Samantha? io Eugenio: piacere!”. Le avevo baciato la mano e avevo visto stendersi sul suo braccio la pelle d'oca; la stessa cosa che mi aveva scosso dentro, come se il solo toccarla fosse un esperimento chimico che sprigionava un'energia cui potevamo assistere, senza sottrarcene. Era arrossita un poco e subito aveva aggiunto: non mi chiamo Samantha, ma più banalmente Teresa, aveva aggiunto, senza lasciarmi la mano. È qualcosa che non dipende da noi, scegliersi: è il destino, dio, le leggi di sopravvivenza della specie, la storia già scritta.
Quando accade, lo si sente; si sa che è così, che così dev'essere, e che la verità ha una sua natura semplice, benché si manifesti raramente. E allora bisogna subito afferrarla, lasciarsi penetrare, nutrirsene. E così abbiamo iniziato ad amarci subito, perché avevamo sentito entrambi la stessa “cosa”.
5
Ero uscito e il rumore di New York mi aveva invaso. Le auto, coi loro aggeggi brutali, i tubi di scappamento, i clacson, le urla, le sirene, il giallo dei taxi; non si accorgevano che tutto questo congiurava contro la loro salute di cittadini di una città mostruosa, la cui mostruosità, in effetti, costituiva, assieme alla sua vitalità, un fascino unico. Ogni città ha dei segreti stratificati: certe città americane, contrariamente a certe altre europee, non li nascondono; te li mostrano in modo trasparente. New York contiene il meglio e il peggio che un ambiente urbano possa offrire, e non si vergogna per questo: afferra ciò che puoi ma attento: se cadi ti fai male; e se cadi, e lo vuoi, c’è sempre il modo di rialzarsi e ricominciare. Cadere, crollare, confliggere, conoscere, costruire, castrare, ricominciare. Avevo praticamente assorbito tutta quell’energia subitaneamente, e mi ero dimenticato di quanto avevo pensato pochi minuti prima. In strada si percepiva un qualcosa difficile da spiegare: facevamo tutti parte di un progetto segreto, di cui nessuno conosceva dimensione, scopo, obiettivo, ma che era decisivo per le sorti della città, e per i suoi abitanti. Una metropoli in cui ci si può sentire terribilmente soli, ma mai isolati; una città che lascia decidere a te il tuo destino, te ne offre la possibilità, te ne chiede la responsabilità, ti presenta infine il conto. Camminavo immerso in questi pensieri, di cui mi vergognavo un po’ per la loro ordinarietà, ma che non riuscivo a evitare.
Al contempo sentivo scorrere dentro me la grazia del privilegio di aver incontrato una delle donne più notevoli al mondo, che amavo e che mi amava, in modo talmente naturale, e perciò perfetto, da non sembrare vero, pur nell’evidenza della realtà, che testimoniava il contrario. Avevo messo la mano nella tasca dello zaino dopo averlo tirato giù dalle spalle, aperto la cerniera, tirato fuori il cellulare quando ho sentito un rumore lontano, un boato indistinguibile, eppure di una qualità speciale di straordinarietà. Un BOATO la cui resa onomatopeica avrebbe bisogno di lettere MAIUSCOLE: un misto tra un ruggito ROARR, e uno scoppio BUMM. Avevo guardato il cellulare, quando un ragazzo mi aveva urtato, facendomelo cadere a terra: correva, scappava, non mi aveva nemmeno guardato. Raccogliendolo da terra, e successivamente alzando lo sguardo, avevo notato la fumata nera che si alzava decisa nel cielo.
6
Ci avevo impiegato qualche secondo a collegare il rumore, il fumo, il ragazzo; avevo messo a fuoco lo sguardo e avevo visto: il fumo veniva dalla torre di fronte a quella dove lavorava Giulietta, la sorella di Teresa. A quel punto, in quel preciso istante, ego, hic et nunc, in quella città estranea a me, che non conoscevo, di cui sapevo più quello che si dice che quello che è, ho sentito che una morsa tenera mi legava agli altri, a quel ragazzo che mi aveva urtato ed era scappato, aGiulietta, a Teresa, ai suoi colleghi, a tutto il grattacielo, a tutta la città, a tutto il mondo, al cosmo, all'universo, all'infinito, alla concreta e spessa valenza del male; il male che mi faceva quell’immagine, quel rumore, quei pensieri d’amore e morte. Il tempo era durato più del solito, come sempre, come tutto il tempo, in cui il dolore è padrone e costringe il resto all’esilio. L’ufficio di Giulietta era al non so quale piano: qualche decina e rotti. Vedevo il retro del grattacielo rispetto a dove c’era l’aereo, il fumo che usciva da dietro. Cercavo di calcolare l’altezza in cui l’aereo, di cui vedevo un pezzo minimo spuntare da non capivo bene dove, si era conficcato; volevo capire se poteva essere l’altezza dell’ufficio, se potessero essere proprio lì, le due sorelle
più importanti della mia personale storia d’uomo. Non so a che distanza ero dal posto; non sapevo esattamente niente: non ero in grado di razionalizzare alcunché. L’unica cosa che so per certo è che correvo, e forte, come mai, come avevo visto fare solo nei film, verso la direttrice visibile della mia probabile tragedia. Mentre correvo, la gente era inebetita, immobile con lo sguardo rivolto alle torri, oppure correva disorientata verso un altrove che fosse distante da lì.
7
La prima volta che avevo fatto l’amore con Teresa, era stato un evento. Avevo avuto già diverse relazioni, numerosi incontri occasionali, talvolta dal punto di vista dell’immaginario erotico maschile, più eccitanti. Ricordo una ragazza che aveva voluto farsi scopare in piedi, nascosti dietro la colonna di una chiesa veneziana, eccitata all’idea di essere lì a Venezia, di poter raccontare qualcosa alle amiche americane, ma soprattutto di poter essere intravista casualmente da qualcuno: un ante, oppure un prete, o chissà chi. Ansimava in modo eclatante, e sembrava godersela davvero, benché al contempo la sentivo lontana; o forse lo ero io. Con Teresa invece non era una questione di tecnica, di bravura, di eccitazione: con lei era semplice, era spensierato, e totalizzante. Erano incursioni in zone temporalmente e spazialmente sconosciute. Un distacco dalla dimensione terrena, dove il controllo, la mente, l’abitudine, perdevano il loro senso e significato. Sembrava fosse normale, pur essendo, in modo evidente, straordinario.
8
Mentre correvo verso le torri, mi era venuto il dubbio che avessi sbagliato, e che non fosse quella, la torre: che fosse l’altra, che fosse stata l’agitazione, la paura, a indurmi a pensarlo. Mentre correvo senza sosta, pensavo che aver pensato all’amore mentre mi sentivo in guerra, era una sorta di aggiustamento biologico per pareggiare i conti. La scena nel frattempo aveva assunto la forma di una paradossale concretizzazione dell’impossibile. Un aereo di linea che si va a conficcare in uno dei grattacieli più conosciuti del mondo; a raccontarla, nessuno ci crederebbe. Il tempo era incontenibile, non si poteva calcolare; frammenti accelerati si alternavano ad altri di immobilità. Correndo avevo iniziato a sudare, mi ero tolto lo zaino dalle spalle, tolto la felpa, messo all’interno dello zaino, riposto questo sulle spalle, il sudore che si attaccava alla schiena. Correvo mentre accanto a me, i suoni, le espressioni, i movimenti, erano preda di quegli stessi sbalzi temporali che io stesso percepivo. I movimenti erano lenti, sincopati; oppure all’improvviso acceleravano in modo incontrollato: un consumo d’energia fuori misura, verticale, stroncante. Ma io dovevo correre, e correvo. Ad un certo punto si sente il suono prorompente di un aereo. Mille sirene ovunque non riuscivano a coprirlo. Poi un boato. Vetri fughe di gas incendi sirene urla fumo grigio bianco nero frammenti volteggianti pianti disperazione cemento imprecazioni cantilene catatoniche immobilità frenesia caducità limite. Un tempo di simultaneità. La descrizione di un tempo senza grammatica possibile e onnicontenente e esatto e sbagliato.
La testa agisce da sé, dirige lo sguardo verso l’alto, guidato dall’istinto, e gli occhi vedono e registrano. L’aereo arriva, curva un poco a sinistra, s’infila dentro l’atra torre, deflagra. La mente paralizza tutto, fuorché le gambe, che continuano a correre, in accordo coi muscoli involontari, e invade ogni cellula, uccidendo ogni speranza, ogni felicità futuribile, ogni prospettiva, ogni colore che non sia il nero. A quel punto il panico è la precondizione necessaria alla sopravvivenza, al non soccombere a se stessi, alla reazione. Guardo le torri gemelle, immagino le due sorelle quasi identiche, gemelle: la mia mente gioca con le parole, costruisce arzigogoli, avanza similitudini: sta evidentemente preparandosi ad affrontare la bestia del dolore feroce.
9
Ricordo la prima volta che siamo stati insieme. Il pudore pareva un orpello inutile, l’intimità era arrivata prima e ci aveva accolti con semplicità, come ospiti amici con cui è bello stare insieme. Il suo corpo ed il mio avevano perso peso e consistenza, e si fondevano senza fatica. Il letto su cui eravamo stesi roteava vigorosamente, il tempo aveva cessato il suo avanzare e lo spazio era con-fuso nei suoi normali confini, alle nostre misure. Eravamo talmente giovani ed elastici, e anche vecchi in confidenza, che la dolcezza e la foga e il vigore e la debolezza faticavano a frapporsi in quegli abbracci in cui, materia e nulla, compenetravano ogni atomo. Eravamo consapevoli di essere venuti a contatto con l’assoluto, con un genere di esperienza sovrumana.
10
La città era diventata un sospiro, una sospensione temporale. Due aerei che si infilano in due enormi grattacieli sono un evento inimmaginabile. Ogni fantasia appariva ridicola, ogni pensiero impensabile, ogni speranza disperata. Ero in una specie di guerra inutile e improvvisa, in un’angoscia senza preavviso, e ne ero invaso. Tutto vibrava, un fragore sotterraneo borbottava, un calore insopportabile si spargeva su ogni cosa. Il senso di tutto ciò non poteva esistere. C’è stato un momento in cui tutto si è fermato. A vederlo da fuori, lo si può immaginare così: sei al cinema e nel bel mezzo di una scena, la pellicola si blocca. La dinamicità della trama, il coinvolgimento emotivo, la sequenza logica si fermano a loro volta. La percezione del tempo svanisce e perde significato. All’improvviso però la scena riprende.
11
Non lo so, non so più niente. Vedo soltanto. E sento. E percepisco e incamero.
In un dato momento, il momento ics, viene giù tutto. Il crollo a vederlo sembra logico. L’aria si satura di un fragore totale. Si alza una massa enorme, che continua a gonfiarsi e crescere fino a coprire la città, il mondo, l’universo. Presto ne siamo tutti ricoperti, non si può parlare, respirare. Il mio paradiso terrestre si ricopre di detriti, di polvere, terrore, stupore, dolore, rabbia, spossatezza. Mi sforzo di ricordare il suo volto, il corpo, gli occhi, gli zigomi, le labbra, la schiena, ma non vedo niente, solo buio polveroso, anche sui ricordi. Mi pare invece di sentire l’odore del suo alito quando mi parlava la notte e mi raccontava di quando era bambina, dei giochi che faceva, delle fantasie che aveva, di cui facevo già parte, anche se non mi conosceva, ma mi sapeva già vivo e presente nella sua carne virginale e innocente.
12
Non so come, non so perché, mentre correvo, chiudevo gli occhi, abbassavo la testa e mi lanciavo a più non posso contro un immenso camion dei pompieri. L’impatto è stato devastante, ma non sentivo niente. Il sangue mi aveva riempito la faccia; ne sentivo l’odore attraverso le narici, e il gusto, mentre mi colava verso il collo. L’odore e il gusto sapevano di rosso, di infinite variazioni di tono di quel colore, avevo pensato prima di crollare a terra. Quando mi sono svegliato, circondato da facce serie, affidabili, traboccanti di pietas e comprehensio gratuite, come se l’aver partecipato tutti insieme a una catastrofe collettiva potesse, se non condividerlo, ammansire il dolore di ciascuno, affidandolo ad un dolore più grande: una sorta di fossa comune,
collettiva, in cui seppellire e commemorare il proprio lutto. Ho chiuso gli occhi arreso, e ho pianto. La sua esistenza non è mai finita.
13
Al suo funerale ho pronunciato queste parole: “ Io non credo in Dio, e ho molti dubbi sulla natura della fede. Credo e conosco la meraviglia dell’esistenza e oggi sono qui per testimoniare anche la conoscenza dell’eternità. Teresa mi ha regalato la fede nella vita, la fiducia, mi ha convinto che esiste la possibilità di incontrare la magia, la totalità, la trascendenza carnale, la felicità eterna di un istante. Auguro a tutti noi di poter incontrare ancora una persona come lei, che è unica e insostituibile, ma come ci insegna la scienza, se un fenomeno accade una volta, è per definizione ripetibile. Io sono stato fortunato, anche se non potrò mai più essere felice.
Vi voglio raccontare brevemente questo episodio: eravamo a Parigi e eggiavamo per il lungosènna. Ad un certo punto, mentre camminavamo, ci siamo fermati: eravamo circondati da una fiumana di gente, e come accade spesso anche a Venezia, c’era un brusio multilingue che ci circondava. Ci tenevamo le mani e sentivamo le stesse “cose” (come altro definire quell’insieme di tutto, che ha una sostanza e un peso, e che al tempo stesso non è visibile ed è impalpabile?). C’è stato un istante in cui siamo stati totalmente investiti da una forza immane,
di fusione e comprensione, quasi insopportabile. È difficile da spiegare a parole poiché si tratta di sensazioni, e la sua essenza, non prevede l’uso del linguaggio. Eravamo al contempo frammentati e solidi, particelle atomiche e un tutt’uno con le persone, il brusio, l’aria, il cielo, il fiume, le pietre, le stelle. E tutto ciò, era contenuto in una sorta di amore universale, globale, che non prevede giudizio, commento, pensiero, ma solo abbandono. In questo momento di commozione sento di amare tutti voi, di provare un sentimento autentico di comione, e non chiedo altro che questa sensazione, che ormai è certezza, la possiate percepire anche voi: l’eternità esiste, e può essere solo qui, ora. Teresa mi ha concesso la grazia di credere in me e in questo. E anche che tutto ciò, e cioè io e questo, in realtà non esiste, in quanto la realtà è un’illusoria costruzione mentale. Esiste solo un flusso energetico, che è, e che è amore. Grazie”
Scrittura e cura
Ci sono improvvisi momenti di lucidità in cui si percepisce che tutto è diverso da come pensiamo che sia. In questi brevissimi istanti di risveglio qualcosa, dentro, si modifica. La prospettiva da cui di solito si osserva la vita, si apre all’ignoto. E tutto è limpido, cristallino. L’ignoto, in questi frangenti, si trasforma in chiara comprensione di quanto, normalmente, non riusciamo a essere ciò che in realtà siamo: di quanto ci difendiamo, di quanto abbiamo paura di ascoltare ciò che sentiamo, di quanto siamo lontani dalla nostra verità. Comincio in modo desueto la mia lettera. Ti scrivo, come sempre, per condividere quel che sento. Il nostro rapporto epistolare non soffre la distanza; anzi, ne trae beneficio; scava una maggiore intimità, e confonde, mischiandola, la verità oggettiva da quella percepita, sottraendosi così al dovere della cronaca, aggiungendo però sostanziose digressioni. Dura da molti anni l’abitudine di scriverti. All’inizio a penna, su dei fogli rubati alla fretta, col furore inoffensivo della giovinezza. Adesso con il computer, con una più tranquilla pulizia di stile. Adesso sembriamo immobilizzati, al confronto; in realtà, e lo sappiamo bene, abbiamo solo spostato i luoghi delle frequentazioni: da fuori, estetici, scintillanti; a dentro, profondi, autentici - nelle intenzioni, almeno -. Quando eravamo più giovani, eternamente tardo adolescenti, ci raccontavamo il ato e il futuro, fantasticando continuamente sulle infinite possibilità che la vita poteva offrirci.
Che male poteva fare, rielaborare ciò che era stato o sognare il divenire? Vanagloriosi, ostentavamo con fierezza la nostra trascuratezza e l’aria un po’ sconcertante degli alternativi alla forma. Non era in verità solo la rappresentazione di una concreta scelta sociale; o almeno non la percepivamo così. Era forse più un mascheramento, che doveva testimoniare come ci sentissimo diversi, come non riuscissimo ad essere come avremmo dovuto, come le regole del mondo fossero stritolanti, e alcuni vivessero in apnea, accontentandosi di un filo di respiro, mentre noi volevamo farlo a pieni polmoni. E allora: politica, musica, droga, sesso; tutti eccessi provinciali, baldorie fittizie, mascheramenti, recitazione. Tutti perfettamente omologati ad uno stile di vita parallelo che riuniva i diversi. Come collocare il disagio se non obliando pensieri pesanti, contestando le minuzie, i particolari, spesso senza valore? Quante avventure abbiamo vissuto che meritino un posto significativo nella nostra memoria; quante volte ci siamo sentiti perdutamente vivi? Recentemente ho letto alcuni libri che mi hanno offerto alcuni interessanti spunti. Dicevano, in sintesi, che lo scopo della vita è conoscersi, bastarsi, accettare la propria solitudine ed unicità. Da quando l’ho fatto, percepisco un continuo lavorio interiore; come ospitassi una presenza roditrice che sgranocchia le mie insicure certezze. Con la mente riesco a relegare in periferia queste scomode ed irriverenti idee; ma da lontano, come il riverbero di un’eco, sento che vivono e hanno lacerato la solida corazza delle mie sicurezze. Infatti non riesco più ad ignorarle, e ad ogni bugia, finzione, furbizia, reagisco come se ne fossi allergico. Così ho deciso di accettarne l’ineluttabilità, constatando che, forse, quel vago senso di vuoto che provavamo, e che continuava con sempre maggior insistenza ultimamente, potrebbe trovare risposte.
Ma devo spiegarmi meglio a te. Quando sono fuori casa, in un qualsiasi posto, osservo le persone. Ricordi quando eravamo ragazzini? Era un vero so per noi! Era come avere un’immensa lente d’ingrandimento attraverso cui guardavamo chiunque ridendo e scherzando come pazzi. Adesso no; adesso non m’importa niente di come uno si veste, si pettina, s’atteggia; adesso la differenza è dentro, è un profondo senso d’estraneità, di non appartenenza: a niente e nessuno. Non tollero più l’ipocrisia, le maschere, la finzione. Non accetto più di continuare ad abitarle, a non riuscire a staccarmene, se non con atti di attenzione, che mi restituiscono ciò che sono: l’inquilino di un robot, uno che presta le sue maschere alla messinscena della vita formale, sociale, riconosciuta come autentico compromesso, introiettato da tutti, riconosciuto come sola soluzione all’ammaestramento della bestia che ci abita e che teniamo a freno con surrogati di felicità consolatoria. Sono sconvolto da come questi elementi siano uniti, dalla simultaneità con cui si sono manifestati: sono solo, unico. Allora, mi dico, val la pena riflettere su come è strutturata l’esistenza, sull’organigramma sociale; su chi sa e organizza, attribuendosi in malafede un potere quasi divino, creando fasulle occasioni relazionali, reciproche tentazioni a pagamento, pretestuosi vizi e bisogni indotti, inibendo al rango di potenziale cliente, la persona e il suo istinto. So perfettamente cosa diresti a questo punto, a come mi guarderesti, con quegli occhi profondi, con la testa che annuisce; non esti la voce, ma io le sentirei comunque le tue parole, i tuoi pensieri, come tu sentivi i miei: diresti, senza parlare, che è quello che dici da sempre, che sostieni fin da quando eri poco più di un bambino, con cui ti sei sempre scontrato con me fin quasi a fare a botte. Ma non è quello: è qualcosa di più, qualcosa di più grande della sociologia, della psicologia; è un seme, soffocato, spesso talmente nascosto da dimenticarcene. È una libertà che non può essere soppressa dal pensiero razionale, dalle regole
sociali, dalla mistica delle religioni: è religione pura, è nudità totale, è segreto svelato. Non serve ribellarsi e rompere tutto; ci vuole una ribellione qualitativamente diversa, più concreta che apparente, più efficace che violenta, più libera che ribelle. Ho raccolto ogni singola lettera che ho scritto e, a rileggerle facendo attenzione all’ordine cronologico, se ne ricava l’evoluzione personale, quella ambientale, la precarietà e mutevolezza di idee che sembravano, se contestualizzate, promesse di fedeltà eterna. A volerle poi interpretare con occhio smaliziato, se ne potrebbe ricavare un diario di vita, un interessante rapporto epistolare che rivela senza filtri, complice la confidenza e le reciproca benevolenza. Emergono, tra gli altri, elementi che fanno pensare allo scampato pericolo, al superamento di una precarietà romantica e tenera che rimanda ai giocolieri circensi. Come equilibristi su una corda tesa, bisognava fare attenzione a non cadere, a raggiungere l’altro capo con calma, senza sbagliare. Confesso che più vado avanti, più lascio al tempo che fu la frenesia del fare per fare, del baccano per sottolineare la presenza, del seguire l’istinto senza cercare di comprendere quale natura lo spinga, lo faccia pulsare nel corpo e nella testa. Ora, ciò che sono, corrisponde sovente a ciò che faccio: mi sento autentico, coerente. Insomma, molto di quel che eravamo, non fa più parte di quello che sono adesso; se non in forma costitutiva, latente, che magari emerge quando un sentimento forte, l’agitazione, la distrazione mi invadono: allora, in quel caso, ciò che ero viene fuori, fa un balletto, e poi torna a cuccia. Volevo dirti quello che penso ora dell’amicizia, del bisogno di stemperare le divergenze, smussare gli angoli, accettare di farsi pungere dalle nostre spine aguzze, dagli sbalzi d’umore, dalle piccole cattiverie. Più ci si conosce, più emergono le parti in ombra, gli istinti primordiali, le parti nascoste dal bisogno di estetizzare quello che non ci piace di noi.
Solo scoprendosi, osando dire il taciuto, pur temendo di farsi male, ma non rinunciando a parlare, certamente faticando, ma con bontà, si riesce a rivelare l’interezza, l’unità disgregata senza più temere il giudizio. E così il rapporto di amicizia, più di quello amoroso, verbalizza i pensieri sparsi e disordinati che pensiamo continuamente, e che risultano sempre parziali, occasionali. Sforzandosi di comunicare, di costruire ragioni, pur anche irrazionali, nude, rivelate nella loro genesi ereditaria, familiare, ambientale, e perciò incolpevoli d’esistere, accettandole, confortati dalla reciprocità. Non è facile non giudicare, tenersi a distanza di sicurezza dai propri umori, dal proprio sistema valoriale. Ma quando si è amici, e lo si è davvero, la benevolenza supera e sublima questi tratti; e le contraddizioni, le difficoltà, diventano terreno neutrale in cui confrontarsi, anziché confliggere. Ogni tanto riguardo il video di allora. Ce ne sono un’infinità, così come le tesi a o. È impressionante, lacerante, e tu, lo so, ne saresti contento. Ti piacerebbe l’estetica barricadera, il contesto, il potere evocativo subliminale, la nettezza della sproporzione dei ruoli e dei giochi di forza. Nessuno mi può controllare se io sono centrato, se sono me, se sono autenticamente integro. La ribellione, la rivoluzione, sono sempre state della borghesia illuminata; talmente illuminata, da aver portato vantaggi concreti soltanto a loro stessi. Mentre la carne da macello si faceva massacrare, loro stavano già tessendo alleanze, contandosi, sfregandosi le mani, supponendo l’incasso. Non è rompendo una vetrina, gambizzando qualcuno; no, quello serve solo a misurare i giochi di potere, a consentirgli di giocare la parte delle vittime, riciclandosi nella nuova veste di chi subisce la violenza altrui.
Io sono libero se sono me, se riconosco le sovrastrutture, se intuisco le trappole delle ideologie; se me ne libero; se accetto infine di non appartenermi, perché io non sono più, sono sparito, fuso, compreso nel gioco dell’esistenza. Lo sai bene, l’avevo promesso che da allora, da quel preciso momento, avrei cambiato la mia vita; l’avrei vissuta cercando di comprendere. Sono ancora legato a quella promessa: ho iniziato un cammino che non prevede ripensamenti, che include in sé la pazzia e il suo antidoto, che mi ha segnato rivelandosi, talvolta, faticoso e pesante ma, al tempo stesso, autentico. Da quando ho cominciato a scriverti ho allontanato e controllato il dolore; è stato il mio modo di (r)esistere, di accettare gradualmente quello che era successo, anche se ho imparato, ormai, che i cambiamenti avvengono all’improvviso, come con un salto quantico, una discesa senza freni. Non si cambia un poco alla volta, se non nei ristretti confini del preordinato, del finto destino dell’educazione formale. Già da prima della nascita abbiamo un percorso prestabilito: feto-neonatobambino-adolescente- giovane-adulto-vecchio-defunto. Un cambiamento vero invece, accade: da un momento all’altro, eravamo in un certo modo, siamo qualcun altro. Perché ciò avvenga, bisogna accettare la parte ignota di noi stessi, mollare le sicurezze, abbandonare le abitudini, vivere ciò che è senza più pensare a quello che fu, senza preoccuparsi di quel che sarà. Esordivo dicendo che ci sono momenti di lucidità che illuminano brevi istanti; che da questi momenti se ne esce con l’intuizione che esiste un modo diverso di essere. Questi mi hanno aiutato a capire che ero sopraffatto dalla paura di soffrire e che dovevo reagire. In questi anni ho comunque vissuto, sono cresciuto, ho costruito rapporti, ho lavorato. Quest’abitudine di scriverti era il mio segreto; era il luogo in cui lasciare e conservare tracce di me che non sapevo, altrimenti, come esprimere. Mi ha aiutato a capire, a dire la mia verità, a sentirmi al sicuro come avessi un
rifugio intimo e inespugnabile; come avessi uno specchio che riflette la coscienza. Poi, per caso, senza avvisare, arrivano quei momenti e cogli il senso di quello che accade, della vita; che tutto inizia e finisce. L’immagine mostra una marea umana, fumo, fuoco, vetrine distrutte, urla, pestaggi violenti, cassonetti. È il caos assoluto, sfondo ideale per giustificare qualsiasi cosa. Il terzo Battaglione Lombardia dovrebbe raggiungere i black block che stanno distruggendo tutto. Si fermano però davanti al corteo delle tute bianche. Sono isolati dalla centrale operativa. Non si dirigono verso Via Tolemaide. Due Defender rimangono isolati in Via Caffa alle 17.22. Retromarcia verso Piazza Alimonda. Incastrati da un cassonetto, una delle due jeep riesce a partire. Rimane solo quella con l’ausiliario Mario Placanica e il suo compagno alla guida. A quattro metri e diciannove dal mezzo ci sei tu, in amontagna e canottiera. Forse vedi la pistola in mano al carabiniere, sollevi un estintore che trovi in strada. Ore 17.27 di venerdì 20 settembre 2001. Uno sparo. Un urlo “ODDIO. CAZZO. NOOOOO”. La jeep guidata da Filippo Cavataglio fa retromarcia e ti calpesta due volte. I tuoi amici spostano il corpo. Io guardo il video e vomito e piango.
Sto dicendo che questo comunicare, felice ma ermeticamente chiuso, sta esaurendosi. Che questo bisogno di interiorità sta cambiando luoghi e confini, che sarà più scoperto; che sono pronto a pagare il prezzo di questa nudità. Sto tentando di dire che val la pena rischiare, aprirsi, buttarsi nel mucchio, esprimere selvatichezza e dolcezza, respirare a pieni polmoni. Sto dicendo che da quando te ne sei andato ho imparato molte cose, ho scoperto piccole verità, ne ho scartate altre, ho capito che bisogna accontentarsi di questo. Quello che so, che riconosco come immutabile, è frutto di intuizioni e non di pensieri: questi ultimi hanno il limite oggettivo di essere contenuti all’interno delle regole del gioco, dei conformismi o, al contrario, da moti di ribellione a questi. Ma, appunto, gli appartengono. La conoscenza scientifica sta dimostrando che più si approfondisce il sapere, più questo è relativo e instabile, fragile, tenuto in piedi fino alla successiva scoperta, che lo abbatterà. Sto dicendo che ho compreso a fondo che si deve cominciare da noi stessi per rivoluzionare lo status quo. Sto dicendo che solo da poco tempo ho accettato di averti perso per sempre e che devo continuare a vivere perché ho finalmente la voglia e la forza per farlo. Addio Carlo, ti ricorderò per sempre.
Verso casa
Percorrendo la strada verso casa dei miei genitori guardo a caso la strada. Rivolgo lo sguardo ai masegni, alle rive, alle case, ai canali. È un’osservazione distratta, a cui i pensieri non fanno caso, continuando a fluire inarrestabili. A volte incrociano un ricordo, pescandolo dall’immensità dell’inconscio, o da chissà dove. Se rimango anche un solo secondo in contatto con quello che sento, mi spavento e scappo verso altri pensieri inoffensivi. Trovo conforto nell’estenuante gioco della mente, che di solito mi stanca fino alla spossatezza. Dovrei preoccuparmene, penso. Dovrei. Ma non posso. Potrei aprire il portoncino di casa con le chiavi, ma avviso sempre col camlo. Regolarmente mio padre mi apre, benché ogni volta gli dica che i tre suoni brevi in sequenza, sono il mio segno distintivo: ma fanno parte delle consuetudini famigliari, quelle che niente e nessuno modifica, mai. Non vorrei disturbarlo, visto che è già occupato ventiquattro ore al giorno con mia madre, con la casa, con i farmaci, con le normali faccende che sono pane quotidiano per molti, ma un incubo per un uomo vecchio stampo, che ha sempre lavorato fuori casa, e che è vissuto in un’epoca in cui l’uomo impersonava il marito, e la donna la moglie, con ruoli precisi, distinti, rigidi. Ho sempre l’impressione che qualunque azione aggiuntiva, possa comprometterne la stabilità, fino a rompere l’equilibrio. Ma ci si adatta a tutto nella vita, soprattutto alle abitudini.
La casa dei miei è un piccolo appartamento al primo piano di una palazzina di tre, più soffitta: un tempo apparteneva tutto alla mia famiglia; al secondo ci abitava mio fratello, al terzo mia nonna. Prima dei miei ci abitava una zia, e prima di mio fratello uno zio. Nei miei pensieri, avrei voluto trasferirmici un giorno; ma i pensieri sono effimeri aggi che nascono da profondità ignote, e poi svaniscono per evaporazione. Tranne quando diventano fissi, e si trasformano in ossessioni, che tormentano e prendono possesso di tutto, fino alla dominazione tirannica: ma per fortuna non è il mio caso, che coi pensieri ci gioco, trasformandoli in parole scritte. ando per il campo col pozzo attorno al quale da bimbo correvo in bicicletta, inizio a provare una stretta al cuore e un brontolio alla pancia. Il corpo si esprime col suo linguaggio viscerale, penso. E credo che mi stia dicendo che non si può che stare così, quando si è al punto nodale. Questi giorni sono davvero brutti, e non lo sono mai abbastanza; avevo calcolato male, pensavo che sarei stato più male, che sarei dovuto svenire pur di non vedere, con gli occhi rossi, ciò che vedo quasi ogni giorno. Assistere al consumo di un’esistenza fondamentale, dovrebbe manifestarsi in modo più letterario, più cocente, più e di più di qualsiasi altra cosa si riesca a immaginare. E invece è tutto così ordinario, così banale, che il dispiacere non può che aumentare, proprio in funzione del paradosso per cui l’insopportabilità si manifesta con tanta merdosa abitudine. Forse è il conto alla rovescia, che ad ogni numero scalato, avvicina gradualmente al punto zero, al niente, alla morte. Di fatto, mentre suono il camlo con le chiavi in mano, mentre osservo per l’ultima volta il pozzo sperando di trovarvi ricordi consolatori, mentre apro la porta lentamente, per contrastare la fretta di arrivare, che coinciderà col bisogno impellente di scappare, mi dico che niente è mai come ci siamo immaginati dovesse essere, e che per scriverne, bisogna accettare di guardare quello che è, per quello che è, senza fisime né allegorie, o enfasi, o imbrogli. I gradini che mi separano dalla porta sono pochi, soltanto una normale rampa di scale; e oltre la soglia, l’anormalità avrà la sua scena mortifera e asettica, su cui potrà esibirsi in tutta la sua cruda sostanza.
Salgo i gradini lentamente, come se il tempo potesse offrirmi una tregua, un breve ristoro, una vaga distrazione; ma non è così, e lo so bene. Mio padre mi aspetta sulla soglia, come sempre. Ci scambiamo un saluto e ci guardiamo negli occhi, con lo sguardo che comunica quello che le parole non possono dire, per un taciuto senso del pudore. Ci sono anche mio fratello e mia madre, nella stanza che funge da astanteria e soggiorno. Ci salutiamo con un gesto della mano, mentre vado verso mia madre, che saluto con un timido bacio sulla guancia. Lei ha gli occhi chiusi, ma li apre, rivelando la presenza del dolore e della morfina, che agiscono assieme nell’organismo e nella coscienza, rendendola morbida e anestetizzata, seppur inaspettatamente vigile. Mi dice ciao, con una voce che fatico a riconoscerle, e che esce filtrata dalla guerra interna al suo corpo: un coacervo di cellule e molecole che battagliano furiose e silenziose. La stanza è organizzata al bisogno. Un tavolo diventato multiuso, dove mio padre mangia, legge, fa i cruciverba della settimana enigmistica, appoggia telecomandi, telefono, farmaci, pane, frutta, e una notevole quantità di altri oggetti utili ad affrontare il tempo da seduti. E poi. La libreria con lo stereo. Le sedie dove ci accomodiamo. La poltrona con appoggia-piedi dove mia madre a gran parte della giornata. E c’è anche la televisione, sempre accesa, che col suo brusio di sottofondo sostiene l’insostenibile peso del silenzio. Mio padre, mio fratello ed io ci guardiamo spesso, alternando sguardi destinati alla tivù, ad altri rivolti alle finestre, alle pareti o al pavimento.
E i più frequenti verso mia madre, la mia genitrice, colei che mi ha costruito giorno dopo giorno dentro sé, quando ancora non ero che un divenire, un futuro incistato nella carne di una giovane donna. Cercando conforto nella delicatezza, proviamo a verbalizzare parole che abbiano un peso specifico inconsistente, in quanto coscienti che ogni pensiero galleggia nel presente di quella stanza, dove il futuro sembra escluso. Appena si dice qualcosa che la riguarda, o che sembra alludere a lei, pur nell’apparente sopore, interloquisce come chi percepisce in forma diretta o indiretta, ogni lontana allusione. Assistere all’eloquio di una persona apparentemente dormiente, guizzare puntuale, scaturisce in noi, apparentemente vigili, una sorta di stupore inesorabile. Colpisce diretta quell’inaspettata lucidità, e lascia una traccia che impiega un po’ di tempo a svanire dall’aria. La televisione produce inutilità, aderendo pedissequa al suo compito di agente distraente. Ci appoggiamo a quella potente vuotezza di senso, perché l’impossibilità di trovarne qualcuno, di senso, di giustezza, di adeguatezza, ci paralizza e costringe a esserne sgomenti testimoni. Non è giusto, penso, affrontare la propria impotenza senza esserne minimamente preparati. Ma so di pensare l’ovvio, e penso che la vita costringe continuamente a convivere con le proprie imperfezioni e limiti. Il mio affetto è paralizzato, soffocato, interdetto; non riesco a convivere lucidamente coi miei sentimenti: sarebbe una strage, un massacro, un suicidio. Devo abituarmi alla rassegnazione, esercizio che non è mai stato il mio forte. Le sue gambe sono uno spettacolo inconsueto e straziante. Sono avvolte da una sorta di pellicola trasparente che va cambiata spesso, in
quanto nella parte bassa, dal ginocchio in giù, continua a secernere un liquido trasparente che parrebbe sudore, o acqua. Guardandola ho la netta percezione mnemonica di quando mi ospitava nel suo ventre rotondo, di quando galleggiavo. Quel liquido mi ipnotizza: liquido amniotico di ritorno. Vorrei ritrovare quella pace acquosa, invece del tormento solido che mi assilla. All’improvviso un’immagine incredibile: la tivù interrompe la scemenza che stava trasmettendo, per mostrare le immagini di un aereo che si infila in un grattacielo. Chiedo a mio padre di alzare un poco il volume. Sono così stanco, così confuso e insieme lucido, così nascosto dietro ai meccanismi di difesa che mi riparano dalle percezioni sensoriali, che niente può toccarmi. Eppure quelle immagini mi si aggrappano addosso, mi scuotono: è proprio così, è New York, e un aereo di linea si è conficcato in una delle torri gemelle. La stupefazione è pari a una scossa: sembriamo tutti riemergere dal torpore autoindotto del preludio al lutto. Mia madre con gli occhi sempre chiusi, chiede di spiegarle cosa sta succedendo. Glielo diciamo, ma forse non può credere alle nostre parole, e infatti apre appena gli occhi per vedere coi suoi, la materializzazione dell’impossibile. La concezione del dolore è spesso compromessa dalle immagini che ne abbiamo introiettato, le quali derivano da letture, da visioni di film, da racconti orali che ne enfatizzano la natura e la potenza. Bisognerebbe invece distinguerne le diverse gradazioni, le sue varie manifestazioni. Mia madre si era accorta di non stare bene perché aveva un dolore sordo, nascosto da qualche parte, che più che sfogarsi in modo devastante, esisteva e si faceva notare con la sua onnipresenza.
Fatti esami, scoperte cellule tumorali: incontro diretto con l’inconsistenza del futuro. Eppure il dolore, quel genere di dolore - come se esigesse un genere -, quasi paralizza. Ferma la progettualità riducendola a capriccio. Sbaraglia la mistica del momento presente trasformandola in condanna subitanea. Vorrei avvicinarmi a lei, toccarla, dare consistenza e precedenza al tatto, ma non riesco. Guardo quelle gambe che continuano a spurgare liquido, e penso che deve trattarsi di energia che abbandona il corpo, in quanto ormai inutile. La distanza andrebbe ridotta e trasformata in occasione di vicinanza, prima che diventi rimpianto. Dovrei non solo ascoltarmi, cosa che riesco a fare a tratti, ma anche ubbidire a quei bisogni di contatto, a quella tenerezza che infonde imbarazzo, a quella debolezza che comunica perentoria che ci si deve abbandonare a ciò che si sente, senza indugi. Ma non lo faccio. Spesso nella vita non ho fatto ciò che avrei voluto e dovuto, e quasi sempre ho fatto quello che ho potuto, potendo purtroppo troppo poco. L’attenzione viene attratta verso lo schermo della tivù: il fumo esce dal grattacielo e tutti i canali trasmettono la medesima scena; qui e nel mondo, perché New York è la città mondiale per eccellenza, e perché non si sa, non si capisce, non ci si raccapezza: la sorpresa però non impedisce, al massimo rallenta, la sensazione di tragedia. Sento una sorta di sollievo per quello che provo, e me ne vergogno: la condivisione in mondovisione della precarietà dell’esistenza. L’inevitabile deflagrazione del dolore intimo e pubblico e condiviso, eppure non
per questo sopito: al massimo distratto da quello altrui. All’improvviso mio padre si alza dalla sedia, si veste, dice di dover uscire per andare al supermercato. Non mancano tante cose a dire il vero, dice. Noi annuiamo: quello che manca là dentro è la distrazione, l’aria pura, la luce del sole, il profumo di settembre, il bisogno di vedere altre persone, la voglia di scambiare due chiacchiere leggere. Lui è presente giorno e notte, da mesi ormai. Ha solo bisogno di una parentesi di assenza. Appena chiusa la porta di sotto, in perfetta coincidenza temporale, guardando le immagini delle torri, arriva un altro aereo che si schianta contro l’altra torre. L’impatto accade nel momento esatto in cui si chiude il portoncino, come se fosse un doppiaggio surreale. Stavolta l’impatto è molto più basso rispetto all’altro. Il fumo nero che continua a fuoriuscire dalla prima torre viene investito da una fiammata; il commentatore è impazzito, non sa cosa dire e ciancia parole come fosse una sorta di lallazione, di balbettio: è la conferma che non ci sono parole che possano descrivere l’impossibile. Io e mio fratello ci guardiamo sgomenti, impietriti. Ci voltiamo in simultanea verso mia madre che ha gli occhi aperti. Capiamo che ha visto anche lei tutta la scena. Li richiude subito, pronunciando con una voce accartocciata dalla gola secca, cinque parole che sembrano una sorta di autoprofezia: “È la fine della vita”. Lei è sempre stata fulminea, a volte annichilente: frasi pronunciate senza premure e censure. Quel che si pensa va detto, saranno gli altri a farne ciò che vogliono o possono. In questo caso quello che posso, confligge aspramente con quello che voglio.
Vorrei risolvere la questione, mi piacerebbe sconfiggere il male invisibile eppure così solido, attenuarne la potenza nefasta e distruttiva e trasformarla in energia che guarisce; ma quello che posso è solo accettare ciò che è, e quel che è, mi è tuttavia quasi insopportabile. Ritorna mio padre dalla eggiata mascherata dal bisogno della spesa frugale. Ha un’espressione riposata, o forse meno tirata del solito. Mentre svuota il sacchetto lo guardo, e mi viene in mente che quando l’ho visto entrare ho pensato a lui come ad uno speleologo, che dalla terra si cala nelle viscere del pianeta dove tutto è scuro, silenzioso, eterno e precario, senza appoggi sicuri. Gli raccontiamo del secondo aereo, e lui ci guarda con stupore e stanchezza, rispondendoci che secondo lui il caso non esiste, e qualsiasi fenomeno ha una spiegazione, che però spesso rimane inaccessibile. Questa volta, aggiunge, però, non c’è nessun mistero: si tratta di qualcosa di grosso, di importante, di un evento che erà alla storia, e che ci ricorderà per sempre dov’eravamo e cosa facevamo, nel momento in cui tutto ciò è accaduto: “In una matrioska di dolore privato e diffuso”, dice. Mette via la spesa e torna al suo posto, dopo aver dato un’occhiata a mia madre, in particolare alle gambe. Si siede sulla sua sedia, sposta per poi rimettere al loro posto gli oggetti sopra il tavolo, prendendo il telecomando, abbassando di una tacca il volume. Da una torre si vede una macchiolina nera che scende. È un uomo che si butta nel vuoto dal grattacielo in fiamme. Per un istante, brevissimo, ho colto il silenzio che galleggia nella stanza. Un silenzio pesante, gravoso; il prodromo del mutismo che riempie la solitudine, il dolore forzoso, il lutto. Dev’essere stata una condizione condivisa, poiché da subito, a partire da un colpo di tosse appena accennato, ricominciamo a riempirlo con le chiacchiere, con la televisione, col movimento involontario del corpo che rifiuta l’immobilità.
Mia madre apre appena gli occhi, ci guarda, e con un filo di voce pronuncia queste poche parole: “Vorrei potervi consolare, ma non riesco a farlo nemmeno con me. Mi manca l’energia”. Prima di chiudere gli occhi, accortasi che la stiamo guardando tutti, con un cenno del viso ci indica la tivù. La prima torre sta crollando. Una catastrofe di polvere, di detriti, di fumo, di debolezza, di odio, di disfatta. Sento che la mia gamba sinistra cedere, facendomi perdere l’equilibrio. Poi l’altra torre, stessa scena al rallentatore. L’altra gamba mi si piega. Le torri crollano e io cado a mia volta, in una simultaneità paradossale. Guardo le torri, poi mia madre, e sento un dolore abnorme che mi stringe la carne, che mi contorce gli organi interni, che mi squassa la testa. Guardo da terra quell’ammasso di polvere indescrivibile, che copre tutto, che nasconde ogni cosa, che sembra fuoriuscire dallo schermo ed entrare nelle case, nelle narici, nei polmoni fino a interrompere il respiro. Penso all’ecatombe, alla catastrofe, al numero di morti. Penso che mia madre sta lasciandomi e che tutte quelle morti, tutto quel dolore, tutta quell’oscena e pornografica rappresentazione della disperazione, sono niente rispetto a quel che sento, e che mi piega ancor più all’evidenza che la sofferenza è inevitabile, incontrollabile, onnipotente. E non è niente di quello che ho immaginato, che ho pensato, creduto, supposto, prefigurato; no, è molto peggio e molto meglio, è materica e spirituale, è preghiera e bestemmia, è fine e inizio, è tutto e nulla. Striscio verso la poltrona, prendo la sua mano, la carezzo con la guancia. Sento che mi sta lasciando e che non posso fare niente.
Capisco che così è, e così dev’essere, e provo finalmente una sorta di liberazione, di leggerezza, di soavità, di pace, di pienezza. Era l’11 settembre 2001. Ho letto e scritto molto da allora. Ho cercato di capire, di affondare nel mistero e nel senso. Ma l’unica lezione che ho imparato è che bisogna accettare tutto.
Il mio nonno è un supereroe (in tuta blu)
Definizione di salute dell'OMS (organizzazione mondiale di sanità): stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia",
Dal settimo piano di un palazzo di Campalto posso vedere la laguna e i suoi due estremi: la città vecchia dal ato glorioso, il porto turistico con quegli assurdi mastodonti bianchi, e la zona industriale, che un tempo fu modernità futuribile, e ora soltanto una mortificazione estetica. Gli estremi mi hanno sempre attratto, e ne riconosco l’evidenza in ciascuno di noi, benché sia tutt’altro che facile accettarne la presenza. Tutti noi conviviamo con la parte buona e quella cattiva, che spesso reprimiamo e nascondiamo in zone d’ombra.
… scusate… sento dei i… Mia figlia arriva, mi strattona un poco i pantaloni; dal basso dei suoi pochi anni, vuole uscire in bicicletta: io pedalo e lei sul seggiolino; io parlo e costruisco concreti mondi immaginari, e lei ascolta, perdendovisi. Vuole la favola che mi raccontava mio nonno. Scendiamo in garage, prendiamo la bici, usciamo. La laguna da una parte, in silenzio, e l’innocenza perduta per sempre, sin da quando il veleno delle fabbriche, portato dal vento, depositava una polvere biancastra, simile al talco. Lei mi guarda, braccia conserte, occhi severi, come a dire: allora, mi racconti la
favola della tuta blu e i guanti bianchi? Sì amore, hai ragione. Eccola…
Questa che ora racconterò, è una sorta di favola: quella che mi raccontava sempre mio nonno quando ero bambino, e che ora sentirete. Ho pensato che, adesso che sono adulto, la cosa migliore sia usare le parole, ma anche le immagini dei luoghi in cui è ambientata. Vi ci accompagnerò in bicicletta: la bicicletta rossa di mio nonno. Dovreste fare un ultimo sforzo: immaginare me bambino, e lui, mentre siamo ai margini della laguna e guardiamo l’acqua e i pesci. I pesci non parlano, lo sappiamo tutti. Eppure a volte, mentre lui parlava, pensavo che eravamo anche noi là con loro; e uno di loro iniziava a raccontare… Dunque…
C'era una volta una città piena di fabbriche che fumavano tanto. Facevano talmente tanto fumo che sembrava che andassero a fuoco.
Ecco, iniziava così la favola preferita di mio nonno. Dovete sapere che mio nonno era una specie di eroe, ma guai a chiamarlo così; si arrabbiava proprio: lui diceva di essere una persona semplice, che faceva il suo dovere fino in fondo, e che purtroppo, non essendocene tanti, che fanno così, lui sembrava esserlo. Ma appunto, non lo era.
Vi dico un segreto a bassa voce, che rimanga tra noi: per me, dentro di me, io lo vedevo con la sua tuta blu e i suoi guanti bianchi, che combatteva contro avversari potentissimi, apparentemente invincibili, che però non riuscivano mai a batterlo. Ma non gliel'ho mai detto. E non so se avrei dovuto.
Dunque… dicevo: c'era una volta una città piena di fabbriche che fumavano tanto. Facevano talmente tanto fumo che sembrava che andassero a fuoco. Dentro queste fabbriche ci lavoravano tante persone. C'erano attività diverse tra loro, che servivano a costruire molte cose. In alcune si trasformava il petrolio in carburante per far funzionare le automobili, le moto, gli autobus, i camion, eccetera. In altre si facevano altre cose, le più incredibili. Mio nonno lavorava in una che produceva CVM, che serviva a fare il PVC, il quale si usa per fare tantissimi oggetti di plastica. Ma voi lo sapete che dalla plastica si riesce a costruire di tutto? Ma proprio tutto tutto. Qualche esempio? Vi presento il biberon, il tubetto di colla vinavil, i dischi in vinile, il computer, l’ipod, il vecchio stereo, il divano in Moplen, le tapparelle, il linoleum, i piatti di plastica, i farmaci e le bottiglie d’acqua. E in fin dei conti nessuno pensa di rinunciare al computer, al biberon, di
comprare l’acqua con le bottiglie di vetro che pesano tanto, solo perché la produzione industriale è pericolosa. Eh no! La modernità ha le sue regole, i suoi costi, le sue seduzioni, i suoi riti, e nessuno sembra più farci caso. Adesso tutto corre, sempre, senza sapere dove va e perché, e senza pensare se questa corsa faccia bene o meno, se serva a qualcosa, se non sia inutile. Se fimo un esperimento e togliessimo tutto ciò che in quest'epoca è inutile, rimarrebbe quasi niente.
C’è però un’eccezione, diceva. La follia degli uomini a volte si trasforma in qualcosa di buono e di bello. E iniziava a fischiettare: poche note, distanti l’una dall’altra, semplici come la verità, leggere e profonde; lo faceva chiudendo gli occhi, come si perdesse per un istante in un luogo magico, dove tutto è armonioso, liscio, pulito; il suo volto si rilassava e per pochi istanti la felicità sembrava abbracciarlo. Succedeva solo quando fischiettava i brani di Satie, un musicista se ormai morto, amico di un poeta, un certo Cocteau. I dischi di vinile, diceva, a volte rendono la vita spensierata e musicale.
Ma dicevo della plastica. Il problema è che la plastica inquina molto, ma molto molto. C'è un'isola nell'oceano pacifico, grandissima, formata da rifiuti di plastica. L’acqua è l’elemento originale, da cui tutti proveniamo, e pensare che una parte di noi potrebbe essere plasticosa è davvero brutto.
Ecco, mio nonno lavorava in questa fabbrica.
Bisogna dire che lui e i suoi colleghi erano molto contenti di poterci lavorare. A quei tempi un posto di lavoro in fabbrica significava poter vivere la propria vita, abitare in una casa dignitosa, crescere i figli, comprarsi la televisione, fare i regali ai loro nipoti. E così, con le loro tute blu, andavano in queste fabbriche immense a lavorare, felici di sentirsi utili al sistema produttivo della vita, in cui c’è posto per tutti, dove si hanno diritti e doveri, e bisogna rispettarsi l’un l’altro.
Pensate che aveva un collega che era addirittura un poeta: si chiamava Ferruccio. Andava in fabbrica e scriveva le poesie, le leggeva a tutti i suoi colleghi, che erano contenti di farsi accompagnare in mondi immaginari costruiti dalle parole. Che poi, aggiungeva sempre mio nonno, la poesia è una specie di mezzo di trasporto che ti conduce alla verità: e questa è un po’ difficile da capire, ma ha un buon sapore.
Nel suo lavoro a volte bisognava pulire le autoclavi, che erano degli enormi contenitori dove venivano lavorate le sostanze chimiche. Ricordava che appena entrati, appesi letteralmente a delle corde, lui e i suoi compagni, erano stati colpiti dalle esalazioni come se invece che gas, fossero sostanze solide che li prendevano a schiaffi, da quanto forti erano. Colpivano gli occhi, il naso, la bocca, la gola, i polmoni. Ti penetravano come fossero dei vermi che strisciavano dentro il tuo corpo; vermi che ferivano, che facevano male non solo al corpo, ma anche alla mente, all'orgoglio, annientando l'onore, la volontà, il sentirsi esseri umani. Avrebbero voluto scappare, uscirsene, ma se uno di loro lo avesse fatto, avrebbe messo in pericolo l'equilibrio e la vita dei compagni di lavoro. Quando tutto era finito, rimanevano solo tracce di polvere bianca, apparentemente innocua, simile a talco, o zucchero a velo. E lacrime, che uscivano dagli occhi di tutti i presenti. Ma non erano lacrime di pianto: le lacrime erano finite, ingoiate dal mostro che ormai li possedeva tutti, che abitava la loro carne, che scuoteva i loro nervi, che beveva il loro sangue.
Che abitava e ammalava i loro corpi.
E così, a un certo punto, il numero di tute blu, cominciava a diminuire. Non se ne accorgeva quasi nessuno, perché erano in tantissimi là dentro, all’inizio; ma mio nonno aveva iniziato a farci caso. Gli sembrava strano che tutti avessero male: lo stesso male per tutti. E così non tornavano più a lavorare, e l’allegria in fabbrica diminuiva. Un giorno era tornato in spogliatoio da solo, e gli pareva che il silenzio fosse veramente pesante. Aveva aperto il suo armadietto e aveva trovato una bellissima tuta blu tutta nuova, e dei guanti bianchi immacolati. Al momento non capiva chi poteva averli messi; non sapendo bene cosa fare, l’aveva indossata, si era messo i guanti, per vedere se la misura era giusta. Appena messa, si sera sentito subito leggero. E sulle mani, che da un po’ di tempo erano sempre fredde, sentiva un bel tepore. Era una sensazione strana, un poco magica. Senza farci caso, aveva pensato al sogno che aveva fatto quella notte: volava sopra le fabbriche! Ebbene, proprio in quel momento, mentre stava pensando al sogno, gli capitò di alzarsi da terra, di dirigersi verso una finestra aperta, e di volare sopra la fabbrica, e poi ancor più in alto, fino ad arrivare alle nuvole. Quasi non ci credeva, eppure era vero.
Lui non amava i furbi, diceva che la furbizia viene quasi sempre usata per prevalere sugli altri.
E si sentiva crescere dentro la sensazione che ci fossero tante persone furbe che nascondevano la verità. Persone a cui importava solo la produzione della fabbrica; persone che credevano che se anche un operaio sta male, ce ne sono tanti altri; persone che non badavano tanto ai fumi che facevano respirare alla città; persone che dicevano che il lavoro porta benessere per tutti, e quei pochi che non ne godevano perché poi stavano male, erano in fin dei conti pochi. Mio nonno, invece, pensava che la vita è la cosa più importante che ciascuno ha, e che ha una data di scadenza naturale, e che nessuno ha il diritto di metterci le mani e modificarla a causa dei propri interessi.
E a un certo punto ha deciso di alzare la voce per esprimere le sue idee. Io pensavo che alzasse la voce perché la fabbrica faceva un gran chiasso, ma non era così: “ alzare la voce ha più di un significato: quello che intendi tu, o anche quello di interrompere un silenzio che ai furbi di cui ti parlavo, conviene mantenere”, mi diceva. Così quando finiva il turno di lavoro, si metteva gli abiti normali perché nessuno lo potesse riconoscere, e ha iniziato a fare una super inchiesta da vero investigatore. Non so se usava la lente di ingrandimento come mostrano nei cartoni, ma so che la sua inchiesta è stata molto importante, e ha cambiato il modo di intendere il lavoro, la salute, la sicurezza. La sua idea era semplice semplice: pensava che il lavoro fosse importante, ma che anche la salute lo era, e che ci doveva pur essere un sistema per far sì che questo potesse conciliarsi. Insomma, diceva: se il lavoro serve a produrre dei beni per tutti, perché qualcuno di questi deve rimetterci la salute? Perché non si studia un modo - CHE C’È, CAVOLO! - per far sì che si facciano le cose per bene? Diceva poi, sconsolato, che la risposta era semplice e complicata insieme.
Come la natura intima degli esseri umani.
Una volta gli ho detto che la notte prima avevo fatto un sogno. Lui mi aveva chiesto se mi faceva piacere raccontarglielo. Io gli ho subito risposto di sì! Bene, allora: fallo, raccontamelo, mi aveva detto. “... Stavo camminando da solo in mezzo a costruzioni enormi, con degli altissimi camini. Attorno a me uno strano silenzio, talmente forte, da farmi sentire i rumori dei i che facevo, come se rimbalzassero nei muri esterni degli edifici. Al tempo stesso sapevo che intorno a me tutto funzionava; appena oltre il silenzio, il rumore dei i, sapevo che c'erano persone, che però non riuscivo a vedere. Iniziavo ad avere paura, anche se non sapevo di cosa o di chi, e pensavo " sarebbe bello che ci fosse qui con me nonno”. E in quel momento, come se avessi sentito le parole che stavo pensando, arrivavi tu. Scendevi dal cielo con la tua tuta blu, i tuoi guanti bianchi come la neve, e avevi anche un mantello dello stesso colore. Mi chiedevi se avevo voglia di fare un giro con te, che mi avresti fatto vedere tutto quello che volevo. Senza parlare, ma solo pensandolo, rispondevo di sì! Tu allora mi prendevi in braccio, e insieme volavamo; all'inizio alto alto, così potevo vedere la vastità della zona, e poi giù in picchiata verso le costruzioni, che tra le tue braccia, ora mi sembravano meno imponenti. Entravamo dentro ciascuna di queste e stavamo vicini al soffitto, mentre tutti ci salutavano sorridendo e facendo ciao con la mano. Mi sentivo sicuro e felice e pensavo che quello fosse il momento più bello di tutta la mia vita, e che avrei voluto raccontarlo ai miei genitori, agli amici, alle maestre. Gli avrei detto che avevo volato con te, e che tutti, quando avamo, erano felici nello stesso modo in cui lo eravamo noi”. Al risveglio ho pensato che, più per il volo, ero felice perché ero stato insieme a te.
Lui aveva distolto un momento lo sguardo, aveva raccolto i pensieri, e aveva detto che la felicità, così come la tristezza, sono stati d'animo che vengono e vanno, che durano poco tempo, e che l'importante era saperli accogliere dentro sé, sapendo appunto che durano poco. I sentimenti invece, come l'amore, sono meno frequenti ma più lunghi e importanti. Anch'io sono felice quando sto con te, aggiungeva; e se lo sono, è appunto perché ti voglio tanto bene.
Non so se questa è una favola. Nelle favole ci sono i buoni, i cattivi, il bene, il male. Nelle favole i buoni e il bene stanno da una parte, i cattivi e il male dall'altra. Ma mio nonno diceva che nel mondo reale, è tutto più confuso, mischiato. Ognuno ha in sé il bene e il male, e può scegliere, anche se non sempre è così semplice. Ora che sono cresciuto, ho capito cosa voleva dire.
In breve, ecco cos'è successo. Mio nonno si toglie la tuta blu e i guanti bianchi, si veste normale, e studia. Vuole capire perché molti suoi amici si sono ammalati della stessa malattia. E comincia a capire che proprio nella fabbrica dove lavora, c'è qualcosa che non va. Loro sono continuamente a contatto con sostanze velenose, le quali, con gli anni, possono portare alla morte. Comincia a parlarne, a confrontarsi, ma quasi nessuno gli dà ragione: gli dicono che è pazzo, che si sta mettendo nei guai, che non ci sono prove, che c'è bisogno di lavoro, che se insiste, si rovinerà la vita.
Ma lui pensava che una vita ben vissuta, è una vita in cui il rimpianto ha un piccolo spazio, in cui quello che conviene non è sempre quello che si fa; in cui sentire quello che si fa è giusto, anche se appunto poco conveniente, ma fa vivere bene con se stessi. E infatti ha continuato a studiare, da solo; a informarsi, a tentare di capire. Fino a quando ha iniziato a comprendere.
Mi raccontava che di notte sognava che le fabbriche si animavano, che sputavano fumo nero, che le ciminiere diventavano come braccia e lo attaccavano, ma lui riusciva sempre a scappare perché indossava la sua tuta blu e i guanti bianchi, con cui volava via, giusto in tempo per svegliarsi dall’incubo. Diceva che gli incubi e i sogni sono materiale nostro, che lasciamo là a riposare, o che nascondiamo, o che dimentichiamo. Di giorno mentre noi siamo svegli, loro dormono; di notte quando noi dormiamo, loro si svegliano e ci vengono a trovare. Dopo, mi diceva, si sentiva ancora più forte, determinato, convinto, di fare quello che era giusto fare. Come si fa a sapere che è giusto fare qualcosa?, gli avevo chiesto. Come al solito, non rispondeva mai subito: ci doveva pensare... È giusto fare qualcosa quando senti che non la fai perché è comoda, perché ti conviene, o perché la fanno tutti; no, una cosa è giusta quando nasce dentro di te e non ti abbandona mai; perché sai che non è solo per te, ma che è toccata a te, e fa parte di quelle cose che fanno bene a tutti.
Un giorno, quando nonostante i vestiti con cui si travestiva da persona normale, fu scoperto, venne chiamato negli uffici del direttore. Diceva di essere molto in difficoltà, di sentirsi piccolo, timido, indifeso in quei lunghi corridoi, in quegli uffici grandi come la sua casa.
Mi diceva però che aveva un segreto: aveva nascosto nel suo borsello, la tuta blu e i guanti bianchi; lo faceva sentire al sicuro: in caso di bisogno li avrebbe usati per volare via. Il direttore con tono sicuro e pacato, gli aveva detto che l’azienda gli avrebbe risparmiato qualche anno di lavoro, regalandogli la pensione prima del tempo, e così avrebbe potuto dedicarsi ai figli, alla bicicletta, alla lettura, che erano le sue ioni. Aveva concluso dicendo che era sicuro che lui sarebbe stato grato ad un’azienda così generosa.
Quando gli ho chiesto cosa significava, mi aveva risposto che probabilmente avevano scoperto che lui si era messo a indagare, e che speravano che, offrendogli dei privilegi, avrebbe smesso. Ma lui non poteva smettere, anche perché se aveva trovato la tuta blu e i guanti bianchi che facevano volare, voleva dire che era stato scelto dal destino per portare a termine quella missione. Allora gli ho chiesto cos’era il destino. Ci aveva pensato, e aveva risposto che era la vita che ci tocca, e che dovremmo tutti accettare. E poi ha aggiunto che accettare non significa subire, anzi; significa piuttosto che proviamo una forma di gratitudine nei confronti della nostra esistenza, qualunque cosa ci succeda durante il percorso di vita.
E da quel momento la sua vita la ava in mezzo ai documenti. Non trascurava mai la nonna, e nemmeno suo figlio e sua figlia, ma sapeva anche che certe missioni segrete richiedono dei sacrifici. Certe volte non ne poteva più e prendeva la bici e se ne andava a fare tanti chilometri in campagna.
Diceva che l'aria era piena di odori, a volte anche forti, aspri, ma che avevano sempre una qualità naturale; non come quelli artificiali della zona industriale. Oppure certe notti, facendo piano piano, scendeva dal letto, prendeva la tuta e i guanti, saliva sul tetto di casa, e volava in alto, sopra la città. Dall’alto tutto ha una prospettiva diversa: questo vale per le case, le auto, le persone, che sembrano formiche indaffarate. E poi andava sempre là, sopra le fabbriche, e si sentiva avvolto dalla nostalgia. Poi tornava a casa, si rimetteva sotto le coperte, e finalmente riposava, sentendosi leggero.
Mettendo insieme tutti i documenti aveva scoperto fatti gravissimi. Le fabbriche oltre al lavoro e all’amicizia, potevano procurare malattie molto gravi. Immaginava queste malattie come un mostro, che però, essendo all’interno delle persone, non poteva essere combattuto. Lui pensava che il lavoro e gli amici fossero importanti per tutte le persone del mondo, ma ancor di più la vita e la salute. E allora aveva ato un brutto periodo, carico di pensieri pesanti, di dubbi, di incertezze, dilemmi. Si immaginava di parlare col direttore, coi padroni dell’azienda, col mostro che abitava i corpi degli operai. Avrebbe voluto fargli capire che sbagliavano, che c’erano sicuramente dei sistemi che potevano mettere d’accordo tutti: tutti tranne il mostro, forse.
In realtà lui sapeva cos’era giusto fare, ma temeva che nessuno l’avrebbe capito. Un giorno indossò la tuta blu, i guanti bianchi, prese il telefono, chiamò un
magistrato e gli disse che doveva parlargli. lo andò a prendere, lo portò in volo sopra le fabbriche e poi entrò in casa e si chiuse con lui dentro la sua stanza. Stettero insieme per ore. Da fuori si sentivano appena le voci, la carta dei fogli dei documenti che leggevano. Poi uscirono, si strinsero le mani, e salutarono tutti. Volarono di nuovo sopra le fabbriche prima di tornare nell’ufficio del magistrato.
Il resto è diventato storia. Ci furono dei processi. Una prima assoluzione, che fece gridare di rabbia e piangere tante persone. Poi una condanna, ma senza condannati. La giustizia ha vinto, senza trionfare.
Mio nonno ha preso la tuta blu, i guanti bianchi li ha sotterrati in un posto segreto (perché aveva concluso la sua missione, diceva), e aveva ricominciato ad andare in bicicletta.
Un giorno un camion lo ha urtato. È caduto, e non si è più risvegliato.
C'era una volta una città piena di fabbriche che fumavano tanto.
Facevano talmente tanto fumo che sembrava che andassero a fuoco. Col are del tempo però fumavano sempre meno, gli operai erano sempre meno. E di notte, guardando il cielo con grande attenzione, si può vedere un puntino blu che saluta con la mano. Poi il puntino se ne va e torna ad abitare vicino alle stelle, dove si sta davvero bene: eh già, là non ci sono fabbriche. E nemmeno mostri.
questa favoletta è ispirata a Gabriele Bortolozzo, morto il 12.09.1995. Grazie a lui, dopo varie traversie giudiziarie, il primo grado risale al 2001, si è iniziato a discutere del rapporto tra salute e lavoro.
Capitolo 2
(anni 2000)
Carnevale
Mercoledì. Il carnevale è finito ieri. ... Ieri la follia conclamata, oggi quella ufficiosa. Per terra tracce di festa: coriandoli, stelle filanti, bottiglie rotte, vomito. Nell’aria si percepisce la piega di stanchezza, dopo una notte forzatamente festosa; divertirsi non ha più un significato, è solo un agito, un ordine perentorio, un modo di distrarsi da sé. Venezia è morta da tanto, e vive solo grazie alla decadente bellezza cui non si può non perdonare tutto. Compresa la volontà politica di un’ignobile svendita, un tot a metro quadro. Suoi unici abitanti, vecchi piegati dall’umidità, ricchi mercenari, ignoranti inebetiti dagli spritz, universitari protempore, poca gioventù isolata: tutti apparentemente vivi, ma mai vitali. La strada straripa di donne e uomini, turisti, sviliti dalla sagacia immorale di commercianti di souvenir della nostalgia. Maschere, vetri, scarpe, bottiglierie, pizzerie, occhialerie, alberghi, fast-food, cucina tradizionale, cinese, araba. Cammino zigzagando tra trolley grandi come tir e zaini misura camper. La festa è finita senza mai iniziare, ma nessuno se ne è accorto. Tutti accettano l’illusione se possono così evitare la delusione. Rido e canto canzoni che fingo di ascoltare da cuffiette che non emettono suono, e sento parlare idiomi incomprensibili dai toni stanchi, impastati e notturni.
Cinesi avanzano a grumi: si distinguono per il loro rimanere compatti, e per i vestiti di chi latita dalla fantasia. Giapponesi a piccoli gruppi, da due a cinque, camminano con borsette, o, pettinature e vestiti da sfilata. Si scattano foto con espressioni standard: sembrano manga che lanciano urletti isterici. Non guardano mai negli occhi. Americani si distinguono tra obesi e muscolosi. Arrotondano le parole con dei versi che sembrano scivolare sulla loro stessa parodia. Hanno bei denti, sguardi felici di chi antepone l’ottimismo semplice, alla pedante complessità. Sono evidentemente quel che sembrano. Bengalesi pettinati con righe in parte iperboliche lasciano scie speziate. Inglesi pallidi portano con sé una nobiltà decadente, umiliata da giovani che non nascondono una disperazione penetrata fin dentro le viscere. Sanno di pioggia, cielo grigio, case marrone a perdita d’occhio, socialità costrette dentro uffici o pub, e birra a gonfiare il ventre. Tedeschi a misura di famiglia che non si vergognano di niente. Purché sia efficiente e affidabile. si che sembrano italiani con l’erre moscia, con la stronzaggine intrinseca di chi eggia in centro. Spagnoli che sembrano italiani che se ne fregano di non essere sempre e comunque vestiti alla moda, e parlano ad alta voce e ridono sguaiati. Olandesi biondi e impermeabili alle emozioni che leggono guide turistiche dalle loro altezze siderali che compensano il fatto che vengono dai paesi bassi. Coreani che sorridono, e che sono in modo netto la prossima modernità. Ai lati, africani robusti vendono borse finte. Parlano gutturale, ridono sempre tra loro e uccidono afflati di simpatia pur di vendere qualcosa. Altri vendono altro. Zingari rumeni mendicano comione ai sensi di colpa.
Veneziani vendono ritratti stereotipati di angoli cittadini inesistenti, commissionati in Cina e Vietnam; oppure si lamentano della marea umana che non gli permette di vivere; oppure trascinano carrelli stracarichi di merci che questi stessi ominidi hanno consumato, e consumeranno, facendosi largo a suon di urla e improperi dialettali. Come tutto e tutti a Venezia, hanno ragione e torto insieme, confusi, smarriti, perduti tra altezze siderali e profondi abissi. Io sono il mondo, anche. Il primo, il secondo, il terzo e finanche il quarto. Contengo tutti i mondi, in scala gerarchica, e ordine misto. Mondi che coesistono detestandosi, scaricando sull’amministratore - il mio ridicolo ego - l’onere di tante contraddizioni. Tutti hanno le stesse scarpe da ginnastica. Alcuni, scarponi neri. Altri imitazioni di scarpe. Altri i sandali. Certi indossano scarpe italiane. Tutti hanno scarpe provenienti da altri paesi, prodotte in fabbriche fatiscenti, assemblate da bambini schiavi che non visiteranno mai Venezia. Maglie e camicie sudate. Piumini, pellicce, cappotti. Giacche, giubbotti, soprabiti. Grandi marche, grandi prese per il culo, firme vere e fasulle. Lusso, lussuria, consumo, depressione, panico, arte, bellezza, metafisica, internet. Non ce l’ho con nessuno di loro come persone; non li sopporto in quanto massa. M’hanno rotto i coglioni!, penso.
Mi posiziono a un lato della strada. Appoggio la borsa sui masegni. Tolgo il giubbotto che porto sopra il vestito, rimanendo in completo gessato. Fingendo di ascoltare musica, mi metto a ballare breack-dance e poi faccio il robotino che si muove a scatti. Poi fingo di raccontarmi una barzelletta e rido a voce altissima, il tutto col silenzio del mimo. Poi mi sposto in un campo attiguo, prendo posizione e comincio a roteare su me stesso; prima piano poi sempre più veloce sino a non distinguere più l’immobilità e l’imponenza dei palazzi che mi circondano. Roteo danzando come i dervisci. Dopo qualche minuto mi fermo. La testa gira, mi lascio cadere morbidamente a terra. Mi si avvicina una bella e giovane bionda vestita con una gonna lunga e una camicia leggera. Mi appoggia le labbra sulle labbra, leggera, senza impegno. Mi guarda con gli occhi azzurri e chiari e ingenui di chi ha non più di venticinque anni. Mi sussurra ad un orecchio: “I understand you”, e se ne va, dopo avermi leccato l’orecchio destro. Mi rialzo. Mi spazzolo i vestiti senza polvere. Vedo un paio di decine di occhi che mi fissano incuriositi. Sulla borsa appoggiata a terra, qualche € di caritatevole predisposizione all’arte che non ho manifestato. La prendo, metto in tasca i soldi e vado salutando con un gesto della mano che
accompagna in modo teatrale un inchino. Squilla il telefonino. “Sì, pronto” dico. “Dottor Persepolis, sono Comin. Sto male, ho bisogno di vederla. La prego, posso venire oggi?” “Comin, sono ancora per strada. Appena arrivo in studio controllo con Clara gli appuntamenti, e se ho un buco la ricevo. Se non è oggi, sarà per domani. Ha preso gli ansiolitici che le avevo prescritto? Sì, bene. Ci sentiamo più tardi”. “Clara, sono io, sto arrivando. Se qualcuno telefona, prenda appunti che poi sistemiamo gli impegni. Sì, a tra poco”. Butto fuori l'aria dai polmoni e mi avvio incontro al giorno.
Cronache dai quotidiani
Brescia 1 Il lunedì mattina era piovoso. Strade e cielo, stesso grigio, pensavi. Andavi in bagno, ti specchiavi, pisciavi, non pensavi. Poi in cucina, preparavi la moka da due, una fetta di pane fatto in casa con la macchina apposita vinta coi punti del supermercato, e marmellata di fragola della suocera. Svegliavi tua moglie alle sei e un quarto, il caffè e il pane pronti anche per lei sul tavolo della cucina. Lei faceva colazione, tu ascoltavi la radio in bagno, mentre ti facevi la barba. Poi uscivi tu e entrava lei. Alle sei e cinquantatré usciva da casa per recarsi al lavoro, autobus delle sei e cinquantanove, come ogni santo giorno. Oggi però non c’era santità nell’aria.
Sant’Agostino, FE 1 Il turno del sabato notte, pensava, era pesante. Era pur vero che alzava lo stipendio, e che i suoi sabati avevano smesso di essere euforia, e quindi rimpianto, ma sarebbe comunque stato meglio a casa sua. Doveva andare in pensione ma la nuova normativa di quella nuova ministra tecnica, così borghese e indecente, aveva allontanato la meta. Aveva girato tutti i concessionari di camper di Ferrara e Bologna.
Con il TFR se ne sarebbe comprato uno e avrebbe girato tutta l’Italia. Sarebbe tornato verso la sua adorata Napoli, come primo viaggio; poi avrebbe continuato, chilometro dopo chilometro. Sarebbe ato anche per Brindisi, dove la ragazzina era stata ammazzata davanti alla scuola. Aveva comprato una cartina geografica, segnato il tragitto, fatto i conti a mano dei chilometri, del costo dell’autostrada, o in alternativa delle statali, e ci stava dentro. Avrebbe rimandato di qualche anno, pazienza. A questo pensava a quasi fine turno, quando aveva sentito il primo rombo profondo, sordo, che sembrava provenire dalle viscere della terra. Contemporaneamente, la fonderia aveva tremato, come fosse stata investita da un brivido.
Brescia 2 Eravate riusciti a non parlarvi anche stamattina. Il dialogo con tua moglie consisteva ormai nei soli impegni da sbrigare: la spesa, i bambini, il lavoro, la tivù. Ti eri fatto un altro caffè e l’avevi bevuto guardando le estrazioni del Superenalotto al televideo. Questa volta avevi fatto 3. Ti eri vestito con i jeans, la camicia bianca, messo i mocassini, eri andato in camera dei bambini e ti eri fermato un momento. Dormivano sereni, l’aria odorava di tenerezza. Avevi un dubbio: chi avresti scelto per primo? Eri rimasto in piedi, appoggiato allo stipite della porta a guardare il respiro lento del sonno innocente, e per un attimo avevi dimenticato la stanchezza. Eri tornato in cucina, avevi messo la lettera che avevi preparato il giorno prima
sul tavolo, appoggiata a una tazza da colazione in modo che si potesse vedere appena entrati nella stanza: poche parole che parlavano di scuse, paura, tradimento, fine. Prima di tornare in camera dei bambini avevi verificato attraverso la finestra del bagno che nel cortile condominiale non ci fosse nessuno. Fuori la città iniziava a svegliarsi, a secernere la sua puzza, a invadere coi suoi rumori, a affannarsi inutilmente. Non c’era nessuno. Bene, era il momento. Andavi da Luca, due anni, che ti aveva guardato un attimo e poi aveva chiuso di nuovo gli occhi, fiducioso. Gli avevi fatto sshh con la bocca, come a dire che non era niente, che eri tu, suo papà. Aprivi la finestra, guardavi i sei piani di sotto e facevi un movimento come di ninna nanna mentre le braccia lo lasciavano andare. Poi Piero, sei mesi. Gli avevi baciato il volto, in particolare gli occhi, l’avevi annusato e ti eri voltato per non guardare mentre non sentivi più il suo poco peso nelle mani. Ti eri aiutato con le mani sulle finestre per alzarti, stando attento a non fare danni. Mentre precipitavi, pensavi che finalmente era finita.
Sant’Agostino, FE 2 Non si capisce subito che è un terremoto, ci si mette sempre un po’ a realizzare. Qualcuno aveva urlato, e lui aveva infine compreso. Era il capoturno, il più anziano; “Fuori, tutti fuori, uscite subito” aveva urlato. Il forno tremava, come avesse freddo, pensava mentre si voltava per uscire. Era
caduta una trave dal soffitto, l’aveva colpito alla testa, era caduto. Sarà durato un attimo, forse: ma un attimo è comunque tempo. Tra la rottura della scatola cranica e l’incoscienza, era riuscito a percepire lo scricchiolio delle ossa che si frantumano sotto il peso del tetto. Non sentiva dolore, non aveva paura. Pensava al destino che lo aveva privato della soddisfazione di girare in camper: pensava all’Irpinia, all’Aquila, alla finale di coppa Italia, alla sua famiglia, alla pensione, alla fine di tutto.
Sto galleggiando nell’aria
Piove, marzo. Sono a casa, sto bevendo un tè, leggendo il romanzo di uno scrittore russo. Sento il ritmo regolare della pioggia contro il vetro della finestra: un sottofondo piacevole. Squilla il cellulare, è Haruki. Rispondo. Una voce dal tono scosso, dal respiro affannoso; le parole sembrano pronunciate casualmente, tanto sono confuse; dice che ha il corpo ricoperto di segni rossi: è uno sfogo cutaneo. Mi chiede, per favore, di raggiungerlo. Arrivo davanti casa sua. Suono, mi apre il portoncino. È vestito con una brutta tuta da ginnastica. È sciupato, ha il viso macchiato e gonfio. Entro con circospezione, gli chiedo cosa sia successo, forse troppo frettolosamente. La stanza è in ordine, fin troppo; pare inanimata. I dischi e i libri sono al loro posto, i quadri anche, la televisione, il computer portatile , sul tavolino davanti al divano. C’è però un’atmosfera mortifera che copre ogni oggetto; è solo una sensazione, eppure mi penetra, glaciale e netta. Mi fa sedere, porta un tè e finalmente parla. “Da cinque mesi sto facendo una terapia per dei seri problemi al fegato e al pancreas. Ho cambiato diversi farmaci, ma non si sa a quale sia allergico. Devo farmi ricoverare per accertamenti”.
“Cinque mesi che fai la terapia? Ma io non sapevo niente, e... scusa ma sono sconvolto... Sei sempre stato solo, ti sei tenuto tutto dentro... cinque mesi di totale solitudine”, dico io. “Lo so, è vero! E adesso; adesso ho una fottuta paura. Mia moglie non sa niente, non ho avuto il coraggio di parlarle, e non so come affrontare questo casino... Scusa ... scusate tutti”. La voce è debole, condizionata dalla commozione e dall’umiliazione; nasconde tra le mani il pianto di chi non è abituato a farsi vedere in questo stato, e corre verso il bagno trascinando le ciabatte. Lo seguo, busso, entro e l’abbraccio. “Sono qui con te... Ti voglio bene...”, dico mentre gli occhi mi si riempiono di lacrime e la voce mi si strozza. Lo abbraccio con gli occhi chiusi. E non sento niente. È la persona con cui sono cresciuto, con cui ho condiviso viaggi e storie. E non provo niente. Vorrei provare dolore, sentire l’apprensione soffocarmi, immaginare il peggio: ma niente. Lo stringo e lui diventa di gomma morbida, mi si modella addosso fino a non sentirlo più. Poi lo scheletro scricchiola un poco; poi come fosse in decomposizione; poi come cenere di brace che si polverizza. Non sento male, non provo nulla. Poi riapro gli occhi e lui è lì; evitiamo di guardarci negli occhi per non umiliarci ancor di più. “Torniamo di là e chiamiamo l’ospedale”, dico. Chiama lui, spiega la sua posizione. È ingegnere nucleare, lavora in centrale da sette anni e sì, forse c’è stata una
piccola fuga di uranio; o forse è successo quando è andato con la squadra di tecnici volontari a ripristinare la corrente elettrica dopo lo tsunami. In azienda dicono che non ha tracce di radioattività, che non è contagioso, che non si può escludere che si tratti di un effetto collaterale dovuto alla missione. Gli dicono che manderanno un’ambulanza. Ascolto in silenzio la telefonata. Gli dico di non preoccuparsi per la moglie; chiederemo consiglio ai medici. Nel frattempo, diremo che è uno sfogo allergico. Si rilassa un poco. La realtà ci impone di essere forti. Si fa silenzio. La casa ne è invasa. Usciamo, dobbiamo andare, l’ambulanza sarà qui a momenti. Fuori piove. S’alza il vento, sempre più forte. Mi volto verso la casa. Un lampo improvviso, inaspettato, si accende dall’appartamento di Haruki. Uno scoppio, una deflagrazione fa volare pezzi di vetro, carne, schegge di plastica, legno. Il condominio si gonfia, scoppia, s’accartoccia, s’incendia, si ripiega e infine si disintegra. Il tutto dura pochi secondi. Lo spostamento d’aria mi scaraventa verso l’alto con un’energia tale, che non avrei mai potuto immaginare nemmeno col pensiero; non c’è più nulla né davanti né dietro me. Non c’è più Haruki, non c’è l’ambulanza, la strada, la città, il mondo, il pensiero, il sentimento, l’emozione. Tutto ormai è soltanto niente. Sto galleggiando nell’aria. Volteggio e roteo.
Mi perdo nella non dimensione cui appartengo: né vivo, né morto.
Mi sveglio sudato. Mi guardo attorno sconvolto. La camera è piena di brandine. La camera non è una camera: è una palestra. È marzo, è il 2011. Mi chiamo Yamaguchi e, se potessi esprimere un desiderio concreto, vorrei riuscire a dormire senza dover sognare questi incubi.
aggio
Il mio corpo sta assumendo un disegno strano, più curvo, rotondo: ora è un sinuoso contenitore smussato, la scatola magica che contiene il mistero biologico della vita. Eppure guardandolo così, come ritorno immediato, me ne sento offesa, disgustata. Non mi piace la figura che vedo allo specchio quando mi guardo: questa è la verità. Perché io debba pagare un prezzo così alto, non mi è dato di saperlo; e niente e nessuno, comunque, potrebbe convincermi che un ritorno alla normalità in pochi mesi, sia una promessa che compenserà questo disagio, questo degrado. Il mio posto nel mondo, il mio ruolo, quello che sono certa di rappresentare, sono compromessi da un’estetica sconveniente e sproporzionata; le mie già precarie sicurezze, conquistate in anni di fatica, di studio, sono minate, da dentro, da una percezione contorsionista che fa le capriole, che mi fa perdere e ritrovare, direzione e padronanza. Ho letto molto e so che posso avere degli scompensi, alti e bassi, che non sono altro che il risultato di impulsi elettrici, reazioni chimiche, battaglie ormonali, lotte psicologiche. Sono un laboratorio; un grosso tondo laboratorio che girovaga senza agilità per un mondo che osserva e giudica. Chilogrammi, taglie elefantiache di mutande e reggiseni, vestiti larghi a caduta perpendicolare, mutazioni e trasformazioni. Leggo i pensieri degli altri e vedo scritte parole sarcastiche quando pensano a me. Lo so sì, lo so da me che sembro un pallone con testa-braccia-gambe. Eppure tutto questo svanisce con un calcio, un impercettibile movimento, un cambiamento di posizione. Tu, immersa nel liquido, nel silenzio reale e irreale del misterioso mondo
sferiforme, galleggi, circoli liberamente, fai piroette circensi. Mi pare che te la si, e sento una sorta di gelosia mista a contentezza, per questo. Il tuo pubblico siamo io e te; solo io e te. E per uno strano sentimento di sufficienza, tu ed io, siamo tutto ciò che desideriamo; siamo un piccolo mondo, ma mai vorremmo che qualcuno venisse a curiosare tra i nostri segreti, che venisse a farci domande cui mai risponderemmo, in quanto sono solo affari nostri. Nella situazione complessa in cui ci troviamo, regna la semplicità e governa la delicata legge della natura e dell’istinto. Io mangio, tu mangi. Io rido, tu godi l’allegria. Io piango, tu scimmiotti rattristandoti. Non sono mai sola così; non posso nascondere segreti; tu in qualche modo sai, senza sentire: il contatto diretto ci unisce, il cordone è un megafono. Mi ritrovo sempre innanzi a salite e discese, alti e bassi, precipitosi cambi d’umore, repentini, improvvisi, temporali e tuoni e fulmini e ventate fresche nel caldo d’estate. Non c’è mai una stabilità stabile: soltanto le mille piccole instabilità che senza volerlo, mi causi; che hanno una strana forma di disciplina, un equilibrio da tiro alla fune. E il mio corpo è sempre un segnale da codificare, un’attività perpetua, composta di scatti, frammentata, disordinata ma viva, saporosa, odorosa, vitale. Quando mi fai stancare tanto, la schiena mi duole, i piedi come braci, il sudore che bagna la pelle. Non riesco a razionalizzare il sentimento. So a malapena collocarlo nel delicatissimo disegno universale, che si autoalimenta, che basta a se stesso e che provvede al mantenimento della specie. E credo questo ci preparerà al dopo.
Ci sono gli alti e i bassi, e occorrono forza e gioia per introiettare le contraddizioni della vita. Noi ci stiamo allenando insieme a separarci; a are dalla beatitudine dell’unità, al lutto della separazione; dall’eliminazione della dualità, al dispiacere di sentirci vicine ma pur sempre lontane rispetto al prima: al nostro adesso. A me spetta il dolore del corpo dilatato, che espelle una parte di sé che diverrà un’altra esistenza che non sono più io, ma tu. Ore a lavorare sodo, a respirare con ordine, col diaframma; lenta, su e giù, pancia in fuori inspiro, pancia in dentro espiro. E sarò maschera di sudore, bocca spalancata che urla, forte, come a sputare il dolore; forte, fortissimo, insopportabile. E tu dovrai lavorare, spingere, comprendere quando è il momento. Sarai ancora in contatto con me, ma saranno le ultime volte prima di affrontare lo scivolo delle viscere e terminare il viaggio, che inizierà proprio allora. Contemporaneamente uscirai ed entrerai; dal mondo perfetto a quello imperfetto. Dal silenzio magnifico della felicità assoluta, al frastuono, alle luci. E piangerai perché non saprai perché; non subito almeno. Poi erai da mani che non conosci, che fanno paura ad un posto morbido; riconoscerai un odore acre mai sentito ma familiare, una voce mai udita con quelle tonalità, ma dolce. Piangerai con forza, con totalità; ma quella voce, quella sofficità, quel profumo ti calmeranno. Per la prima volta sarai nel momento, nel punto esatto, dove qualcosa finisce per ricominciare subito dopo, in altro modo: tutto da imparare, capire, tradurre. Adesso, se appoggio le mani sulla curva rotonda della pancia, sento un piede e riconosco la tua risposta. Questi pensieri non erano solo miei; li hai indotti tu con la tua ingombrante presenza, con l’alfabeto del tuo movimento, con la danza acquatica che mi
disegni dentro. So che arriveremo alla fine esauste, ma resisteremo e trasformeremo la nostra unione in qualcosa di nuovo, forte, complice. In questo continuo rutilante miscuglio di emozioni sonore come schiaffi, fragorose come il silenzio assoluto, si aprono dei piccoli varchi e io, in quei piccolissimi pertugi, posso depositare amore; amore senza ragioni, perché uscito vivo da lotte leggendarie e leggi universali. L’altro giorno ho visto la tua prima fotografia in bianco e nero. Nel monitor, come in un film, ti muovevi senza fretta, con grazia. Ti sei mostrata nuda e libera e fluttuante. E ho anche sentito il tuo primo suono: un galoppare frenetico, un tambureggiare tribale; il tuo cuore echeggiava nel mio mare, la tua casa, la mia pancia. Dopo un po’, non subito, ho continuato a sentirti, a percepire il tuo linguaggio delicato e ho sentito una stretta fortissima al cuore, una morsa d’acciaio, improvvisa e ho capito che per sempre saremmo state legate, pur nella nostra unicità, avremmo condiviso per sempre un legame che è semplice e vitale e assolutamente involontario; è un marchio a fuoco che non abbiamo deciso, ma che abbiamo ereditato. Ora non resta che aspettare che si compia il meccanismo naturale. Uscirai da me, ma non preoccupartene: sarò lì ad accoglierti e stringerti. E ti nutrirò e rassicurerò. Sarò sempre con te fino a quando servirà, poi spero di riuscire a lasciarti andare. E un giorno ti leggerò queste righe e insieme ne sapremo ridere, con spensieratezza e leggerezza. Ti aspetto. Buon viaggio.
Incontri (omaggio a Guccini e Mestre)
È in ritardo, come sempre, unica certezza della sua vita incerta. Chiude il portoncino con quattro mandate, con un automatismo robotico. Scende i gradini tre alla volta e correndo la incontra lungo le scale. La riconosce subito, uguale all’immagine che coltiva nei ricordi, con dieci anni in più, ben distribuiti, nonostante la curva della loro età sia ormai parabola discendente. Sono due bei quarantenni, e quasi nulla gli sembra cambiato in lei. Subito, l’impatto della sua presenza, nei suoi circuiti neuronali. Pensa a tutto quello che sa, e sa che tutto quello che pensa non vale niente, appena più di poco, forse nemmeno quel poco e quel niente. Quello che sa, che pensa, è relativizzato dalla circolazione sanguigna, dal caos delle cellule che corrono qua e là, su e giù, come non avesse più semafori a dirigere il traffico interiore, sempre controllato e pacato. Vaffanculo pacatezza e controllo. Il corpo s’impone, frena deciso: inversione a U. -“Sei tu”, dice. -“Sì”, risponde lei. -“Cosa fai qui?” aggiunge d’istinto, pentendosi subito delle parole e del tono con cui ha pronunciato la frase. -“Sono venuta a pagare il terapeuta del secondo piano”, dice lei, guardando il pavimento del pianerottolo con un movimento involontario: un riflesso del suo pudore. -“Ti va un caffè, qui vicino c’è una pasticceria?” chiede lui.
-“Sì, certo che sì. Se puoi aspettare cinque minuti” risponde. L’aspetta fuori, camminando avanti e indietro sotto i portici, in attesa. Il portone si apre, lei esce. Vanno senza parlare verso la pasticceria, raggiungendo la saletta interna. Si siedono, lei sul divanetto e lui sulla sedia; lei appoggia le borse, si toglie il cappotto e lui si accorge di aver notato solo in quel momento com’era vestita e pettinata: aveva guardato solo i suoi occhi azzurro chiaro, riconoscendone la dimensione insondabile, benché trasparente nell’esprimere i suoi stati d’animo. Sono seduti vicini, le gambe si toccano a tratti, sprigionando piccole cariche elettriche che corrono lungo i loro corpi. L’eccitazione è un’inesauribile fonte emozionale: ricorda gli elementi chimici pronti a fondersi, a reagire, a trasformarsi in altro da sé. Ordina lui, d’istinto, senza chiederle conferma. -“Non hai sbagliato: ricordi ancora”, dice lei, sottolineando, senza dirlo, che le sembra sintomatico quell’automatismo. Non dicono, ma sentono la contrazione del tempo: dieci anni di vite separate, ati e vissuti come tra parentesi. -“Che strano trovarti oggi”, inizia a dire lei, “sono sette mesi che vengo in terapia in questo condominio e non ci siamo mai incrociati”. -“Pensa che ci abito da tre anni e non conosco ancora tutti i vicini”, dice lui. -“Ho iniziato la terapia dopo un periodo buio, in cui non riuscivo a vedere alcuna luce. Quanti figli hai?”, gli chiede. -“Ho due figlie, una di sette e una di tre anni. Se vuoi dopo ti faccio vedere le foto, le ho qui sul cellulare. Mi spiace per il tuo brutto periodo, e spero che la terapia ti aiuti”, dice. -“Scrivi ancora? Pensavo proprio a te quando mi sono detta, senza allegria, che
la mia vita sembra un romanzo. Quando ci siamo lasciati, dieci anni fa, era natale: la strada, le bancarelle chiuse, nessuno in giro e uno stupore bianco, come la neve che cadeva pigra quel giorno. Ti eri allontanato senza dire una parola e non eri più tornato. E per confermare la teoria delle coincidenze, come in un romanzo scritto male, lui si è ucciso per natale. Ora io e mia figlia, a natale, ci concediamo le vacanze in paesi che non lo festeggiano, per allontanarci dai ricordi”, fa lei. Silenzio. I loro occhi si incontrano, si catturano, fuggono, si ritrovano, rifuggono. Le loro gambe si sfiorano, e basta un tocco leggero e fugace a scatenare un’energia insostenibile: una massa di ricordi, rimpianti, sentimenti, sensi di colpa, coscienza, fuga, chiarezza, nausea, paura. Silenzio, occhi che roteano e fissano dettagli inutili: scatole di cioccolatini, focaccine, le divise delle banconiere, le scarpe di uno che beve un caffè, la borsa firmata di una ragazza. Non sono più stati felici, si sono mancati da morire, sono morti e rinati monchi; sono nati per stare insieme e hanno sputato sul loro destino: sono un solo organismo vivente ormai moribondo, sono solo un banale lui e una triste lei. Sono qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa. Lui si alza dal tavolino con una fatica di secoli sulle gambe, va verso la cassa con piedi pesanti di piombo, paga con mani arrugginite e tremolanti. Non capisce cosa dice la cassiera: le orecchie non distinguono suoni: producono solo brusio. Si volta, lei non c’è più. Si guarda allo specchio di una vetrinetta, non vede nessuno. Esce in strada e respira a pieni polmoni, mentre si avvia verso il nulla che ha riempito di parvenza di vita che, in quel momento, si dissolve.
Guarda alla sua destra perché nota solo ora che la sua figura non produce ombra. “Almeno lei ha sempre avuto il coraggio di vivere, dopo: io solo di fingere”, si ritrova a pensare mentre corre verso l’autobus che riparte, incurante di lui e della sua vita incerta.
Quaranta
Questa giornata è una bella giornata e io devo pigliare quel che viene con la grazia di chi non giudica, ma accoglie e sorride. Sembra oramai un mantra, questo. Non giudicare, accogliere e sorridere; non giudicare, accogliere e sorridere; non giudicare, accogliere e sorridere: ad infinitum. Ma perché non dovrei accettare i consigli del terapeuta? Una formula salvifica, è positività; ci metterà del tempo ma crescerà e lascerà un segno inciso nell’anima. Un giorno gli ho chiesto cosa fosse, e cosa intendeva per “anima”. Mi ha guardato col solito sorriso di chi la sa lunga, lui; e invece tu che fai ste domande, la sai corta corta. L’anima è una convenzione sociale - mi fa -; serve a fondare negli individui l’idea che abbiano un’interiorità, e che questa spesso non è in sincrono con quello che poi dicono, fanno, pensano, manifestano, agiscono: insomma, l’anima serve a giustificare Dio, la psicologia, la religione, le credenze, le sovrastrutture, le menate orientali, lo yoga, eccetera. In questo caso - aggiunge -, serve a contrastare ciò che lei - che sarei io - ha introiettato e considera immodificabile, pur non essendolo. E cosa considererei immodificabile? - faccio io -. Il suo destino di persona sola - fa lui con tono dolce e affabile -.
Quest’altro consiglio invece, non lo so accettare e alla mattina, appena alzata, mi prendo solo un caffè, nero e dolce, e fanculo. Dovrei are ai cereali e alle fette biscottate integrali con la marmellata biologica e il tè verde.
Dovrei ma non c’entra. Quello che dovrei è una costruzione artificiale e irraggiungibile di buoni propositi e adempimenti e fioretti e rotture di palle. E quelli che ti dicono quello che dovresti, sono di solito infelici anche se lo nascondono dietro quei sorrisi e quei modi così a posto che ti verrebbe voglia di prenderli a schiaffi.
Poi subito la sigaretta, tanto per far andar via quell’oppressione ai polmoni che schiaccia col vigore d’una pressa. La prima cicca è una delle cose belle della mia vita: tiro forte, tirate luuunghee, che occupano immediatamente tutte le distonie dei polmoni che si lamentano. Voglio un figlio, cazzo.
Onomatopee della prima: Sssssssss (aspiro), ffffffffff (butto fuori). E poi la pace, l’ansia che si placa e ridiscende dentro fino a diventare lontano ricordo che ogni tanto ricompare. Non è molto elegante, ma lo dico lo stesso, tanto mica va su un giornale rosa sta specie di diario a pezzi: la sigaretta me la fumo in bagno, mentre faccio i bisogni. E tanto per dirla tutta, ma proprio tutta, è la più grande liberazione sfinterica che si possa immaginare, e io me la godo tutta tutta, prima di ridiventare un essere con sembianze umane. È il vantaggio di abitare in campagna, in case grandi che hanno almeno tre bagni. E questo è solo mio. Mia madre e mia sorella ne hanno anche loro uno ciascuna; e così ci posso fare
quello che voglio qua dentro. Il bagno è mio e lo gestisco io. Vorrei un amore che dividesse il bagno con me.
Finalmente riconquisto la libertà dopo anni di sacrificio; mi sono tenuta dentro tutto, tutto soffocato là sotto, perfino a cagare ci andavo quando ero sicura che non c’era nessuno in casa; per paura di far rumori molesti, o puzza. La femminilità si misura ancora oggi secondo canoni onomatopeici secolari: la donna dev'essere silenziosa, discreta, efficiente, ubbidiente. Certo, come no; mal di pancia, mal di piedi, schiena, testa: chi bella vuol apparire, in silenzio deve soffrire. Proprio pensieri da cesso mi vengono alla mattina, altro che bella giornata. Mi piacerebbe essere una donna, non una femmina.
C’è questa rabbia che esplode così senza preavviso e che mi impone pensieri che non vorrei pensare e mi fa dire, nel silenzio di questi, parole che mai vorrei udire da alcuno; specialmente da me stessa. Ma poi ano; “è forse la tazza che evoca il piacere anale che ritorna con la sua semplicità, complicata ad arte dalla morale e dalla cultura occidentale”. Ma che bei pensierini da convegno che mi vengono mentre me ne sto qua seduta, con sta cicca fumante tra le dita, mentre faccio tiri lunghi, potenti, che mi riempiono e quietano. Desidero una carezza.
Finito! Adesso via sotto la doccia.
“Sono un corpo umido d’acqua e vapore/sono nascosta dentro a questa nebbia/mi vedi e non mi vedi/ ci sono o forse no/sono solo un sogno/ che si rivela un poco/ per suscitare domande/ per scaturire risposte”. C’è chi canta, in doccia; io no, m’immagino d’essere una che scrive canzoni, o poesie, e a seconda di chi me la commissiona, scelgo un particolare stile. E anche perché ho sempre freddo e questo comporre canzoni e versi mi distrae dalla temperatura che mi penetra la pelle e arriva fino alle ossa e poi ancora oltre, ad allarmare le interiora. Ambirei talvolta alla superficialità.
Terminata la doccia inizia il supplizio: devo decidere cosa mettermi addosso; ed è una logorante guerra quotidiana, una di quelle cose che, in certe giornate, mi spossano ancor prima d’uscire. Oggi non dovrei avere riunioni quindi una qualsiasi cosa dovrebbe andar bene, a patto che sia almeno decente. Che poi lo so che non sono gli uomini che s’accorgono come mi vesto o se tutto è intonato, ma quelle mezze vacche delle mie colleghe; le regine del brusio, le star del chiacchiericcio. Va bene, decido per il blu, che tutti mi dicono mi sta bene e basta. Questi jeans mi stanno proprio bene, con quello che son costati, ci mancherebbe; e poi sono di moda e coordinati con i gemelli blu scuro sono a posto. Adoro sentire questa lana pregiata sulla pelle, arci le mani sopra facendo finta di sistemarmi, ma in realtà soltanto per posarci le mie mani sopra e affondare sul morbido. Un trucco leggero e una spazzolata ai capelli che speriamo resistano fino a sabato che ho appuntamento dal parrucchiere. Datemi una corazza.
Prima di uscire devo dare un’occhiata all’agenda e fare il punto della situazione; l’altro giorno Gianluca e Susi mi hanno invitato al cinema con tutta la compagnia e io, come una scema, a dire sì, sì; con una faccia che si vedeva lontano un chilometro che non ho mai niente di bello da fare, solo impegni, e corsi, e palestra, e teatro, e basta. Il teatro, un posto e un tempo per provare emozioni vere, per farmi uscire da questa monotonia, da questo appiattimento cui assisto come fossi a teatro; spettatrice al di qua del proscenio della mia vita: uno spettacolo scadente, con pochi applausi di un pubblico immaginario feticista e vagamente depresso. Un applauso alla mia vita, vi prego.
E insomma quella sera dovevo andare al cinema e poi, magari, a sarebbe stato bello fare tutti insieme uno strip poker: io che avrei perso apposta, e davanti a tutti, un pezzo alla volta, avrei tolto con la finta calma pacchiana delle spogliarelliste, gli indumenti. E sentire che quelli che mi guardano si eccitano, gli si gonfiano i pantaloni. E le donnine gelose, perché sentono quest’elettricità che investe tutti. E invece sono uscita e ho visto il film senza perdere una scena. Ho anche pianto verso la fine, e con una scusa sono dovuta andare in bagno a truccarmi di nuovo. Poi come al solito, casualmente, tutti se ne vanno e io rimango col fesso di turno che ci prova. Se ci provasse un uomo con me, invece dei soliti fessi.
Il tenore di certi discorsi, fatti senza pensare, senza esserci, senza esistere. Lui: - “La fortuna di essere femmina, di poter scegliere chi voglio quando ne ho voglia”
Io: - “Ma la mia voglia ha una qualità diversa, e sorge solo se sono desiderata” Lui: - “Non so come fate, ma quando volete, inducete il desiderio in noi maschi” Io: - “Sono solo parole e pensieri tipicamente maschili. La realtà è molto più complicata e difficile” Lui: - “La realtà è la rappresentazione che noi diamo della nostra soggettiva visione delle cose” Io: - “Certo, hai proprio ragione. Senti, sono un po’ stanca, ti spiacerebbe riaccompagnarmi al parcheggio della pizzeria che prendo la macchina e torno a casa?” Lui: - “veramente speravo riuscissimo a stare un po’ insieme stasera” Io: - “anch’io, ma non mi sento tanto bene. Scusa” Aiutatemi a scoraggiare la noia.
Mentre raggiungo la macchina per andare al lavoro penso che ormai ho superato i quaranta, che i miei sogni stanno diventando materiale effimero fuori moda, che se non mi muovo non diventerò mai madre, che continuerò a vivere con mia sorella e mia madre, che il calore e l’amore di cui penso di aver bisogno, li leggerò sui romanzi. E che magari adottando un figlio smetterò di fumare. Nel frattempo mi accendo una cicca. In macchina mia decido io: qui si può fumare!
Segnali onirici di mezza estate (e di mezza età)
Lido di Venezia, zona San Nicoletto, nel pezzo di spiaggia libera non distante dalla diga. Davanti al mare, seduto, un tardo pomeriggio di agosto, guardo e ascolto. Mi immergo nel moto perpetuo, l’eterno su e giù delle onde. Sto così un minuto, cinque, dieci. Rilasso le spalle, che mi accorgo essere tese. In posizione a gambe incrociate, sciolgo i muscoli.
Mesi fa, incalzato dall’insistenza di amici e conoscenti e colleghi, ho finito per assecondarli, organizzandomi una festa a sorpresa. Ho mandato dei biglietti, firmandoli col nome di qualcun altro di loro, inducendoli così a pensare che qualche buon’anima si fosse finalmente deciso a organizzarla, 'sta festa. " il 22 agosto alle 18 festa a sorpresa di Cristiano per il suo cinquantesimo compleanno. Giavera del Montello, al Macondo. Bada bene a non farne parola con il diretto interessato!" C’è sempre bisogno di uno così, che si prende la briga di fare concretamente qualcosa, avranno pensato tutti. E perciò ho concretamente fatto: adesso staranno già arrivando i primi. Loro sono a circa settanta chilometri da qui, in collina: ho preferito non correre rischi e li ho piazzati lontani da dove sono io. Qualcuno avrà già mandato giù più di un aperitivo. Me li vedo, quelli e quelle;
abituati a comandare le parole, a gestire i gesti, a inventarsi nuovi sé i più lontani possibile dall’originale. Guarderanno l'ora su orologi e cellulari, tra un aperitivo e l’altro dissimulando le ovvie domande sull'assenza del festeggiato. Si distribuiranno sorrisi eleganti, parole di circostanza, allegrie simpatiche, pensieri pornografici. Mentre io sono qui.
Seduto così ho quasi l'impressione di sentire sulla nuca il peso leggero dello sguardo degli altri. In un momentaneo istante di follia transitoria, immagino un dialogo con i mandanti di quegli sguardi. - “ cosa sta facendo, perché sta così: che stia così per posa, per farsi guardare? ” - “ sto nullando, sto nientendo ”, risponderei loro. - “ e dovreste provarci, qualche volta ”, aggiungerei. - “ sapeste quanto sia ricco questo apparente nulla immutabile, questo rumore di onde, questa schiuma, quest’orizzonte, questa bellezza evidente eppure mesta, disinteressata all’esibizione ”, gli vorrei dire. - ” Basterebbe fare attenzione, e tutto sarebbe infinito orizzonte, realtà pura, visuale pulita ”, pronuncerei se avessi voglia di parlare. E invece taccio. E ristoro la mente, quieto i pensieri, smusso gli angoli, tradisco la fretta, aborrisco l’inutilità, sposo e bacio e lecco l’essenza. Oggi è il ventidue agosto duemilaquattordici e compio cinquant’anni.
L’ultima volta che sono stato a una festa di compleanno di un amico che ha compiuto i cinquanta, qualche mese fa, poiché non riuscivo a sostenere emotivamente la puerile oscenità delle scene che mi si presentavano davanti, ho dovuto ricorrere ad una strategia mentale: sei uno scrittore, mi sono detto, fai quello che fanno quelli che sono quello che anche tu sei. E così sono entrato nella parte: ho iniziato a muovermi, a interagire, a dire a qualche orecchio distratto che ero uno scrittore. Subito qualcuno si è precipitato da me a chiedermi telefono e mail per sottopormi manoscritti dopo aver girato attorno ai discorsi. Ho avuto un rapporto orale con una della mia età che si era rifatta le labbra: le aveva gonfie e di profilo sembrava tragicamente Paperina. Mentre era là, inginocchiata con un asciugamano sotto le ginocchia, in uno dei bagni liberi della bivilla con giardino del festeggiato, pensavo che erano anni che non leggevo più Topolino, e che non ne sentivo la mancanza, se non per il fatto che quando lo leggevo ero molto più giovane. Alla fine lei mi guardava con occhi desiderosi di gratificazione. Le ho detto “grazie”, e sono tornato alla festa. Se fossi stato me invece di essere lo scrittore, sarei voluto sprofondare, sparire, scoppiare lì in bagno, per l’indifferenza che provavo. Uno scoppio che avrebbe prodotto uno schiocco come se fossero state le sue labbra a scoppiare, piuttosto che io. Ma istintivamente mi sono detto “ segnatela questa ”, dimostrandomi così di essere lo scrittore e non me.
All’improvviso mi alzo, sento la sabbia umida sul costume, e me la tolgo con le mani. Lo faccio quando m’accorgo che la gioia di prima e i pensieri che ne sono seguiti, stanno per diventare posa. Quando l’orgoglio di saper talvolta vedere e sentire, diventa orgoglio. L’ego non dà tregua. E mi riporta al sonno delle abitudini.
Sono stato bene con me. Quando mi sono dimenticato di me, e sono stato in uno stato ignoto e amico, in comunione con quello che c’era. E io non c’ero.
Quella volta della festa dell’amico cinquantenne - “ mezzo secolo eh!? “, gli dicevano indistintamente tutti con tono soddisfatto come fosse una frase di cui darsi vanto -, quando dimenticavo di essere uno scrittore, rientravo in ciò che ero. Immaginavo la mia, di festa; vedevo tutti avvicinarmisi, farmi gli auguri, e dirmi immancabilmente “mezzo secolo eh!?“. Non riuscivo a mantenere sempre distinte le personalità. Prima di rientrare nell’identità dello scrittore, c’è stato un momento in cui mi sono estraniato dal salone della bivilla - penso si possa definire un fenomeno extracorporale, quello che mi è successo -, e come se il mio udito fosse stato a livello del soffitto, sentivo un unico continuo brusio: un chicchiericcio, un cicaleccio, un bla bla bla, con qualche acuto ogni tanto. Sei uno scrittore, mi dico. Lo so, mi rispondo. Torna giù, appoggia i piedi al pavimento, scrivi due appunti, immergiti nella parte. Uno scrittore può immedesimarsi in qualsiasi situazione e uscirne indenne, con una storia in tasca. Anche nei panni di un cinquantenne che vorrebbe essere ovunque, ma non dove si trova; ivi compreso questa festa di gente che dissimula la delusione e l’amarezza che li ha ormai invasi e condizionati, scambiandosi sorrisi, frasi di circostanza, gesti consumati. Ecco, scrivi così, calca la mano, esagera: tu puoi, sei autorizzato a farlo.
Raggiungo a i calmi l'acqua, sento il contrasto del freddo sui piedi accaldati dal sole.
Avanzo a i regolari nonostante le conchiglie sotto i piedi. Ad altezza inguine mi immergo, con uno slancio in avanti. L'impatto è piacevole, come fosse un ritorno alle origini, ormai dimenticate, causa inutili occupazioni quotidiane. Nuoto alternando gli stili, cercando di mantenere uno stile rigoroso, ma rilassato. Raggiungo il largo forzando fiato e muscoli. Ora sono solo, distante dalla riva. Il vociare continuo e frenetico che disturbava la quiete interiore, viene sostituito da un vociare lontano, indistinguibile.
A un certo punto mi si è avvicinato il festeggiato: senza capelli, con la pancia che sporge dai pantaloni, coi mocassini in tinta, le braccia coi muscoli della palestra, la camicia bianca aperta sul petto coi peli bianchi. AH AH! Ride sguaiato, mi abbraccia: odora di profumo buono. “ Mezzo secolo, eh!?, anche tu fra poco! Ma io sto bene, mai stato meglio e questo, e si tocca il prima il suo, e poi il mio, funziona ancora AH AH! “. È questo l’importante!, dice ridendo. a davanti a noi la figlia di un nostro amico: avrà venticinque anni, tatuaggi, piercing, testa rasata, bellissima. Eh!, e mi dà una botta col gomito; “ se non fosse la figlia di Bruno Buoso, questa me la porterei in taverna e glielo farei vedere io il tatuaggio AH AH! ”. Sorrido a bocca stretta. Annuisco. Mi da una botta sulle spalle, e va verso sua moglie, invitata anche se sono separati da tre anni e mai pacificati del tutto. A quanto dicono, lui sarebbe costantemente sul filo della bancarotta, circondato da gentaglia, stretto nella morsa di equitalia e ndrangheta di cui sarebbe ormai un prestanome. Tira su col naso e quando si allontana mi accorgo che è senza culo.
Tutte notizie sapute stasera, da gente che non vedevo da qualche decennio. Chissà cosa dicono di noi, mi sussurra in testa il me scrittore.
Mi metto in posizione del morto: viso in su, braccia e gambe allargate, come l'uomo vitruviano in orizzontale. Gli orecchi sott'acqua condizionano l'udito rendendo ogni rumore sordo, filtrato. Lentamente un onomatopeico, morbido blo blo blo mi rilassa, chiudo gli occhi, la presenza lucente del sole s'affievolisce, fino a sparire. Sento la presenza soprannaturale di mia madre: oggi avremmo festeggiato insieme il mio compleanno.
La ex moglie del festeggiato mi si avvicina, ondeggia un poco. Ha in mano un flute di prosecco, mi fa cin. Mi prende sottobraccio, mi conduce nel giardinetto della bivilla. Mi offre una sigaretta che accetto; lo scrittore, mi dico, può anche fumare una sigaretta, benché il quasi cinquantenne non fumi più da decenni. “ da quando ci siamo separati la mia vita è finita e ricominciata. All’inizio non mi sembrava possibile: pensavo ai venticinque anni ati insieme, buttati via come spazzatura. Poi invece ho capito: se non ce n’è, perché continuare? Pensavo di essere ormai esaurita come donna e invece, senti qua ”. Mi prende la mano, se la mette dentro alle mutande per farmi sentire che è bagnata. Poi la toglie. Si volta, fa per andarsene. Si rigira, mi guarda, sorride. “ tu sì che ti sei tenuto in forma ”, e poi va. Non l’ho più rivista per tutta la sera.
Sono un cosino grande così. Un esserino che galleggia nel liquido amniotico, che fa le capriole, riposa; sono nell'ambiente più perfetto che si riesca ad immaginare: una sorta di paradiso acquatico. Fa buio, ma non mi manca la luce. S'intravede la curva del ventre materno, la sua rotondità sinuosa, la sua dilatazione naturale. Il silenzio è padrone, interrotto solo, a tratti, da qualche eco lontana. Il tempo è un concetto inutile, un frammento, un particolare ininfluente di questa umida eternità. Improvvisamente una sorta di gorgo mi attira, mi pone in verticale, a testa in giù. Il liquido fuoriesce nella stessa direzione verso cui sono attratto. o attraverso un corridoio stretto, fino a giungere verso un'apertura che s'allarga poco alla volta. Combatto contro una forza superiore che mi sospinge verso la cavità pelvica. Una luce abbagliante oltre la barriera della vulva che s'apre, s"allarga, m'inghiotte. Non so se sto andando incontro alla vita, o alla morte.
Guardavo l’ora. Era l’una di notte. Avevo piedi e gambe doloranti: la vena varicosa, pensavo. In sala c’era un nostro compagno di ragioneria che faceva il dj, metteva musica anni ottanta, quando eravamo ventenni e pensavamo al futuro e a scopare. C’erano una quindicina di persone che ballavano, con le stesse movenze di allora, rese ancor più nostalgiche dai corpi appesantiti. Guardavo le gambe, i pantaloni, le scarpe, le acconciature, le calvizie, le risa, le rughe, la voglia irrefrenabile di futuro e di scopate.
Trent’anni dopo, come trent’anni prima: in mezzo soltanto tempo, ato a rimpiangere quello appena ato. Rivedo in quei volti sudati, i volti di allora. Non provo nostalgia, non provo niente: sono uno scrittore, e in quanto tale un bugiardo, un venditore di cronache e suggestioni vere, miste a finzione. Ecco, tocca il trenino. Tocca farlo, scrittore, mi dico. Inventa qualcosa, scrivi che dietro c’era una che ti toccava il culo e che davanti c’era uno che appena poteva frenava per farsi toccare il suo. Quanto tempo a bramare e raccontare sesso. Ecco un argomento da scrittori. Il dj spara “ people from Ibiza “ e tutti ridono e sculettano. Fatevi travolgere!, dice al microfono il ragionier dj Guidi. Suda in modo imbarazzante e sorride, tutto preso nella parte. È talmente ridicolo da risultare simpatico.
Apro gli occhi, guardo sotto di me, sul fondo sabbioso, in cerca di cavità: niente. Immagino sia stata una suggestione, un’allucinazione, un colpo di calore. Mi rimetto in moto, muovo braccia e gambe in direzione riva. Pochi minuti dopo arrivo, gli ultimi i pesanti sull'acqua bassa.
Prima di uscire, o in bagno a lavarmi le mani. Dentro una stanzetta vedo la sagoma "der pantagruelico", il Ciccio arrivato da Roma quando eravamo in terza; ci ha messo tre giorni a conquistare la simpatia di tutti e diventare uno di noi. Guardo meglio e vedo anche Seghetti, omino ormai untuoso, che fa il commercialista del festeggiato; ci sono anche Emma
Tuorlo, che gestisce un negozio di parrucchiera in periferia, Oreste Fragile, che lavora come facchino dopo aver chiuso l'azienda di traslochi di famiglia e la figlia di Bruno Buoso: non vedo bene, ma sento distintamente il movimento di narici. Questo non scriverlo, provo a dire allo scrittore, il quale annuisce, come a dire "certo come no, figurati". Mi lavo le mani, poi urino. Mi guardo allo specchio: lo scrittore mi osserva divertito; probabilmente sarò patetico nel dissimulare età e giudizio, mentre lui se ne fotte. E ci ride su.
Cosa scriverebbe uno scrittore di queste brevissime allucinazioni? Cosa direbbe di uno di mezza età che finge di accettare l’idea di una festa per sè, e non vi partecipa? Come scriverebbe di una giornata di sole, solitudine e silenzio?
Mi arriva come uno schiaffo il chiacchiericcio della gente stesa al sole. Mi irrigidisco, sento tornare in forza le difese verso il mondo ostile, percepisco la scomparsa della dolcezza, l'arroganza dell'istinto di sopravvivenza alle regole. Mi volto per un ultimo sguardo verso il mare. Ma la grazia è transitoria, e vedo solo sabbia e acqua.
Traversata
Mia madre insisteva con forza. Più era debole, fragile, sola, più s’impuntava e insisteva. Lo sai che tuo cugino è già andato, che se la cava bene, diceva sempre. E io rispondevo che era vero, ma che non potevo andare così, senza sapere cos’avrebbe fatto lei, da sola, senza appoggi, senza un uomo che la proteggesse. E lei diceva che non dovevo preoccuparmi, che i parenti le sarebbero stati vicini. Vai, è il tuo viaggio: ti spetta!
Nel nostro quartiere abitava uno che prestava i soldi: non si parte per un viaggio, senza; e lui te li prestava. Bisognava pensarci bene: guai a non restituirglieli, con gli interessi: avrebbe perseguitato tutta la famiglia, nessuno escluso, senza pietà. Aveva una memoria contabile infinita, e una crudeltà negli affari senza requie.
Per arrivare al punto ics bisognava partire almeno un giorno prima. Mia madre mi aveva preparato il bagaglio. Avevamo preso uno zaino, perché era grande come una valigia ed era più comodo da portare in viaggio. L’avevo abbracciata forte, le avevo giurato che l’avrei chiamata appena arrivato; avevo nascosto il mio viso al suo sguardo perché un uomo non si fa vedere quando piange. Lei invece non si era nascosta e mi aveva dedicato una bellissima poesia
d’amore, attraverso il suo sguardo. Volevo chiederle di dirmi la verità, volevo sapere dove fosse mio padre, perché era sparito, ma avevo taciuto: le avevo promesso di non parlarne più, e io mantengo le promesse. Il suo ultimo gesto era stato una carezza delicata sui miei capelli neri come la notte, come amava ripetere lei quando ero bambino.
Sono partito. Ho attraversato la pianura arida, il deserto, con un pullman vecchio e rumoroso, così pieno di gente che quasi mancava l’aria. Eravamo tutti sudati, stufi, tramortiti dalla polvere, dalle buche, dal caldo insopportabile, dalla mancanza di futuro, dall’evidenza del presente. Alla frontiera bisognava mettere un po’ di soldi dentro il documento e si ava senza problemi. A me è andata bene; a molte persone, soprattutto alle donne, invece, è andata male. Le hanno lasciate lì, al confine, senza documenti, senza bagaglio, senza più niente. Qualcuna invece, è stata portata via, dove si dice che, se va bene, escono sfigurate, incinte, ma vive. Se una di queste fosse mia sorella, mia cugina o mia madre cosa farei? Non mi sono risposto: ho solo chiuso gli occhi e pregato che certi pensieri non mi toccassero più.
Quando sono arrivato in centro città, sono andato al mercato, mi sono mischiato alla folla, ho camminato tutto il giorno da un banchetto all’altro, cercando di non farmi notare e tenendo sempre stretto lo zaino.
Quando ha iniziato a calare il sole, aiutato dall’odore di salso, mi sono incamminato verso il mare. Non avevo più molto tempo, non potevo permettermi di sbagliare posizione, né parlare con nessuno: mi avevano avvisato che qui è pieno di spie della polizia che, in cambio di poco, o perché costretti, denunciano chiunque.
Ho raggiunto la spiaggia, invisibile come tutti quelli come me. Ci siamo tutti nascosti tra gli alberi in attesa del segnale. La spiaggia era deserta, il mare era un immobile tappeto nero, il cielo, dapprima luminoso di stelle, si è via via incupito fino a sparire nel suo stesso buio. Il rumore delle onde si faceva sempre più rabbioso, il vento sparava la sabbia con violenza, l’elettricità dell’aria s’accoppiava alla nostra tensione.
All’improvviso il segnale. Dei colpi di luce ondeggiavano al largo. Siamo usciti di corsa, a decine: visti dall’alto saremmo sembrati formiche. Abbiamo raggiunto il peschereccio superando onde sempre più violente. Una volta saliti a bordo, tutti seduti sul ponte, gli spruzzi del mare, il gonfiarsi del vento, la pioggia che iniziava a scendere violenta. Il mio ultimo pensiero a te, madre, che mi proteggi col tuo amore che, lo giuro, ricambierò coi fatti: coi soldi per la casa e per il debito. Tornerò per rimanere: mi sposerò e farò figli che saranno nipoti felici. Sperando i in fretta questa notte di tempesta.
Era il 13 ottobre 2013, data in cui sono morte 363 persone
Skype
Ci sentiamo via skype. Il mio schermo mi fa vedere la mia faccia e la sua, in formati diversi, tridimensionali; oltre ai nostri volti, di contorno, le stanze dove abbiamo i computer. Da circa un anno ho cambiato residenza; lui da pochi giorni soltanto. Prima, a casa mia, la stanza dove leggevo e scrivevo, era più stretta e lunga, con le travi del sottotetto che scendevano da due metri e venti a un metro e dieci; ora è quasi quadrata, più ordinata, con scaffali di libri che non stanno nelle librerie in soggiorno, e che dovrei riordinare per autore e casa editrice senza riuscire a farlo mai. Da decenni, con gli ebook, è automatico: si sistemano da soli, basta indicare il criterio; volendo, si possono creare librerie virtuali a grandezza 1:1, con gli ologrammi. La mia collezione è antica, e per alcuni obsoleta; per me rappresenta il legame con quella che un tempo era la mia vita. Sogno di lasciarli ai miei nipoti, sperando riescano a cogliere l’amore con cui li ho raccolti: un amore che non è pratico, né conveniente; come dovrebbero essere tutti gli amori.
La stanza che vedo attorno a lui invece, è ancora precaria, fresca di trasloco; riconosco scatoloni, con scritte in inglese, con forme e colori diverse da quelli italiani. Mi capita di chiedermi se siamo noi a distinguerci da loro o viceversa. Nel periodo post-globalizzazione sono tornate in auge le forti caratterizzazioni nazionali, per chi può permetterselo. A lui piace parlare con me, tirare fuori da angoli nascosti, l’italiano: lo pronuncia con accento straniero per i primi minuti, poi si scioglie e torna l’uomo che un tempo era il mio migliore amico.
Skype ci costringe a primi piani che a tratti mi mettono in imbarazzo: nessuno dei due ci è abituato. Ricordo certi film che tentavano di ipotizzare il futuro, e che tra le tecnologie futuribili, c’erano videotelefoni; ricordo che mi chiedevo, allora, come sarebbe stato chiamare qualcuno e vederlo: ora che è possibile, da decenni, addirittura in 4D volendo, capisco che il sapore tra come si immagina qualcosa di futuribile, e quando l’immaginazione diventa concreta, cambia, e di molto. L’abitudine accelera e corrompe ogni novità.
Piove, tanto. Qui e là. Più là di qua. La pioggia scroscia talmente forte che dobbiamo alzare il tono della voce. Ad un certo punto il rumore invade ogni pensiero e ci lascia interdetti. Sento delle voci provenire da un’altra stanza. Lui si scusa, mi dice che lo chiamano, che lascia un momento la chiamata. Si alza, lascia la postazione, mi fa un gesto con la mano, come a dire che torna subito.
Osservo lo spazio lasciato libero: vedo scatoloni, la sedia sopra cui sedeva, la luce della lampada da tavolo, e poco altro, in penombra. Lo scroscio aumenta di intensità, diventa furioso. Lo schermo emette scariche elettriche, sembra un vecchio televisore che non trova il canale.
Il rumore diventa un rombo che si alterna al suono artificiale delle scariche grigionere dello schermo, e sembra preludere alla catastrofe. Sento frasi concitate provenire da altre stanze, voci che diventano improvvisamente urla e imprecazioni multilingue. Riconosco la voce del mio amico che grida “ le bambine, le bambine, forza usciamo, svelte”.
Prima che lo schermo diventi nero, mi pare di vedere porte e finestre che rinculano, costrette da una massa d'acqua potente e definitiva. Poi più niente. Deduco che la corrente è saltata, e che la vita del mio amico, in questo preciso momento, è pura emergenza vitale.
Anche qui piove a dirotto, e la temperatura, pur con la tara di umido, è primaverile. Sono almeno tre decenni che non torna l'inverno, e il mio corpo ormai vecchio, benché ancora totalmente immune da qualsivoglia malattia, ne risente. C'è stata la revisione del calendario, che ha ridotto le stagioni da quattro a due: primavera e estate. I miei nipoti sono nati e cresciuti in questa dimensione temporale, e la considerano naturale e ovvia. Ma il mio corpo ricorda, e soffre di una sorta di nostalgia biologica. Quello che mi manca di più è l’odore dell’aria fredda: puro, perfetto.
Si è tanto discusso di riscaldamento del pianeta, senza agire di conseguenza; ci si era divisi, tra chi voleva il contenimento dell'inquinamento ambientale, e chi lo
negava, adducendo idee di progresso tecnologico, il quale avrebbe fermato il progressivo ed evidente disfacimento climatico del pianeta. E mentre il futuro avanzava sempre più in fretta, l'imputridimento terrestre procedeva, accelerando anch'esso. E così, dei pochi testimoni del mondo che fu, siamo rimasti solo noi, vecchi tacciati di nostalgia, nutriti da futurviagra 4.0, da antidepressivi con effetto antimnemonico, rappresentati politicamente da leader ininfluenti, messi all'angolo dal ricatto delle comfort-community residenziali, obbligatorie per chi supera i settant'anni.
E non preoccupatevi per il mio amico. È già successo altre volte che la sua casa sia stata invasa dalle piene fluviali e dalle piogge incessanti. Ogni abitazione è costituita da elementi intercambiabili, e le fondamenta fungono da vasche raccogli acqua, che viene poi ripulita, sterilizzata, rimessa in circolo. Nel giro di un paio di giorni mi chiamerà, ci rimetteremo in videoconferenza con gli amici, e finiremo la partita di scopone scientifico che abbiamo interrotto causa forza maggiore. Tanto, con i nuovi farmaci antireumatici che ci somministrano qui assieme a quell'altra medicina che ci mantiene sessualmente attivi e mai depressi, rischiamo l'immortalità. Per fortuna siamo attrezzati, e chi non ne ha più voglia, di vivere, l'eutanasia legalizzata la si può scegliere tra diverse modalità di applicazione: sono tutte indolori, ovviamente, e si differenziano soltanto per la durata.
Ora però devo lasciarvi. Stanno arrivando i miei due nipoti, che staranno con me le tre ore settimanali,
utili a raccontare il mondo che fu, consentendo lo sviluppo della memoria affettiva, diventata ormai pedagogia riconosciuta. La cosa più difficile è quando parlo loro della neve: non riescono, se non in termini di fantasia favolistica, o di ologrammi, o di parchi a tema, a credere che esisteva in natura. Del resto, mi viene da aggiungere, perfino io e il mio amico, un tempo, siamo esistiti.
Piove
Piove una pioggia svogliata, cielo grigio, poca luce, nuvole basse a far da cappa alla città. L'autobus si ferma, salgo con altre diciannove persone. Sento un urlo, un'offesa a sentire i commenti, pronunciata con tono e linguaggio primordiale. Non ho capito cosa è stato detto, ma vedo correre il ragazzo che l'ha pronunciato, il quale fa gesti inconsulti all'autista. Tolgo le cuffiette, voglio capire. Sento solo brusio e non capisco niente. Arriviamo al semaforo, dei rumeni commentano tra loro l'episodio, il ragazzo continua a correre accanto al bus, accelerando e frenando, mantenendo una traiettoria parallela. Semaforo rosso, l'autista apre le porte, scende, l'altro scappa. Vieni qua, gli dice, se hai coraggio. Stronzo, aggiunge poi. Risale soddisfatto di sé, della fuga dell’altro, dell’apparente dominanza momentanea. Per tutta la strada, il ragazzo corre, l'autista lo guarda, mentre parla con una biondona russa coi jeans che le segnano il culo abbondante. Attorno a noi, uno dopo l'altro, negozi chiusi con scritto vendesi o affittasi. Su una trentina di negozi, almeno quindici hanno il cartello in vetrina e le serrande abbassate. E siamo in centro. Una zona dove pochi anni fa la vita pulsava. Ora è abitata per lo più da stranieri, il valore delle case ha subito un tracollo verticale, i negozi chiudono perché non ci sono più clienti.
Ogni tanto si vede qualche bar chiuso per intervento giudiziario. Il rapporto causa-effetto ottiene una concretezza stridente, e servono colpevoli a portata di mano.
Il ragazzo continua a correre. Ha un giubbotto di due misure più grandi, un cappello col frontino in testa, lo zaino, un paio di braghe larghe, scarpe da ginnastica. È trasandato, pare sporco. Continuano a guardarsi inscenando una sfida piena di tensione e allo stesso tempo ridicola. La natura del conflitto tra gli esseri, intrinseca ma negata, e perciò pronta ad esplodere improvvisa, è quasi palpabile. Fantastico che al prossimo semaforo il ragazzo prenderà a calci e sputi il bus, o che gli lancerà un sasso, che estrarrà la pistola e sparerà all'autista, che si trasformerà in martire suicida e compirà un'azione kamikaze, o chissà che. E corre, continua a correre, pur non avendo l'aspetto di uno che fa sport, che ha fiato e gambe buone, se non per scappare quando gli corrono dietro.
Le fermate si susseguono, la biondona col culo scende, i rumeni parlano tra loro, coi loro giubbotti in pelle fuori moda, seguendo con lo sguardo la donna. Piove, il cielo è grigio, i negozi in affitto o in vendita; uno aperto e uno chiuso, uno aperto e uno chiuso, e via così. L'autista guida nervoso, è tutto un susseguirsi di frenate e accelerazioni brusche, di commenti spigolosi. Siamo quasi arrivati a Venezia, le fabbriche di porto Marghera non soffiano più fumo mortifero. Questa città sta morendo, penso. Questo Paese sta marcendo, penso.
E qualcuno pensa che sia a causa degli stranieri. E molti non sanno che l'idiozia li abita, ed è indigena. Siamo quasi arrivati, mi rimetto le cuffiette. Guardo l'acqua bassa della laguna, le rotaie arrugginite del tram, ascolto gli Smiths che cantano " it's time the tale were told/ of how you took a child/ and you made him old...". All'improvviso una botta, una frenata, una donna senza culo col segno bianco della ricrescita, urla. Tolgo le cuffie. Davanti al bus il ragazzo giace a terra immobile.
Nero
Senti le mani impiastricciate, l’odore come di ferro, il silenzio perfetto, profondo, nero. Ti senti sfinito, pronto a rinascere.
Se mi dedichi la tua attenzione ti descrivo com’è il mio nero. Lo so che sei curiosa, che vorresti chiedermelo ma non ne hai il coraggio: sai stare al mondo, sai quello che si deve dire e quello che non è il caso di pronunciare, e sai che c'è un limite oltre il quale si scade nella maleducazione. Ma io mi ti concedo, ti esonero dalla fatica di esporti, dall’approfittare di me per soddisfare una tua curiosità; di cui però io sento il rumore, l’eco, lo scalpitio che procede a o di marcia, e che tu domi come fosse una bestia feroce, anziché una parte di te.
Hai visto che lei non vuole stare con sé? Hai visto come scarta quel che non le piace, come fosse un corpo estraneo? Vedi che ti consiglio sempre il giusto, che la tua è comione?
Ascoltami: il mio nero è come il buio assoluto, è come essere in una stanza senza finestre, senza porte, senza luce: non c’è altro che quel nero profondissimo. Se vuoi davvero immaginarlo, se desideri immergertene totalmente per un poco, in concreto, ti devo chiedere di provare a diventare me, e per far questo devi lasciarti andare e guidare. Ti chiedo uno sforzo: cerca di essere completamente qui, ora, senza pensare ad
altro. Ecco: ora sei me. Immagina di essere in quella stanza di cui ti dicevo, in quel buio; e di non essere più solo. Accanto a te c’è una persona, una donna. Se ti va di giocare fino in fondo, chiudi gli occhi, ascoltami, seguimi: ecco sei con me in quella stanza totalmente buia, di una tinta di nero che così non l’avevi mai nemmeno immaginata.
A volte arriva come un lampo, è una voce, un dolore, una distrazione, ma a subito. È una scossa che squassa e annulla ogni pensiero.
E sai che c’è qualcuno con te. Lo sai perché l’aria è diversa, c’è ora un odore nuovo, che cerchi da subito di codificare, che respiri facendolo scorrere tra le pareti delle narici, che arriva alla mente, che corre giù fino al diaframma. E poi ascolti, senti il suo respiro, ne segui il ritmo, provi a sincronizzarti con esso, fino a che, poco alla volta, lo penetri, lo interiorizzi, diventi amico dei suoi segreti biologici. E ancora, immagina le mani che cercano il suo corpo: inizi dall’alto, coi polpastrelli, dai capelli e piano scendi verso il viso, collo, spalle, seno, pancia, la fessura che piano s’inumidisce, le cosce, ginocchia, piedi; e da lì risali da dietro, dal basso verso l’alto stavolta. Senti i pori della sua pelle farsi evidenza a contatto con le tue mani, senti il sudore, il calore, le vibrazioni dell’eccitazione.
E poi con la lingua e la bocca rifai il percorso perché vuoi conoscere il suo sapore. Labbra e lingua ti trasmettono il suo sapore. Rotei, infili, sfiori, lasci scie. Ora sai tutto di lei. Conosci il suo profumo, il suo respiro, il suo corpo, il gusto della sua pelle. E ora tocca a lei. Ti annusa, ti ascolta, ti tasta, ti assaggia. Alla fine sapete tutto quello che c’è da sapere, tranne l’aspetto formale, perché il nero impedisce qualsiasi immagine, ma tanto non serve, non più: l’intimità annulla la forma. I vostri corpi si bastano, la mente lavora con gli altri sensi, le sono sufficienti. La vista è un senso sopravvalutato, di cui però si può fare senza, solo se acuisci gli altri. E se tutto fosse così, risponderebbe allo stesso meccanismo di conoscenza neurologica e sensoriale. Se il mondo fosse nero, sarebbe comunque il mondo. Il mio nero è così, si accende senza colori, si adegua ad un modo altro di esistere, fino a tararlo alle sue necessità.
E tornano ancora quei lampi, quelle voci, la bava della rabbia ti colpisce, ti penetra e improvvisamente scompare. Tienila a bada, domala e gustala: ancora per poco.
Questo è il mio nero, il mio buio felice, la mia scala di valori non visiva, la mia consuetudine esistenziale. E adesso ti dirò il resto, quello che non potevo dire prima. È stato semplice dopo che eri venuta, dopo che ti avevo saziata, ti avevo resa felice, condurti al di là. Stringere un poco, sentire lo spessore della giugulare, il sangue che scorreva, stringere ancora un po’ fino alla fine del respiro, della circolazione, della coscienza. Sei ata dagli spasmi dell’orgasmo alle convulsioni, alla scomparsa definitiva della luce, alla pace, in un unicum spazio-temporale. Ho infilato le dita nelle tue orbite, ho estratto le due palle mollicce, me le sono ate sulla pelle, le ho toccate, annusate, leccate, le ho inghiottite, e poi basta. Ho soltanto voluto regalarti un’esperienza, una morte felice, dopo il culmine del piacere. Così non subirai la violenza della vita, la sua decadenza, la sua progressiva e inarrestabile fine.
Hai solo ubbidito alle scosse violente procurate da quelle voci che ti ordinavano il da farsi.
Ora conosci anche tu la profondità, la consistenza del mio nero.
Addio
Visita www.priamoedit.it
o segui Priamo su
Meligrana Editore Via della Vittoria, 14 – 89861, Tropea (VV) Tel. (+ 39) 0963 600007 – (+ 39) 338 6157041 www.meligranaeditore.com [email protected]
Scopri tutti i nostri ebook su
Smashwords.com