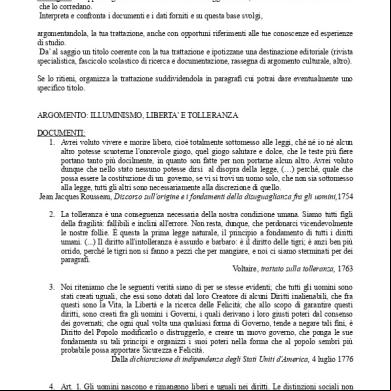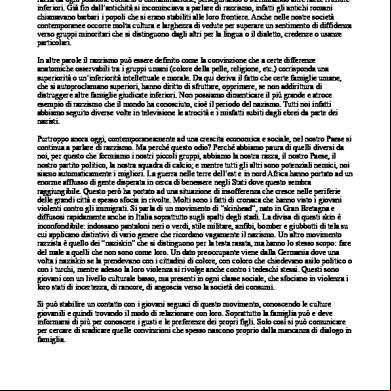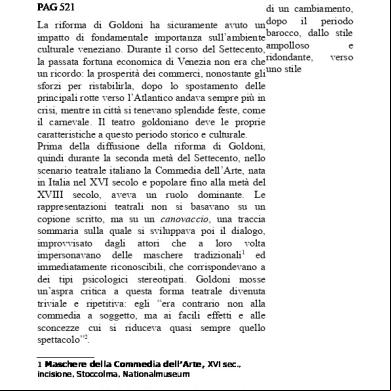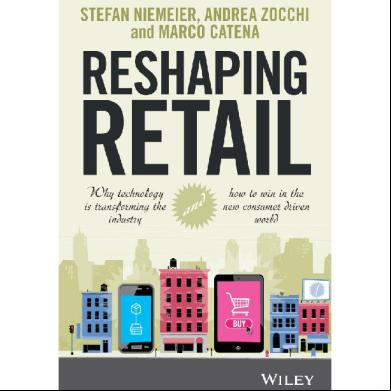La Tempesta: Saggio Breve 5y6h6h
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View La Tempesta: Saggio Breve as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 6,456
- Pages: 43
- Publisher: Meligrana Giuseppe Editore
- Released Date: 2015-09-09
- Author: Gianluca Mungo
La tempesta saggio breve
Gianluca Mungo
Published by Meligrana Editore
Copyright Meligrana Editore, 2015 Copyright Gianluca Mungo, 2015
Tutti i diritti riservati ISBN: 9788868151447
In copertina: Vincent Van Gogh, Il mare a les Saintes - Maries de la mer Giugno 1888, olio su tela, 51x64cm.
Meligrana Editore Via della Vittoria, 14 – 89861, Tropea (VV) Tel. (+ 39) 0963 600007 – (+ 39) 338 6157041 www.meligranaeditore.com [email protected]
Segui la Meligrana su:
Facebook
Twitter
INDICE
Frontespizio
Colophon
Licenza d’uso
Gianluca Mungo
Copertina
Navi e tempeste Tempeste di parole e piogge di falene La primavera hitleriana
Conclusioni
Bibliografia
Altri ebook di Meligrana Editore
Note
Licenza d’uso
Questo ebook è concesso in uso per l’intrattenimento personale. Questo ebook non può essere rivenduto o ceduto ad altre persone. Se si desidera condividere questo ebook con un’altra persona, acquista una copia aggiuntiva per ogni destinatario. Se state leggendo questo ebook e non lo avete acquistato per il vostro unico utilizzo, si prega di acquistare la propria copia. Grazie per il rispetto al duro lavoro di quest’autore.
Gianluca Mungo
Gianluca Mungo è nato a Crotone nel 1979. Dopo aver compiuti i primi studi a Catanzaro, si è laureato a Siena in Filosofia. Successivamente, ha compiuto studi anche ad Heidelberg, Firenze e Pisa, divenendo sia insegnante delle scuole superiori di secondo grado sia dottore di ricerca. I temi di suo interesse sono da sempre Platone e la filosofia classica. Ha pubblicato presso Meligrana Editore il testo ‘Il Sole e il Bene’ e alcuni articoli sul blog ‘Carte sensibili’.
Contatto autore: [email protected]
Navi e tempeste
Nel presente lavoro, desidero occuparmi di un tema ampiamente sviluppato in ambito poetico e artistico: La tempesta. Spesso utilizzata come metafora di una certa condizione umana o simbolo di un’intera situazione, la tempesta, come elemento fenomenico, non ha mai mancato di affascinare quanti hanno visto, nel suo manifestarsi, una potenza distruttiva e spiazzante con cui l’uomo è chiamato a fare i conti. Spesso alla tempesta si contrappone la quiete di un paesaggio naturale dove si armonizzano le diverse forme di vita, quasi, però, dimenticando che la tempesta stessa è anch’essa espressione di vita da parte della Natura. È chiaro, comunque, che, istintivamente, si sia indotti ad ascrivere alla tempesta caratteri negativi. La percezione che l’uomo tende, infatti, ad avere di un simile fenomeno è quella di pericolo e, come ogni cosa che appare pericolosa agli occhi umani, anche di elemento con una forte dose di fascino. Ne è prova la nutrita produzione artistica e letteraria che ha, appunto, una tempesta come elemento principale di una narrazione o come sfondo di una scena. Nella presente sede, voglio, però, analizzare il tema della tempesta così come esso viene affrontato in un ambito più strettamente filosofico nella sua veste di metafora della condizione umana. Il mio pensiero va a due autori della classicità che, utilizzando immagini di equipaggi in difficoltà o di tempeste propriamente dette, arrivano a conclusioni diverse riguardo, in particolare, al ruolo del saggio/sapiente nella società: Platone e Lucrezio. Entrambi ci descrivono la condizione umana simile ad una barca in preda alle onde o a problemi di organizzazione interna. Nel VI libro della Repubblica, Platone ci paragona, per esempio, la vita della polis ad una nave che necessita di una guida in un momento di forte crisi. Il pericolo, però, non proviene, in questo caso, dall’esterno: la vera tempesta che il filosofo vuol qui descrivere si svolge tutta all’interno della nave/città. Riporto il testo:
“Pensa che su molte navi o su una soltanto stia succedendo una scena come questa: figuriamoci un nocchiero superiore per grandezza o forza fisica a tutti i membri dell’equipaggio, ma piuttosto duro d’orecchio e così pure corto di vista e con altrettanto scarse conoscenze di cose navali; e i marinai che altercano fra loro per il governo della nave, ciascuno credendosi in diritto di governarla lui, mentre non ne ha mai appreso l’arte né può dichiarare con quale maestro e in quale tempo l’ha appresa; e inoltre affermano che quest’arte non si può insegnare, pronti anche a fare a pezzi chi la dica insegnabile; tutti sempre stretti attorno alla persona del nocchiero, a pregarlo e premerlo in tutti i modi perché affidi loro la barra¹.” (Rep., VI, 487 – 488)
L’immagine della nave, che abbiamo visto descritta nel brano appena letto, precorre, per molti versi, il celeberrimo o della Caverna e riesce, forse, per taluni aspetti, ad essere ancora più emblematico. In tale immagine, si ravvisano, infatti, tutti gli elementi platonici riguardanti il ruolo del filosofo e della filosofia all’interno di una società e al rischio cui va incontro un professato amore per la verità. Da una parte, l’accusa più stereotipata che possa essere rivolta alla filosofia vale a dire quella di essere inutile chiacchiera per via della sua vocazione ad una conoscenza del Tutto; dall’altra il dovere che, secondo Platone, dovrebbe essere proprio del filosofo, colto nella sua vocazione ad andare avanti allo scopo di portare un messaggio di coerenza tra un certo dire ed un certo fare. Il filosofo platonico ha, pertanto, un dovere verso la società che nasce dalla sua stessa inclinazione a filosofare e in particolare nella politica ovvero nell’educazione ad una certa vita spirituale e nel contempo pratica, la filosofia vede compiersi il proprio destino. Nell’esempio della nave è palese sia la consapevolezza che Platone ha delle accuse di inutilità mosse alla filosofia e della visione, assai superficiale, che di essa la società del tempo, in maniera non dissimile dalla nostra, si era fatta che l’intenzione di sottolineare un ruolo specifico della figura del filosofo all’interno di questa stessa società. Nel mito della Caverna, i filosofi sono coscienti di rischiare anche la vita nel loro portare avanti un messaggio di verità, così come di ricevere pure un’offesa di natura morale ben più grave: la denigrazione del loro logos che arriva a porre il filosofare ai livelli di follia se non di insensatezza. In fondo, non v’è aggettivo più dissacratorio per un filosofo di quello di “acchiappanuvole” (‘scrutatore del
cielo’). Il fatto che nell’arco della stessa opera una simile questione ritorni due volte in due esempi e in due libri diversi, suggerisce quanto sia importante, all’interno della filosofia socratica e platonica, la riflessione sul senso vero della filosofia. Dalle cronache del tempo, si evince, per esempio, che, coerentemente al suo stile ironico, Socrate riesce, forse per primo, a prendere in maniera bonaria la critica mossa a chi dà un certo e particolare quanto sarcastico alone al filosofare. Sappiamo, infatti, che un buon rapporto lo legava ad Aristofane e che non disdegnasse di assistere, con un certo piacere, alla rappresentazione delle “Nuvole”. Nel VI libro della Repubblica, l’interlocutore di Socrate, però non è Aristofane, ma un amico che sembra quasi volersi sfogare del fatto che a molti la Filosofia appaia come un’inutile perdita di tempo. Perché, infatti, porre tanta attenzione ad un qualcosa di propedeutico alla politica? La cultura classica vedeva nella politica il fine ultimo e l’occupazione principale della vita di un uomo: il cittadino della polis era chiamato a partecipare attivamente alla vita politica della propria città e le scuole di retorica e pensiero fungevano a formare i futuri rampolli della classe dirigente. La filosofia, in tale contesto, era vista dai più come una sorta di mero esercizio intellettuale che era bene, crescendo, mettere da parte. La risposta socratico/platonica confluirà nella famosa provocazione (uno dei tre “scandali” di cui parla Vegetti²) di presentare i filosofi come gli unici degni a salire al potere. La filosofia non s’identifica, così, con l’infanzia dell’umanità, bensì con la sua crescita e in un’opera quale il Fedone la stessa viene chiamata ad educare l’uomo alla preparazione della conclusione della propria vita. Una compagna, quindi, che segue la vita dell’uomo lungo tutte le sue tappe fino al suo epilogo. Per il singolo, l’opera della Filosofia finisce quando si conclude la vita di questi, una continua conversazione il cui “Alt!” è suonato dalla morte dell’individuo, ma che prima di allora è servita ora a demitizzare, ora a costruire una vita esistenziale più autentica e un atteggiamento più maturo e sereno verso la morte e, di conseguenza, verso le cose della vita. Nel momento in cui si parla di collettività, si parla però di storia dell’umanità e gli interrogativi qui coinvolgono tutte le contraddizioni tra un dire e un fare cui la vita quotidiana dà adito. In tal caso, la filosofia non può esaurire il suo compito con la morte di un individuo, ma deve andare oltre: è chiamata a dare un segno tangibile nella storia e ciò può farlo solo con la “paideia”. Il compito del filosofare è, pertanto, educare ad una ricerca più solida di una certa moralità. La nave non può continuare a stare in balia delle acque e delle chiacchiere che la bloccano, gli “acchiappanuvole” devono cercare di condurla ad un porto stabile. Quello che abbiamo, quindi, qui definito come una sorta di “tempesta interna” è, in realtà,
una partita interamente umana: da una parte gli eventi; dall’altra l’opera di un essere dotato di raziocinio, ma anche di ione e come tale volubile. L’aspetto più peculiare dell’esempio della nave è che Platone non ci dice se effettivamente una simile imbarcazione si stia trovando in condizioni critiche da un punto di vista climatico e naturale: non ci viene descritto né uno stato di bonaccia né di tempesta, ma un autentico “tram tram” interno che arriva a sconvolgere la normalità della vita quotidiana di una polis in qualsiasi momento. In uno stato in cui tutti vogliono governare e fomentare i propri egoistici interessi, come più volte nota Stenzel³, gli unici a restare fedeli alla propria “paideia” e a cercare di porre una certa Phronesis a guida dell’immaginaria nave saranno appunto i saggi, i quali si ritroveranno, però, ad essere inascoltati. Nella visione platonica, malgrado tutto, questi stessi saggi rimangono comunque al loro posto all’interno della nave, continuano a dimorare dentro di essa e non si allontanano neanche dopo la derisione. Subiscono il destino della nave né più né meno di come Socrate accetterà il proprio e questo nonostante essi sappiano in che modo andrà a finire una navigazione così mal gestita. Per via di un simile modo di insistere sulla questione, Platone si rivela un pensatore “greco” e, nella fattispecie, “ateniese”: l’attività politica è e resta un bene, il fine ultimo in cui lo spirito filosofico deve concretizzarsi. A distanza di anni, diametralmente opposta sarà la visione che Lucrezio avrà della filosofia e della politica: nel celeberrimo o del II libro del “De rerum natura”, viene descritta una tempesta sul mare, ma, soprattutto, viene commentato il piacere che si può provare nell’osservarla, sapendo di non essere da questa toccati a differenza di chi invece deve affrontarla, rischiando la propria vita. Anche se non viene direttamente menzionato, è chiaro che il riferimento va all’equipaggio di una nave. Stavolta si tratta dunque di una tempesta in piena regola e l’ipoetico equipaggio che si può intravedere tra le righe è costretto a barcamenarsi e ad impiegare tutte le forze per non fare affondare la nave e cercare letteralmente di salvare almeno la pelle. Da lontano, assiste alla scena un saggio che, pur provando comione per i poveri uomini, guardando al proprio stato interiore, gioisce del pensiero di vivere una situazione ben diversa. Facendo leva sul senso di sicurezza che psicologicamente ciascun uomo è indotto a provare quando si accorge di non esser toccato dal pericolo che incombe su altre teste, Lucrezio scrive:
“È dolce, quando i venti sconvolgono le distese del vasto mare,
guardare da terra il grande travaglio di altri;
non perché l’altrui tormento sia un giocondo diletto,
bensì perché t’allieta vedere da quali affanni tu sia immune⁴.”
(De Rerum natura, libro II, vv. 1-4)
E’ cambiata un’intera epoca e la nostra nottola di Minerva prende atto di quanto, nel frattempo, è avvenuto: la politica ha smesso di essere la principale occupazione degna di ogni uomo libero, la polis non chiama più a sé i suoi cittadini e la filosofia cambia il proprio ruolo. Se prima Platone spingeva il vero filosofo ad entrare nella caverna e a correre il rischio di farsi deridere sulla nave, in omaggio ad una visione in cui la filosofia deve diventare una sola cosa con la politica, in Lucrezio è l’esatto opposto: la filosofia deve allontanare l’uomo dagli affanni della quotidianità e sostituire un proprio chiuso spazio interiore al Daimon socratico, che, invece, pungola l’uomo a un ‘non fare’ che di fatto è, in realtà, una spinta ad agire. Si fa sempre notare, a riguardo, come il Giardino epicureo sia lontano dalla città né più né meno di come l’Accademia e il Liceo avevano sede al suo interno. La tempesta descritta da Lucrezio non è causata dagli uomini desiderosi di potere, ma è un evento esterno che si abbatte su una società e che coinvolge quanti sono al suo interno. L’intellettuale sa che il rimedio è allontanarsi e trovare una certa solidità nel proprio animo, cosa, questa, che conferma come la ricerca di quiete intesa come lontananza dagli affanni sia l’unica strada percorribile per ottenere una vita beata. È impressionante quanto abissale sia la
distanza tra i due autori: un saggio per Platone non può godere di una sua distanza dai problemi umani e quel che in Lucrezio diventa motivo e sintomo di serenità e di distacco, in Platone sarebbe stata impotenza e, pertanto, situazione da non ricercare. La filosofia ha, in Platone, senso solo quando diventa mero interesse per l’uomo e per i suoi interrogativi e si apre a quella che è un’autentica prassi politica. In Lucrezio, invece, il compito del filosofare consiste nell’alienare il saggio dalle ioni quotidiane: la politica è, così, tanto più in Platone un terreno di ioni come d’ideali in cui filosofare significa tracciare le differenze delle une dalle altre quanto in Lucrezio è solo cumulo di ioni e di affanni legati ad un momento effimero che conduce l’uomo ad una manifesta vanitas vanitatis. Il filosofo epicureo non trova, dunque, posto all’interno della barca, ma preferisce starsene lontano e eggiare sulla sicura terraferma, guardando, in maniera distaccata, la società né più né meno di come il filosofo platonico assiste le cose all’interno di essa e parla con i suoi diretti protagonisti. Prepararsi alla morte in Socrate voleva, inoltre, significare vivere intensamente le cose della vita e meditarle; in Lucrezio la morte ideale è, come in Epicuro, il sereno spegnimento di una vita interiore conscia della materialità dell’esistenza e della necessità di distaccarsi dalle vacuità della vita quotidiana. In entrambi gli autori, la metafora di una nave con il suo equipaggio in pieno affanno è usata con intenzioni, come abbiamo visto, diverse. Nel secondo di essi, in particolare, si avvertono gli echi di un’epoca in cui la politica è uscita dalle piazze per chiudersi nei palazzi di potere e la discussione è affrontata all’interno di chiuse stanze. I problemi dell’uomo iniziano ad essere, così, marcatamente ancora più individuali ed esistenziali e, soprattutto, non più oggetto della “politica”. Se nell’Etica Nicomachea, Aristotele continuava ad insistere che fine della politica fosse l’eudaimonia⁵, in Epicuro prima e in Lucrezio dopo cambia l’ottica della “felicità”: essa non è amministrazione e cura del bene comune o, meglio, della giustizia vista come dimensione per realizzare la ricerca etica e pertanto filosofica, né, tanto meno, ricerca di un Sapere superiore quanto distacco dagli affanni quotidiani mentre quel che in Platone come in Socrate era dovere del filosofo, negli epicurei diventa mera ambizione. L’uomo, in sostanza, cessa di essere uno “Zoon politikòn” per divenire soprattutto individuo. Prendere coscienza della materialità dell’esistenza è il primo o per
comprendere la vacuità delle ambizioni umane e la filosofia invita il saggio a non affrontare mai la tempesta, ma a guardarla, un po’ compiacente, da lontano. Un poema che iniziava con l’inno a Venere e si chiudeva con la drammatica rappresentazione della peste di Atene induceva, secoli dopo, un San Gerolamo a ipotizzare il sopravvento della follia nella mente dell’autore. Vista da una certa prospettiva, in realtà, la descrizione di un malessere che, appunto, al pari di una tempesta si abbatte su una città come Atene in piena gestione di una strategia di guerra quale quella voluta da Pericle per controbattere l’offensiva spartana, dovrebbe far meglio cogliere l’essenza della vacuità umana che sta alla base dell’esasperata ricerca di un trionfo, non curante che tutto ha una fine, che gli eccessi volgono sempre al peggio e che l’uomo nulla può contro gli imprevisti (Pericle non poteva certo prevedere che l’ammasso di gente all’interno delle mura del Pireo avrebbe facilitato il diffondersi dell’epidemia) e contro un destino che porta necessariamente al nulla. L’unica soluzione che l’uomo può trovare è a livello individuale e non collettivo ovvero accettare la realtà nella sua essenza materiale e nella sua caratteristica di esser sempre e comunque volta ad una fine per dedicarsi, così, alle poche cose importanti che possano assicurare una certa serenità interiore, tenendo, di conseguenza, lontani i falsi timori (morte e dei) e gli inutili affanni. Socrate e Platone, a differenza di Lucrezio, avevano, però, assistito direttamente allo sfascio di Atene e da tale esperienza avevano tratto l’interesse più vivo per affrontare direttamente i problemi della vita etica e politica, dando alla filosofia un ruolo di farmaco molto diverso da quello che avrebbe poi descritto Epicuro. Al pari di una medicina che consente ad un corpo malato di riacquistare salute e vigore per riprendere le attività di sempre, il filosofare avrebbe dovuto restituire all’anima i suoi orizzonti più propri e, quindi, riconsegnarla ad una sfera politica. Tanto in Platone quanto in Lucrezio, la metafora della tempesta non è, dunque, semplice riferimento alla politica, ma alla vita in generale così come essa va affrontata giorno per giorno: il male in Platone si può curare; in Lucrezio è solo da accettare e da tenere lontano.
Tempeste di parole e piogge di falene
Facendo un salto di parecchi secoli, si può notare che, da un punto di vista simbolico e letterario, la tempesta continua ad essere immagine di forza, ma anche di turbamento sia per il singolo che per un’intera comunità. Ad essa viene sempre accomunata l’idea di un qualcosa che si abbatte violentemente su una certa quotidianità, sconvolgendone l’ordine. Non è un caso che nel Novecento all’immagine della tempesta venga associata l’idea di una guerra o di una dittatura. Nei riguardi della politica, i due atteggiamenti prima analizzati che la classicità ci ha consegnato restano fondamentalmente immutati: se la Grecia di Platone era una terra di poleis e di tirannidi e la Roma di Lucrezio conosceva i germi delle diverse metamorfosi che il corso della storia le avrebbe fatto incontrare, l’Europa del Novecento è un continente di democrazie e di dittature totalitarie. La filosofia non cambia quella posizione che Platone aveva descritto nel VI libro della Repubblica ovvero di disciplina inascoltata e ridicolizzata dal potere (ormai si è andata a fare sempre più marcata la distinzione tra “uomo di pensiero” e “uomo d’azione”). Gli intellettuali sono comunque chiamati a prendere una posizione nei riguardi del potere: Se Camus paragonava il Nazismo alla peste, c’era chi, come D’Annunzio, diffondeva un’immagine di uomo tipicamente legata agli entusiasmi dell’epoca e la bellissima “Pioggia nel Pineto” dava un’incisiva immagine di fusione tra forze naturali ed umane. Ben presto, però, la realtà avrebbe mostrato il suo vero volto e le promesse fatte da un qualsiasi tiranno del Novecento si sarebbero rivelate le stesse megalomanie tanto osteggiate millenni prima da Platone. I due intellettuali che, nella presente sede, eleggo, quindi, a “campioni” del Novecento sono due figure molto diverse tra loro: Eugenio Montale ed Hannah Arendt. Entrambi vivono il fenomeno del Nazismo e del Fascismo, ma ambedue consegnano un’immagine molto diversa del rapporto intellettuale/potere. La Arendt propone, in fondo, malgrado alcune sue osservazioni (per la verità, in ‘Vita activa’, un po’ fuorvianti), un vero ritorno al mondo classico e filosofico di Platone. Ne “Le origini del Totalitarismo” ci descrive, così, l’evolversi di un fenomeno che, nella perseverante cura della propaganda di massa, finisce, tramite una sorta di pioggia incessante dove le gocce d’acqua sono sostituite da parole e slogan, per entrare nel cervello della gente fino a fare un’autentica
violenza concettuale alla spontaneità ed alla libertà del pensiero. Spina dorsale di un totalitarismo, secondo lo Arendt, è la sua intrinseca coerenza logica, così come suo fine è far rientrare l’intera realtà all’interno di un suo concetto, parcellizzando, frantumando e, infine, annullando l’individualità di ciascun singolo. Un’ideologia dittatoriale nasce, infatti, con un’operazione di concettualizzazione della realtà e una tempesta di parole, suoni e immagini inneggianti sono il mezzo più efficace per raggiungere un simile obiettivo e con esso il consenso delle masse. Da una politica di classi si a ad una propaganda di e per le masse. Senza consenso la dittatura si annulla: la retorica di un regime fa necessariamente leva sulle immagini di forza, di stabilità e di “assolutamente buono e giusto”, rispolverando tutte le tecniche che i sofisti avevano insegnato per storpiare i lineamenti della verità, al fine di irrigidire l’intera realtà dentro un concetto il cui mantenimento ad oltranza è indispensabile per la sopravvivenza del regime stesso oltre che per assicurarsi poteri sempre più ampi. Il concetto violenta, in questo modo, la realtà per poi trascurarla e sovrapporsi ad essa. In natura, una normale tempesta sconvolge lo status quo delle cose per poi aprire ad una rinnovata quiete; una dittatura, invece, stravolge per poi immobilizzare. Da cosa trae, però, un totalitarismo la sua vera forza? La risposta della Arendt è una delle più incisive: dall’indifferenza del cittadino verso i valori di una civiltà. È interesse dei regimi mantenere tale indifferenza e da ciò si spiega l’abolizione e la persecuzione spesso attuata nei confronti della libertà di pensiero e di espressione. Nelle pagine finali delle Origini del totalitarismo la Arendt scrive:
“La coercizione del terrore totale, che irreggimenta le masse di individui isolati e la sostiene in un mondo che per esse è diventato un deserto […] Come il terrore, anche nella sua forma pretotatle, semplicemente tirannica, distrugge tutti i legami fra gli uomini. Così l’autocostruzione del pensiero ideologico distrugge tutti i legami con la realtà […] Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione tra realtà e finzione, tra il vero e il falso non esiste più .”
L’autrice fa, quindi, una distinzione molto profonda tra isolamento ed
estraniazione:
“L’isolamento e l’impotenza, cioè la fondamentale incapacità di agire, sono sempre stati tipici delle tirannidi. […] L’isolamento e l’estraniazione non sono la stessa cosa. Posso essere isolato – cioè in una situazione in cui non posso agire perché non c’è nessuno disposto ad agire con me – senza essere estraniato; e posso essere estraniato – cioè in una situazione in cui come persona mi sento abbandonato dal consorzio umano – senza essere isolato. […] Mentre l’isolamento concerne soltanto l’aspetto politico della vita, l’estraniazione concerne la vita umana nel suo insieme⁷.”
L’isolamento non è, di per sé, estraniazione, ma può diventarlo ed è tutto interesse dei regimi far sì che divenga tale. Resta sicuramente abissale la differenza tra la scelta di isolarsi e il subire un’estraniazione: un uomo, intellettuale o no, può volutamente decidere d’isolarsi, di distaccarsi, sia pure per meglio meditare le cose della propria esistenza e/o della vita in generale. Nell’isolamento, si può trovare un’isola di pace e di quiete per poter prendere serenamente coscienza di una data realtà e cercare di elaborare una risposta ad essa. Estraniare significa, invece, alienare, annullare interessi e vitalità allo spirito dell’uomo, rendendolo apatico e restio ad ogni forma di reazione ad un regime. I sudditi ideali di una dittatura sono, pertanto, assai simili ai plagiati, timorosi abitanti degli orwelliani continenti descritti in 1984. l’estraniazione leva il coraggio e la libertà di volere o di negare (dire “No!”) propri dell’essere umano, facendolo divenire lo strumento principale per il protrarsi di uno status totalitario. La Arendt, per scongiurare il pericolo di avere un popolo di estraniati, propone, dunque, un ritorno all’interesse vivo che legava il cittadino greco alla sua polis. All’indifferenza deve subentrare la ione di un interesse e all’apatia la cura della cosa pubblica. Resuscitando e mantenendo, infatti, lo spirito della Boulé, intesa come assemblea viva di uomini liberi chiamati a dire la propria, la democrazia rafforza le proprie radici, relegando ad un margine sempre più ristretto uno spirito totalitario. Nel momento in cui, invece, si attua lo scarto tra individuo e comunità, si viene a definire quel tipico vuoto spesso riempito da una dittatura. Avvicinare il cittadino alla propria collettività è, dunque, l’unico modo per scongiurare il ritorno di un tale vuoto nella storia civile di un popolo.
Il totalitarismo, in fondo, proprio in quanto fenomeno di massa, non può essere arginato da una politica classista ed elitaria, che vede solo in qualche nicchia il proprio consenso. Per impedire il sopravvento di una tirannide è necessario che il popolo divenga spazio d’incontro tra individui in cui ogni membro si percepisca come parte armonica di una comunità e dove il proprio diritto politico giunga a prendere l’aspetto di dovere morale e primaria aspirazione di un uomo nella vita. La “massa” o, meglio, il cittadino diventerebbe, in questo modo, non più oggetto e territorio fertile su cui fare propaganda, bensì primo soggetto della storia di un paese. Se la filosofa Arendt spinge, quindi, l’uomo, in particolare l’intellettuale, a riappropriarsi della sfera politica e a muoversi verso la gestione della cosa pubblica, manifestando interesse a ché le regole del gioco vengano rispettate per aprirsi ad una forma di partecipazione di democrazia diretta intesa, in primis, come discussione aperta, di ben altro avviso è il poeta Eugenio Montale. Se virtualmente possiamo costruire un ponte che lega il Platone del VI libro della Repubblica alla Arendt che analizza il fenomeno del totalitarismo, mettendo a confronto anche le due visioni di “tempeste interne”, che generano la tirannide, altrettanto possiamo fare, con le dovute differenze e cautele, tra i poeti Lucrezio e Montale. La Arendt e Montale sono, per prima cosa, autori sicuramente diversi in tutto: Montale, a differenza della filosofa tedesca, predica un “aristocratico distacco” verso la società e alla presa di coscienza che l’esistenza è attanagliata dal “male di vivere”, dal cui cerchio non si po’ fuggire e che si può solo rappresentare tramite uno stile “scabro ed essenziale”, fa eco un rifiuto, da parte del poeta, a rendersi partecipe di talune vicende umane che, nel loro insieme, non fanno altro che esasperare la condizione del male di vivere che abbraccia ogni forma di vita presente sulla faccia della terra. Se ne deduce il poco impegno politico che Montale, malgrado la sua nomina a senatore a vita, poté avere in quanto poeta: le sue tematiche ruotano, soprattutto, attorno al tema dell’esistenza e al ruolo della poesia come rappresentazione e rifugio. Tuttavia, possediamo anche qualche scritto di Montale che ha un carattere più propriamente politico e non solo esistenziale, il più suggestivo dei quali è sicuramente il componimento poetico “La primavera hitleriana”, che ritengo opportuno riportare qui per intero e di cui consiglio vivamente la lettura, la quale, come si noterà, procede secondo ritmi incalzanti quanto incisivi da un punto di vista emotivo:
La primavera hitleriana
Né quella ch’a veder lo sol si gira.... DANTE (?) a Giovanni Quirini
Folta la nuvola bianca delle falene impazzite turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, stende a terra una coltre su cui scricchia come su zucchero il piede; l’estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai.
Da poco sul corso è ato a volo un messo infernale tra un alalà di scherani, un golfo mistico e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito, si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive benché armate anch’esse di cannoni e giocattoli di guerra,
ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi, la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue s’è tramutata in un sozzo trescone d’ali schiantate, di larve sulle golene, e l’acqua séguita a rodere le sponde e più nessuno è incolpevole.
Tutto per nulla, dunque? - e le candele romane, a San Giovanni, che sbiancavano lente l’orizzonte, ed i pegni e i lunghi addii forti come un battesimo nella lugubre attesa dell’orda (ma una gemma rigò l’aria stillando sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi gli angeli di Tobia, i sette, la semina dell’avvenire) e gli eliotropi nati dalle tue mani - tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e ha punte di sinibbio.... Oh la piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte! Guarda ancora
in alto, Clizia, è la tua sorte, tu che il non mutato amor mutata serbi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbàcini nell’Altro e si distrugga in Lui, per tutti. Forse le sirene, i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda, si confondono già col suono che slegato dal cielo, scende, vince col respiro di un’alba che domani per tutti si riaffacci, bianca ma senz’ali di raccapriccio, ai greti arsi del sud... (da “La bufera”)
La poesia rievoca la storica visita di Hitler a Firenze nel 1938 cui Montale poté assistere di persona. Sin dal primo verso, il componimento ci proietta in un clima surreale: dal cielo sulla città si abbatte una pioggia di falene impazzite, che cadono e muoiono per terra, riempiendo le strade dei loro cadaveri che scricchiolano “come zucchero” sotto il tacco delle scarpe. Alla pioggia di falene, corrisponde un gelo improvviso che sembra emanarsi da un’estate che ancora deve venire, ma che già cova, nel suo interno, una tremenda inquietudine. Pare essere l’intera natura a voler rifiutare e manifestare il proprio dissenso ad un evento che non s’identifica con l’umano e che non viene mai citato per nome, ma che ben presto si manifesta nell’immagine di un “messo infernale”, che, sull’auto che lo porta si fa strada tra “alalà di scherani” e croci uncinate. Molto forte è la contrapposizione tra una simile immagine di Hitler, che impersona il Male e che viene, così, paragonato ad un “messo infernale” inghiottito come da
un turbine di folla e una Natura che manifesta una sorta di negazione verso un suo stesso figlio, che, di fatto, pare essere del tutto contro-natura, in quanto pericolo e fonte di inquietudine per la natura stessa. Alla pioggia di falene, ad un’atmosfera come bloccata, ad un gelo improvviso e alle finestre delle case e delle vetrine dei negozi che, per protesta, si chiudono e si sbarrano, fa eco lo scroscio delle acque del fiume Arno, le quali vorticano indifferenti e che sembrano, man mano che le porte delle botteghe si chiudono, voler quasi evidenziare che “nessuno è incolpevole”. Al poeta non resta che rientrare nella propria casa, invocare Clizia, la personificazione della Poesia, e trovare, in essa, un riparo dalla tempesta che i suoi occhi hanno appena visto avvenire nel mondo di fuori. A differenza del saggio di Lucrezio, che prova serenità nel capacitarsi di non essere in mezzo a certe situazioni del mondo e nel prendere consapevolezza di non avere parte alcuna della dimensione della tempesta, il poeta Montale continua a provare angoscia anche nel chiuso della propria stanza e malgrado il suo essere accolto tra le metaforiche e rassicuranti braccia della Poesia/Clizia. Se era una ricerca di serenità a spingere il personaggio lucreziano a immergersi nella Filosofia e a trovare distacco dagli affanni quotidiani, è invece l’angoscia a muovere l’intellettuale Montale a cercare rifugio interiore nel silenzio come dimensione pacata per leggere e scrivere versi. Il distacco è presente in entrambi gli autori, ma in uno è motivo di serenità, in un altro è consapevolezza di un’impotenza tipicamente umana che non mette fine all’angoscia e mentre duraturo è, secondo Lucrezio, il rimedio della Filosofia, temporaneo è, per Montale, quello della Poesia. Anche l’immagine della tempesta è diversa: in Lucrezio è una tempesta marina che smuove le acque del mare e sconvolge un intero paesaggio; in Montale è, invece, un evento surreale che pare immobilizzare più che muovere la vita di una città e degli esseri che la abitano. Le figure umane che fanno da sfondo alla macchina che conduce Hitler sono some bloccate e apatiche a differenza dei rimandi allusivi che Lucrezio ci proietta, il quale, all’opposto, ci fa immaginare gente che comunque si barcamena per sopravvivere alla tempesta. Sicuramente la posizione del Montale è più simile alla forma d’isolamento di cui parla, in maniera critica, la Arendt mentre in Lucrezio troviamo una ricerca alla non cura assai vicina ad una forma di distacco che può divenire anche indifferenza, ma, per quanto Montale stesso, il poeta della Divina Indifferenza, predichi uno sdegnoso “aristocratico distacco”, la sua partecipazione alle cose
della vita, tuttavia, permane come ben si evince dal verso “nessuno è incolpevole”. La stessa invocazione finale a Clizia come unica forma possibile per opporre uno stile “scabro ed esenziale” ad una retorica di regime, uno sprazzo di luce alla tormenta di parole, un silenzio meditativo che apra ad una dimensione altra a parallela rispetto a quella che la mistica e bestiale coreografia totalitaria prospetta, induce ad una riflessione sul ruolo di una posizione meditativa all’interno di un contesto d’inquietudine e di prepotenza. Due sono, quindi, le figure che aprono e chiudono la poesia: una metaforizzata (Hitler/messo infernale) ed una metaforica (Clizia/la Poesia), in mezzo sta la descrizione di una tempesta surreale dove le falene sostituiscono la pioggia che storicamente si era davvero abbattuta su Firenze prima del aggio del Fuehrer e dove tutto pare bloccarsi fino a quando non giunge l’immagine di una “stanza” personale nella quale si racchiude il poeta. A differenza della Arendt, però, qui pare fermarsi Montale: manca quel vigore, che non poteva che essere proprio della Filosofia, vale a dire il voler reagire attivamente ad una situazione di crisi, facendo avvertire, con sempre maggior forza, l’invito ad una presa di coscienza che muova verso la storia e verso la realtà
Conclusioni
Dai quattro autori da me trattati emergono, dunque, due visioni riconducibili all’immagine di una tempesta: una che abbiamo definito “interna” ed un’altra “esterna”. Platone e la Arendt hanno mostrato il pericolo che scorre lungo le dinamiche che accompagnano la vita di una comunità e il danno che sorge quando il silenzio dell’intellettuale si fa palese e, attraverso un atteggiamento di indifferenza, favorisce l’avvento di una tirannide. Il ruolo di educare ad una vita etica diventa fondamentale per porre il coraggio e la libertà a guida della civiltà e mantenere viva l’attenzione del singolo verso la collettività. Lucrezio e Montale hanno, invece, presentato al lettore un’immagine di tempesta tumultuosa e in piena regola il primo; surreale e simbolica il secondo. Anche in questi due ultimi casi il richiamo non è tanto alle forze naturali, quanto alla società ed entrambi gli autori propongono un atteggiamento di distacco ed isolamento, mantenendo, però, caratteristiche molto diverse. La cosa che dovrebbe maggiormente saltare all’occhio è come la riflessione sulla condizione umana spinga a vedere quest’ultima, spesso, come una situazione di continua turbolenza, così come in un continuo stato di irrequietezza pare voler essere la società in cui si è calati. Quella mitica età dell’oro tanto cantata nel Politico, dettata da tempi più statici e dilatati cede il o ad un ritmo di vita decisamente più frenetico ed incalzante che immancabilmente si riflette sulla psychè umana e, di conseguenza, sul tipo di società che questa contribuisce a produrre. I ritmi di una dittatura sono, a loro volta, assai simili a quelli di una tempesta: veloci e spesso improvvisi. Una dittatura non avvisa mai quando sorge o quando cade, così come non avvisa mai quando adotta un provvedimento verso un singolo o un numero di cittadini. Si manifesta e si abbatte come lo scoppio improvviso di un tuono che segnala che il tempo per correre ai ripari è oramai irrevocabilmente ridotto se non esaurito. I modi con i quali gli uomini messi al potere da un colpo di Stato o da una tirannide agiscono sono spesso veloci, al pari dei fulmini di una tempesta estiva, così come simili a piogge torrenziali sono i meccanismi di propaganda con i quali un dittatore spera di mantenersi in auge. Al contrario, i tempi della democrazia sono lenti, le discussioni prendono
spazio e spesso rallentano l’applicazione di un provvedimento, ma, soprattutto, ogni democrazia che si rispetti avvisa con anticipo i cittadini dell’emanazione di una certa legge e riconosce loro il diritto di manifestare un certo dissenso e di organizzarsi per farlo. Spesso i detrattori della democrazia hanno paragonato il sistema democratico ad un pantano o ad una bonaccia, la lentezza dei suoi tempi a, così, per un ostacolo allo sviluppo di un paese e una “tempesta” viene, invece, elogiata come sintomo di fase nuova e di cambiamento. Eppure la vita di ogni giorno dimostra come grazie ad una certa lentezza, un uomo può comunque avere una garanzia di tutela e impiegare il tempo per organizzarsi, reagire o accogliere il Nuovo. Aristotele segnalava, in modo incisivo, gli svantaggi della democrazia, ma ne sottolineava anche il vero grande punto di forza ovvero quello di avere le degenerazioni meno cruente rispetto ad una forma di governo come la monarchia o ad un’altra come l’aristocrazia. Pur mantenendo un fascino di forza e di sgomento, una tempesta resta, così, pur sempre un elemento di pericolo e, in realtà, più di blocco del corso di una vita che non vita stessa.
Bibliografia
Arendt H., 2004, Le origini del totalitarismo, trad. di A. Guadagnin, Torino, Einaudi
Aristotele, 2001, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Milano, Bompiani
Camus A., 1965, “Le opere”, a cura di G. Cintioli, Milano, CDE
Conte G. B., 1989, Letteratura latina, Firenze, Le Monnier
D’Annunzio G., 1995, “Alcione”, a cura di P. Gibellini, Torino, Einaudi
Lucrezio, 2006, La natura delle cose, trad. di L. Canali, Milano, BUR
Montale E., 2004, Poesie, a cura di G. Roboni, Milano, Corriere della sera
Orwell G., 1989, “1984”, trad. di G. Baldini, Milano, Mondadori
Platone, 1994, La Repubblica, a cura di Sartore e Vegetti, Bari, Laterza
Platone, 1997, Tutte le opere – vol. IV, a cura di E. V. Maltese, Roma, Newton & Compton
Salinari C. e Ricci C., 1970, Storia della letteratura italiana, vol. III, Bari, Laterza.
Stenzel, 1966, Platone educatore, a cura di F. Gabrieli, Bari, Laterza
Meligrana Editore Via della Vittoria, 14 – 89861, Tropea (VV) Tel. (+ 39) 0963 600007 – (+ 39) 338 6157041 www.meligranaeditore.com [email protected]
Scopri tutti i nostri ebook su
Smashwords.com
Note
1 Platone, 1994, pag. 201. 2 Platone, 1994, pag. 4 3 Stenzel, 1966, pag. 258 4 Lucrezio, 2006, pag. 157 5 Aristotele, 2001, I, 3-4, 1095 a 5 – 1095b 6, pag. 55 6 H. Arendt, 2004, pag. 649 7 Arendt, cit., pp. 650 - 651
Gianluca Mungo
Published by Meligrana Editore
Copyright Meligrana Editore, 2015 Copyright Gianluca Mungo, 2015
Tutti i diritti riservati ISBN: 9788868151447
In copertina: Vincent Van Gogh, Il mare a les Saintes - Maries de la mer Giugno 1888, olio su tela, 51x64cm.
Meligrana Editore Via della Vittoria, 14 – 89861, Tropea (VV) Tel. (+ 39) 0963 600007 – (+ 39) 338 6157041 www.meligranaeditore.com [email protected]
Segui la Meligrana su:
INDICE
Frontespizio
Colophon
Licenza d’uso
Gianluca Mungo
Copertina
Navi e tempeste Tempeste di parole e piogge di falene La primavera hitleriana
Conclusioni
Bibliografia
Altri ebook di Meligrana Editore
Note
Licenza d’uso
Questo ebook è concesso in uso per l’intrattenimento personale. Questo ebook non può essere rivenduto o ceduto ad altre persone. Se si desidera condividere questo ebook con un’altra persona, acquista una copia aggiuntiva per ogni destinatario. Se state leggendo questo ebook e non lo avete acquistato per il vostro unico utilizzo, si prega di acquistare la propria copia. Grazie per il rispetto al duro lavoro di quest’autore.
Gianluca Mungo
Gianluca Mungo è nato a Crotone nel 1979. Dopo aver compiuti i primi studi a Catanzaro, si è laureato a Siena in Filosofia. Successivamente, ha compiuto studi anche ad Heidelberg, Firenze e Pisa, divenendo sia insegnante delle scuole superiori di secondo grado sia dottore di ricerca. I temi di suo interesse sono da sempre Platone e la filosofia classica. Ha pubblicato presso Meligrana Editore il testo ‘Il Sole e il Bene’ e alcuni articoli sul blog ‘Carte sensibili’.
Contatto autore: [email protected]
Navi e tempeste
Nel presente lavoro, desidero occuparmi di un tema ampiamente sviluppato in ambito poetico e artistico: La tempesta. Spesso utilizzata come metafora di una certa condizione umana o simbolo di un’intera situazione, la tempesta, come elemento fenomenico, non ha mai mancato di affascinare quanti hanno visto, nel suo manifestarsi, una potenza distruttiva e spiazzante con cui l’uomo è chiamato a fare i conti. Spesso alla tempesta si contrappone la quiete di un paesaggio naturale dove si armonizzano le diverse forme di vita, quasi, però, dimenticando che la tempesta stessa è anch’essa espressione di vita da parte della Natura. È chiaro, comunque, che, istintivamente, si sia indotti ad ascrivere alla tempesta caratteri negativi. La percezione che l’uomo tende, infatti, ad avere di un simile fenomeno è quella di pericolo e, come ogni cosa che appare pericolosa agli occhi umani, anche di elemento con una forte dose di fascino. Ne è prova la nutrita produzione artistica e letteraria che ha, appunto, una tempesta come elemento principale di una narrazione o come sfondo di una scena. Nella presente sede, voglio, però, analizzare il tema della tempesta così come esso viene affrontato in un ambito più strettamente filosofico nella sua veste di metafora della condizione umana. Il mio pensiero va a due autori della classicità che, utilizzando immagini di equipaggi in difficoltà o di tempeste propriamente dette, arrivano a conclusioni diverse riguardo, in particolare, al ruolo del saggio/sapiente nella società: Platone e Lucrezio. Entrambi ci descrivono la condizione umana simile ad una barca in preda alle onde o a problemi di organizzazione interna. Nel VI libro della Repubblica, Platone ci paragona, per esempio, la vita della polis ad una nave che necessita di una guida in un momento di forte crisi. Il pericolo, però, non proviene, in questo caso, dall’esterno: la vera tempesta che il filosofo vuol qui descrivere si svolge tutta all’interno della nave/città. Riporto il testo:
“Pensa che su molte navi o su una soltanto stia succedendo una scena come questa: figuriamoci un nocchiero superiore per grandezza o forza fisica a tutti i membri dell’equipaggio, ma piuttosto duro d’orecchio e così pure corto di vista e con altrettanto scarse conoscenze di cose navali; e i marinai che altercano fra loro per il governo della nave, ciascuno credendosi in diritto di governarla lui, mentre non ne ha mai appreso l’arte né può dichiarare con quale maestro e in quale tempo l’ha appresa; e inoltre affermano che quest’arte non si può insegnare, pronti anche a fare a pezzi chi la dica insegnabile; tutti sempre stretti attorno alla persona del nocchiero, a pregarlo e premerlo in tutti i modi perché affidi loro la barra¹.” (Rep., VI, 487 – 488)
L’immagine della nave, che abbiamo visto descritta nel brano appena letto, precorre, per molti versi, il celeberrimo o della Caverna e riesce, forse, per taluni aspetti, ad essere ancora più emblematico. In tale immagine, si ravvisano, infatti, tutti gli elementi platonici riguardanti il ruolo del filosofo e della filosofia all’interno di una società e al rischio cui va incontro un professato amore per la verità. Da una parte, l’accusa più stereotipata che possa essere rivolta alla filosofia vale a dire quella di essere inutile chiacchiera per via della sua vocazione ad una conoscenza del Tutto; dall’altra il dovere che, secondo Platone, dovrebbe essere proprio del filosofo, colto nella sua vocazione ad andare avanti allo scopo di portare un messaggio di coerenza tra un certo dire ed un certo fare. Il filosofo platonico ha, pertanto, un dovere verso la società che nasce dalla sua stessa inclinazione a filosofare e in particolare nella politica ovvero nell’educazione ad una certa vita spirituale e nel contempo pratica, la filosofia vede compiersi il proprio destino. Nell’esempio della nave è palese sia la consapevolezza che Platone ha delle accuse di inutilità mosse alla filosofia e della visione, assai superficiale, che di essa la società del tempo, in maniera non dissimile dalla nostra, si era fatta che l’intenzione di sottolineare un ruolo specifico della figura del filosofo all’interno di questa stessa società. Nel mito della Caverna, i filosofi sono coscienti di rischiare anche la vita nel loro portare avanti un messaggio di verità, così come di ricevere pure un’offesa di natura morale ben più grave: la denigrazione del loro logos che arriva a porre il filosofare ai livelli di follia se non di insensatezza. In fondo, non v’è aggettivo più dissacratorio per un filosofo di quello di “acchiappanuvole” (‘scrutatore del
cielo’). Il fatto che nell’arco della stessa opera una simile questione ritorni due volte in due esempi e in due libri diversi, suggerisce quanto sia importante, all’interno della filosofia socratica e platonica, la riflessione sul senso vero della filosofia. Dalle cronache del tempo, si evince, per esempio, che, coerentemente al suo stile ironico, Socrate riesce, forse per primo, a prendere in maniera bonaria la critica mossa a chi dà un certo e particolare quanto sarcastico alone al filosofare. Sappiamo, infatti, che un buon rapporto lo legava ad Aristofane e che non disdegnasse di assistere, con un certo piacere, alla rappresentazione delle “Nuvole”. Nel VI libro della Repubblica, l’interlocutore di Socrate, però non è Aristofane, ma un amico che sembra quasi volersi sfogare del fatto che a molti la Filosofia appaia come un’inutile perdita di tempo. Perché, infatti, porre tanta attenzione ad un qualcosa di propedeutico alla politica? La cultura classica vedeva nella politica il fine ultimo e l’occupazione principale della vita di un uomo: il cittadino della polis era chiamato a partecipare attivamente alla vita politica della propria città e le scuole di retorica e pensiero fungevano a formare i futuri rampolli della classe dirigente. La filosofia, in tale contesto, era vista dai più come una sorta di mero esercizio intellettuale che era bene, crescendo, mettere da parte. La risposta socratico/platonica confluirà nella famosa provocazione (uno dei tre “scandali” di cui parla Vegetti²) di presentare i filosofi come gli unici degni a salire al potere. La filosofia non s’identifica, così, con l’infanzia dell’umanità, bensì con la sua crescita e in un’opera quale il Fedone la stessa viene chiamata ad educare l’uomo alla preparazione della conclusione della propria vita. Una compagna, quindi, che segue la vita dell’uomo lungo tutte le sue tappe fino al suo epilogo. Per il singolo, l’opera della Filosofia finisce quando si conclude la vita di questi, una continua conversazione il cui “Alt!” è suonato dalla morte dell’individuo, ma che prima di allora è servita ora a demitizzare, ora a costruire una vita esistenziale più autentica e un atteggiamento più maturo e sereno verso la morte e, di conseguenza, verso le cose della vita. Nel momento in cui si parla di collettività, si parla però di storia dell’umanità e gli interrogativi qui coinvolgono tutte le contraddizioni tra un dire e un fare cui la vita quotidiana dà adito. In tal caso, la filosofia non può esaurire il suo compito con la morte di un individuo, ma deve andare oltre: è chiamata a dare un segno tangibile nella storia e ciò può farlo solo con la “paideia”. Il compito del filosofare è, pertanto, educare ad una ricerca più solida di una certa moralità. La nave non può continuare a stare in balia delle acque e delle chiacchiere che la bloccano, gli “acchiappanuvole” devono cercare di condurla ad un porto stabile. Quello che abbiamo, quindi, qui definito come una sorta di “tempesta interna” è, in realtà,
una partita interamente umana: da una parte gli eventi; dall’altra l’opera di un essere dotato di raziocinio, ma anche di ione e come tale volubile. L’aspetto più peculiare dell’esempio della nave è che Platone non ci dice se effettivamente una simile imbarcazione si stia trovando in condizioni critiche da un punto di vista climatico e naturale: non ci viene descritto né uno stato di bonaccia né di tempesta, ma un autentico “tram tram” interno che arriva a sconvolgere la normalità della vita quotidiana di una polis in qualsiasi momento. In uno stato in cui tutti vogliono governare e fomentare i propri egoistici interessi, come più volte nota Stenzel³, gli unici a restare fedeli alla propria “paideia” e a cercare di porre una certa Phronesis a guida dell’immaginaria nave saranno appunto i saggi, i quali si ritroveranno, però, ad essere inascoltati. Nella visione platonica, malgrado tutto, questi stessi saggi rimangono comunque al loro posto all’interno della nave, continuano a dimorare dentro di essa e non si allontanano neanche dopo la derisione. Subiscono il destino della nave né più né meno di come Socrate accetterà il proprio e questo nonostante essi sappiano in che modo andrà a finire una navigazione così mal gestita. Per via di un simile modo di insistere sulla questione, Platone si rivela un pensatore “greco” e, nella fattispecie, “ateniese”: l’attività politica è e resta un bene, il fine ultimo in cui lo spirito filosofico deve concretizzarsi. A distanza di anni, diametralmente opposta sarà la visione che Lucrezio avrà della filosofia e della politica: nel celeberrimo o del II libro del “De rerum natura”, viene descritta una tempesta sul mare, ma, soprattutto, viene commentato il piacere che si può provare nell’osservarla, sapendo di non essere da questa toccati a differenza di chi invece deve affrontarla, rischiando la propria vita. Anche se non viene direttamente menzionato, è chiaro che il riferimento va all’equipaggio di una nave. Stavolta si tratta dunque di una tempesta in piena regola e l’ipoetico equipaggio che si può intravedere tra le righe è costretto a barcamenarsi e ad impiegare tutte le forze per non fare affondare la nave e cercare letteralmente di salvare almeno la pelle. Da lontano, assiste alla scena un saggio che, pur provando comione per i poveri uomini, guardando al proprio stato interiore, gioisce del pensiero di vivere una situazione ben diversa. Facendo leva sul senso di sicurezza che psicologicamente ciascun uomo è indotto a provare quando si accorge di non esser toccato dal pericolo che incombe su altre teste, Lucrezio scrive:
“È dolce, quando i venti sconvolgono le distese del vasto mare,
guardare da terra il grande travaglio di altri;
non perché l’altrui tormento sia un giocondo diletto,
bensì perché t’allieta vedere da quali affanni tu sia immune⁴.”
(De Rerum natura, libro II, vv. 1-4)
E’ cambiata un’intera epoca e la nostra nottola di Minerva prende atto di quanto, nel frattempo, è avvenuto: la politica ha smesso di essere la principale occupazione degna di ogni uomo libero, la polis non chiama più a sé i suoi cittadini e la filosofia cambia il proprio ruolo. Se prima Platone spingeva il vero filosofo ad entrare nella caverna e a correre il rischio di farsi deridere sulla nave, in omaggio ad una visione in cui la filosofia deve diventare una sola cosa con la politica, in Lucrezio è l’esatto opposto: la filosofia deve allontanare l’uomo dagli affanni della quotidianità e sostituire un proprio chiuso spazio interiore al Daimon socratico, che, invece, pungola l’uomo a un ‘non fare’ che di fatto è, in realtà, una spinta ad agire. Si fa sempre notare, a riguardo, come il Giardino epicureo sia lontano dalla città né più né meno di come l’Accademia e il Liceo avevano sede al suo interno. La tempesta descritta da Lucrezio non è causata dagli uomini desiderosi di potere, ma è un evento esterno che si abbatte su una società e che coinvolge quanti sono al suo interno. L’intellettuale sa che il rimedio è allontanarsi e trovare una certa solidità nel proprio animo, cosa, questa, che conferma come la ricerca di quiete intesa come lontananza dagli affanni sia l’unica strada percorribile per ottenere una vita beata. È impressionante quanto abissale sia la
distanza tra i due autori: un saggio per Platone non può godere di una sua distanza dai problemi umani e quel che in Lucrezio diventa motivo e sintomo di serenità e di distacco, in Platone sarebbe stata impotenza e, pertanto, situazione da non ricercare. La filosofia ha, in Platone, senso solo quando diventa mero interesse per l’uomo e per i suoi interrogativi e si apre a quella che è un’autentica prassi politica. In Lucrezio, invece, il compito del filosofare consiste nell’alienare il saggio dalle ioni quotidiane: la politica è, così, tanto più in Platone un terreno di ioni come d’ideali in cui filosofare significa tracciare le differenze delle une dalle altre quanto in Lucrezio è solo cumulo di ioni e di affanni legati ad un momento effimero che conduce l’uomo ad una manifesta vanitas vanitatis. Il filosofo epicureo non trova, dunque, posto all’interno della barca, ma preferisce starsene lontano e eggiare sulla sicura terraferma, guardando, in maniera distaccata, la società né più né meno di come il filosofo platonico assiste le cose all’interno di essa e parla con i suoi diretti protagonisti. Prepararsi alla morte in Socrate voleva, inoltre, significare vivere intensamente le cose della vita e meditarle; in Lucrezio la morte ideale è, come in Epicuro, il sereno spegnimento di una vita interiore conscia della materialità dell’esistenza e della necessità di distaccarsi dalle vacuità della vita quotidiana. In entrambi gli autori, la metafora di una nave con il suo equipaggio in pieno affanno è usata con intenzioni, come abbiamo visto, diverse. Nel secondo di essi, in particolare, si avvertono gli echi di un’epoca in cui la politica è uscita dalle piazze per chiudersi nei palazzi di potere e la discussione è affrontata all’interno di chiuse stanze. I problemi dell’uomo iniziano ad essere, così, marcatamente ancora più individuali ed esistenziali e, soprattutto, non più oggetto della “politica”. Se nell’Etica Nicomachea, Aristotele continuava ad insistere che fine della politica fosse l’eudaimonia⁵, in Epicuro prima e in Lucrezio dopo cambia l’ottica della “felicità”: essa non è amministrazione e cura del bene comune o, meglio, della giustizia vista come dimensione per realizzare la ricerca etica e pertanto filosofica, né, tanto meno, ricerca di un Sapere superiore quanto distacco dagli affanni quotidiani mentre quel che in Platone come in Socrate era dovere del filosofo, negli epicurei diventa mera ambizione. L’uomo, in sostanza, cessa di essere uno “Zoon politikòn” per divenire soprattutto individuo. Prendere coscienza della materialità dell’esistenza è il primo o per
comprendere la vacuità delle ambizioni umane e la filosofia invita il saggio a non affrontare mai la tempesta, ma a guardarla, un po’ compiacente, da lontano. Un poema che iniziava con l’inno a Venere e si chiudeva con la drammatica rappresentazione della peste di Atene induceva, secoli dopo, un San Gerolamo a ipotizzare il sopravvento della follia nella mente dell’autore. Vista da una certa prospettiva, in realtà, la descrizione di un malessere che, appunto, al pari di una tempesta si abbatte su una città come Atene in piena gestione di una strategia di guerra quale quella voluta da Pericle per controbattere l’offensiva spartana, dovrebbe far meglio cogliere l’essenza della vacuità umana che sta alla base dell’esasperata ricerca di un trionfo, non curante che tutto ha una fine, che gli eccessi volgono sempre al peggio e che l’uomo nulla può contro gli imprevisti (Pericle non poteva certo prevedere che l’ammasso di gente all’interno delle mura del Pireo avrebbe facilitato il diffondersi dell’epidemia) e contro un destino che porta necessariamente al nulla. L’unica soluzione che l’uomo può trovare è a livello individuale e non collettivo ovvero accettare la realtà nella sua essenza materiale e nella sua caratteristica di esser sempre e comunque volta ad una fine per dedicarsi, così, alle poche cose importanti che possano assicurare una certa serenità interiore, tenendo, di conseguenza, lontani i falsi timori (morte e dei) e gli inutili affanni. Socrate e Platone, a differenza di Lucrezio, avevano, però, assistito direttamente allo sfascio di Atene e da tale esperienza avevano tratto l’interesse più vivo per affrontare direttamente i problemi della vita etica e politica, dando alla filosofia un ruolo di farmaco molto diverso da quello che avrebbe poi descritto Epicuro. Al pari di una medicina che consente ad un corpo malato di riacquistare salute e vigore per riprendere le attività di sempre, il filosofare avrebbe dovuto restituire all’anima i suoi orizzonti più propri e, quindi, riconsegnarla ad una sfera politica. Tanto in Platone quanto in Lucrezio, la metafora della tempesta non è, dunque, semplice riferimento alla politica, ma alla vita in generale così come essa va affrontata giorno per giorno: il male in Platone si può curare; in Lucrezio è solo da accettare e da tenere lontano.
Tempeste di parole e piogge di falene
Facendo un salto di parecchi secoli, si può notare che, da un punto di vista simbolico e letterario, la tempesta continua ad essere immagine di forza, ma anche di turbamento sia per il singolo che per un’intera comunità. Ad essa viene sempre accomunata l’idea di un qualcosa che si abbatte violentemente su una certa quotidianità, sconvolgendone l’ordine. Non è un caso che nel Novecento all’immagine della tempesta venga associata l’idea di una guerra o di una dittatura. Nei riguardi della politica, i due atteggiamenti prima analizzati che la classicità ci ha consegnato restano fondamentalmente immutati: se la Grecia di Platone era una terra di poleis e di tirannidi e la Roma di Lucrezio conosceva i germi delle diverse metamorfosi che il corso della storia le avrebbe fatto incontrare, l’Europa del Novecento è un continente di democrazie e di dittature totalitarie. La filosofia non cambia quella posizione che Platone aveva descritto nel VI libro della Repubblica ovvero di disciplina inascoltata e ridicolizzata dal potere (ormai si è andata a fare sempre più marcata la distinzione tra “uomo di pensiero” e “uomo d’azione”). Gli intellettuali sono comunque chiamati a prendere una posizione nei riguardi del potere: Se Camus paragonava il Nazismo alla peste, c’era chi, come D’Annunzio, diffondeva un’immagine di uomo tipicamente legata agli entusiasmi dell’epoca e la bellissima “Pioggia nel Pineto” dava un’incisiva immagine di fusione tra forze naturali ed umane. Ben presto, però, la realtà avrebbe mostrato il suo vero volto e le promesse fatte da un qualsiasi tiranno del Novecento si sarebbero rivelate le stesse megalomanie tanto osteggiate millenni prima da Platone. I due intellettuali che, nella presente sede, eleggo, quindi, a “campioni” del Novecento sono due figure molto diverse tra loro: Eugenio Montale ed Hannah Arendt. Entrambi vivono il fenomeno del Nazismo e del Fascismo, ma ambedue consegnano un’immagine molto diversa del rapporto intellettuale/potere. La Arendt propone, in fondo, malgrado alcune sue osservazioni (per la verità, in ‘Vita activa’, un po’ fuorvianti), un vero ritorno al mondo classico e filosofico di Platone. Ne “Le origini del Totalitarismo” ci descrive, così, l’evolversi di un fenomeno che, nella perseverante cura della propaganda di massa, finisce, tramite una sorta di pioggia incessante dove le gocce d’acqua sono sostituite da parole e slogan, per entrare nel cervello della gente fino a fare un’autentica
violenza concettuale alla spontaneità ed alla libertà del pensiero. Spina dorsale di un totalitarismo, secondo lo Arendt, è la sua intrinseca coerenza logica, così come suo fine è far rientrare l’intera realtà all’interno di un suo concetto, parcellizzando, frantumando e, infine, annullando l’individualità di ciascun singolo. Un’ideologia dittatoriale nasce, infatti, con un’operazione di concettualizzazione della realtà e una tempesta di parole, suoni e immagini inneggianti sono il mezzo più efficace per raggiungere un simile obiettivo e con esso il consenso delle masse. Da una politica di classi si a ad una propaganda di e per le masse. Senza consenso la dittatura si annulla: la retorica di un regime fa necessariamente leva sulle immagini di forza, di stabilità e di “assolutamente buono e giusto”, rispolverando tutte le tecniche che i sofisti avevano insegnato per storpiare i lineamenti della verità, al fine di irrigidire l’intera realtà dentro un concetto il cui mantenimento ad oltranza è indispensabile per la sopravvivenza del regime stesso oltre che per assicurarsi poteri sempre più ampi. Il concetto violenta, in questo modo, la realtà per poi trascurarla e sovrapporsi ad essa. In natura, una normale tempesta sconvolge lo status quo delle cose per poi aprire ad una rinnovata quiete; una dittatura, invece, stravolge per poi immobilizzare. Da cosa trae, però, un totalitarismo la sua vera forza? La risposta della Arendt è una delle più incisive: dall’indifferenza del cittadino verso i valori di una civiltà. È interesse dei regimi mantenere tale indifferenza e da ciò si spiega l’abolizione e la persecuzione spesso attuata nei confronti della libertà di pensiero e di espressione. Nelle pagine finali delle Origini del totalitarismo la Arendt scrive:
“La coercizione del terrore totale, che irreggimenta le masse di individui isolati e la sostiene in un mondo che per esse è diventato un deserto […] Come il terrore, anche nella sua forma pretotatle, semplicemente tirannica, distrugge tutti i legami fra gli uomini. Così l’autocostruzione del pensiero ideologico distrugge tutti i legami con la realtà […] Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione tra realtà e finzione, tra il vero e il falso non esiste più .”
L’autrice fa, quindi, una distinzione molto profonda tra isolamento ed
estraniazione:
“L’isolamento e l’impotenza, cioè la fondamentale incapacità di agire, sono sempre stati tipici delle tirannidi. […] L’isolamento e l’estraniazione non sono la stessa cosa. Posso essere isolato – cioè in una situazione in cui non posso agire perché non c’è nessuno disposto ad agire con me – senza essere estraniato; e posso essere estraniato – cioè in una situazione in cui come persona mi sento abbandonato dal consorzio umano – senza essere isolato. […] Mentre l’isolamento concerne soltanto l’aspetto politico della vita, l’estraniazione concerne la vita umana nel suo insieme⁷.”
L’isolamento non è, di per sé, estraniazione, ma può diventarlo ed è tutto interesse dei regimi far sì che divenga tale. Resta sicuramente abissale la differenza tra la scelta di isolarsi e il subire un’estraniazione: un uomo, intellettuale o no, può volutamente decidere d’isolarsi, di distaccarsi, sia pure per meglio meditare le cose della propria esistenza e/o della vita in generale. Nell’isolamento, si può trovare un’isola di pace e di quiete per poter prendere serenamente coscienza di una data realtà e cercare di elaborare una risposta ad essa. Estraniare significa, invece, alienare, annullare interessi e vitalità allo spirito dell’uomo, rendendolo apatico e restio ad ogni forma di reazione ad un regime. I sudditi ideali di una dittatura sono, pertanto, assai simili ai plagiati, timorosi abitanti degli orwelliani continenti descritti in 1984. l’estraniazione leva il coraggio e la libertà di volere o di negare (dire “No!”) propri dell’essere umano, facendolo divenire lo strumento principale per il protrarsi di uno status totalitario. La Arendt, per scongiurare il pericolo di avere un popolo di estraniati, propone, dunque, un ritorno all’interesse vivo che legava il cittadino greco alla sua polis. All’indifferenza deve subentrare la ione di un interesse e all’apatia la cura della cosa pubblica. Resuscitando e mantenendo, infatti, lo spirito della Boulé, intesa come assemblea viva di uomini liberi chiamati a dire la propria, la democrazia rafforza le proprie radici, relegando ad un margine sempre più ristretto uno spirito totalitario. Nel momento in cui, invece, si attua lo scarto tra individuo e comunità, si viene a definire quel tipico vuoto spesso riempito da una dittatura. Avvicinare il cittadino alla propria collettività è, dunque, l’unico modo per scongiurare il ritorno di un tale vuoto nella storia civile di un popolo.
Il totalitarismo, in fondo, proprio in quanto fenomeno di massa, non può essere arginato da una politica classista ed elitaria, che vede solo in qualche nicchia il proprio consenso. Per impedire il sopravvento di una tirannide è necessario che il popolo divenga spazio d’incontro tra individui in cui ogni membro si percepisca come parte armonica di una comunità e dove il proprio diritto politico giunga a prendere l’aspetto di dovere morale e primaria aspirazione di un uomo nella vita. La “massa” o, meglio, il cittadino diventerebbe, in questo modo, non più oggetto e territorio fertile su cui fare propaganda, bensì primo soggetto della storia di un paese. Se la filosofa Arendt spinge, quindi, l’uomo, in particolare l’intellettuale, a riappropriarsi della sfera politica e a muoversi verso la gestione della cosa pubblica, manifestando interesse a ché le regole del gioco vengano rispettate per aprirsi ad una forma di partecipazione di democrazia diretta intesa, in primis, come discussione aperta, di ben altro avviso è il poeta Eugenio Montale. Se virtualmente possiamo costruire un ponte che lega il Platone del VI libro della Repubblica alla Arendt che analizza il fenomeno del totalitarismo, mettendo a confronto anche le due visioni di “tempeste interne”, che generano la tirannide, altrettanto possiamo fare, con le dovute differenze e cautele, tra i poeti Lucrezio e Montale. La Arendt e Montale sono, per prima cosa, autori sicuramente diversi in tutto: Montale, a differenza della filosofa tedesca, predica un “aristocratico distacco” verso la società e alla presa di coscienza che l’esistenza è attanagliata dal “male di vivere”, dal cui cerchio non si po’ fuggire e che si può solo rappresentare tramite uno stile “scabro ed essenziale”, fa eco un rifiuto, da parte del poeta, a rendersi partecipe di talune vicende umane che, nel loro insieme, non fanno altro che esasperare la condizione del male di vivere che abbraccia ogni forma di vita presente sulla faccia della terra. Se ne deduce il poco impegno politico che Montale, malgrado la sua nomina a senatore a vita, poté avere in quanto poeta: le sue tematiche ruotano, soprattutto, attorno al tema dell’esistenza e al ruolo della poesia come rappresentazione e rifugio. Tuttavia, possediamo anche qualche scritto di Montale che ha un carattere più propriamente politico e non solo esistenziale, il più suggestivo dei quali è sicuramente il componimento poetico “La primavera hitleriana”, che ritengo opportuno riportare qui per intero e di cui consiglio vivamente la lettura, la quale, come si noterà, procede secondo ritmi incalzanti quanto incisivi da un punto di vista emotivo:
La primavera hitleriana
Né quella ch’a veder lo sol si gira.... DANTE (?) a Giovanni Quirini
Folta la nuvola bianca delle falene impazzite turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, stende a terra una coltre su cui scricchia come su zucchero il piede; l’estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai.
Da poco sul corso è ato a volo un messo infernale tra un alalà di scherani, un golfo mistico e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito, si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive benché armate anch’esse di cannoni e giocattoli di guerra,
ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi, la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue s’è tramutata in un sozzo trescone d’ali schiantate, di larve sulle golene, e l’acqua séguita a rodere le sponde e più nessuno è incolpevole.
Tutto per nulla, dunque? - e le candele romane, a San Giovanni, che sbiancavano lente l’orizzonte, ed i pegni e i lunghi addii forti come un battesimo nella lugubre attesa dell’orda (ma una gemma rigò l’aria stillando sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi gli angeli di Tobia, i sette, la semina dell’avvenire) e gli eliotropi nati dalle tue mani - tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e ha punte di sinibbio.... Oh la piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte! Guarda ancora
in alto, Clizia, è la tua sorte, tu che il non mutato amor mutata serbi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbàcini nell’Altro e si distrugga in Lui, per tutti. Forse le sirene, i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda, si confondono già col suono che slegato dal cielo, scende, vince col respiro di un’alba che domani per tutti si riaffacci, bianca ma senz’ali di raccapriccio, ai greti arsi del sud... (da “La bufera”)
La poesia rievoca la storica visita di Hitler a Firenze nel 1938 cui Montale poté assistere di persona. Sin dal primo verso, il componimento ci proietta in un clima surreale: dal cielo sulla città si abbatte una pioggia di falene impazzite, che cadono e muoiono per terra, riempiendo le strade dei loro cadaveri che scricchiolano “come zucchero” sotto il tacco delle scarpe. Alla pioggia di falene, corrisponde un gelo improvviso che sembra emanarsi da un’estate che ancora deve venire, ma che già cova, nel suo interno, una tremenda inquietudine. Pare essere l’intera natura a voler rifiutare e manifestare il proprio dissenso ad un evento che non s’identifica con l’umano e che non viene mai citato per nome, ma che ben presto si manifesta nell’immagine di un “messo infernale”, che, sull’auto che lo porta si fa strada tra “alalà di scherani” e croci uncinate. Molto forte è la contrapposizione tra una simile immagine di Hitler, che impersona il Male e che viene, così, paragonato ad un “messo infernale” inghiottito come da
un turbine di folla e una Natura che manifesta una sorta di negazione verso un suo stesso figlio, che, di fatto, pare essere del tutto contro-natura, in quanto pericolo e fonte di inquietudine per la natura stessa. Alla pioggia di falene, ad un’atmosfera come bloccata, ad un gelo improvviso e alle finestre delle case e delle vetrine dei negozi che, per protesta, si chiudono e si sbarrano, fa eco lo scroscio delle acque del fiume Arno, le quali vorticano indifferenti e che sembrano, man mano che le porte delle botteghe si chiudono, voler quasi evidenziare che “nessuno è incolpevole”. Al poeta non resta che rientrare nella propria casa, invocare Clizia, la personificazione della Poesia, e trovare, in essa, un riparo dalla tempesta che i suoi occhi hanno appena visto avvenire nel mondo di fuori. A differenza del saggio di Lucrezio, che prova serenità nel capacitarsi di non essere in mezzo a certe situazioni del mondo e nel prendere consapevolezza di non avere parte alcuna della dimensione della tempesta, il poeta Montale continua a provare angoscia anche nel chiuso della propria stanza e malgrado il suo essere accolto tra le metaforiche e rassicuranti braccia della Poesia/Clizia. Se era una ricerca di serenità a spingere il personaggio lucreziano a immergersi nella Filosofia e a trovare distacco dagli affanni quotidiani, è invece l’angoscia a muovere l’intellettuale Montale a cercare rifugio interiore nel silenzio come dimensione pacata per leggere e scrivere versi. Il distacco è presente in entrambi gli autori, ma in uno è motivo di serenità, in un altro è consapevolezza di un’impotenza tipicamente umana che non mette fine all’angoscia e mentre duraturo è, secondo Lucrezio, il rimedio della Filosofia, temporaneo è, per Montale, quello della Poesia. Anche l’immagine della tempesta è diversa: in Lucrezio è una tempesta marina che smuove le acque del mare e sconvolge un intero paesaggio; in Montale è, invece, un evento surreale che pare immobilizzare più che muovere la vita di una città e degli esseri che la abitano. Le figure umane che fanno da sfondo alla macchina che conduce Hitler sono some bloccate e apatiche a differenza dei rimandi allusivi che Lucrezio ci proietta, il quale, all’opposto, ci fa immaginare gente che comunque si barcamena per sopravvivere alla tempesta. Sicuramente la posizione del Montale è più simile alla forma d’isolamento di cui parla, in maniera critica, la Arendt mentre in Lucrezio troviamo una ricerca alla non cura assai vicina ad una forma di distacco che può divenire anche indifferenza, ma, per quanto Montale stesso, il poeta della Divina Indifferenza, predichi uno sdegnoso “aristocratico distacco”, la sua partecipazione alle cose
della vita, tuttavia, permane come ben si evince dal verso “nessuno è incolpevole”. La stessa invocazione finale a Clizia come unica forma possibile per opporre uno stile “scabro ed esenziale” ad una retorica di regime, uno sprazzo di luce alla tormenta di parole, un silenzio meditativo che apra ad una dimensione altra a parallela rispetto a quella che la mistica e bestiale coreografia totalitaria prospetta, induce ad una riflessione sul ruolo di una posizione meditativa all’interno di un contesto d’inquietudine e di prepotenza. Due sono, quindi, le figure che aprono e chiudono la poesia: una metaforizzata (Hitler/messo infernale) ed una metaforica (Clizia/la Poesia), in mezzo sta la descrizione di una tempesta surreale dove le falene sostituiscono la pioggia che storicamente si era davvero abbattuta su Firenze prima del aggio del Fuehrer e dove tutto pare bloccarsi fino a quando non giunge l’immagine di una “stanza” personale nella quale si racchiude il poeta. A differenza della Arendt, però, qui pare fermarsi Montale: manca quel vigore, che non poteva che essere proprio della Filosofia, vale a dire il voler reagire attivamente ad una situazione di crisi, facendo avvertire, con sempre maggior forza, l’invito ad una presa di coscienza che muova verso la storia e verso la realtà
Conclusioni
Dai quattro autori da me trattati emergono, dunque, due visioni riconducibili all’immagine di una tempesta: una che abbiamo definito “interna” ed un’altra “esterna”. Platone e la Arendt hanno mostrato il pericolo che scorre lungo le dinamiche che accompagnano la vita di una comunità e il danno che sorge quando il silenzio dell’intellettuale si fa palese e, attraverso un atteggiamento di indifferenza, favorisce l’avvento di una tirannide. Il ruolo di educare ad una vita etica diventa fondamentale per porre il coraggio e la libertà a guida della civiltà e mantenere viva l’attenzione del singolo verso la collettività. Lucrezio e Montale hanno, invece, presentato al lettore un’immagine di tempesta tumultuosa e in piena regola il primo; surreale e simbolica il secondo. Anche in questi due ultimi casi il richiamo non è tanto alle forze naturali, quanto alla società ed entrambi gli autori propongono un atteggiamento di distacco ed isolamento, mantenendo, però, caratteristiche molto diverse. La cosa che dovrebbe maggiormente saltare all’occhio è come la riflessione sulla condizione umana spinga a vedere quest’ultima, spesso, come una situazione di continua turbolenza, così come in un continuo stato di irrequietezza pare voler essere la società in cui si è calati. Quella mitica età dell’oro tanto cantata nel Politico, dettata da tempi più statici e dilatati cede il o ad un ritmo di vita decisamente più frenetico ed incalzante che immancabilmente si riflette sulla psychè umana e, di conseguenza, sul tipo di società che questa contribuisce a produrre. I ritmi di una dittatura sono, a loro volta, assai simili a quelli di una tempesta: veloci e spesso improvvisi. Una dittatura non avvisa mai quando sorge o quando cade, così come non avvisa mai quando adotta un provvedimento verso un singolo o un numero di cittadini. Si manifesta e si abbatte come lo scoppio improvviso di un tuono che segnala che il tempo per correre ai ripari è oramai irrevocabilmente ridotto se non esaurito. I modi con i quali gli uomini messi al potere da un colpo di Stato o da una tirannide agiscono sono spesso veloci, al pari dei fulmini di una tempesta estiva, così come simili a piogge torrenziali sono i meccanismi di propaganda con i quali un dittatore spera di mantenersi in auge. Al contrario, i tempi della democrazia sono lenti, le discussioni prendono
spazio e spesso rallentano l’applicazione di un provvedimento, ma, soprattutto, ogni democrazia che si rispetti avvisa con anticipo i cittadini dell’emanazione di una certa legge e riconosce loro il diritto di manifestare un certo dissenso e di organizzarsi per farlo. Spesso i detrattori della democrazia hanno paragonato il sistema democratico ad un pantano o ad una bonaccia, la lentezza dei suoi tempi a, così, per un ostacolo allo sviluppo di un paese e una “tempesta” viene, invece, elogiata come sintomo di fase nuova e di cambiamento. Eppure la vita di ogni giorno dimostra come grazie ad una certa lentezza, un uomo può comunque avere una garanzia di tutela e impiegare il tempo per organizzarsi, reagire o accogliere il Nuovo. Aristotele segnalava, in modo incisivo, gli svantaggi della democrazia, ma ne sottolineava anche il vero grande punto di forza ovvero quello di avere le degenerazioni meno cruente rispetto ad una forma di governo come la monarchia o ad un’altra come l’aristocrazia. Pur mantenendo un fascino di forza e di sgomento, una tempesta resta, così, pur sempre un elemento di pericolo e, in realtà, più di blocco del corso di una vita che non vita stessa.
Bibliografia
Arendt H., 2004, Le origini del totalitarismo, trad. di A. Guadagnin, Torino, Einaudi
Aristotele, 2001, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Milano, Bompiani
Camus A., 1965, “Le opere”, a cura di G. Cintioli, Milano, CDE
Conte G. B., 1989, Letteratura latina, Firenze, Le Monnier
D’Annunzio G., 1995, “Alcione”, a cura di P. Gibellini, Torino, Einaudi
Lucrezio, 2006, La natura delle cose, trad. di L. Canali, Milano, BUR
Montale E., 2004, Poesie, a cura di G. Roboni, Milano, Corriere della sera
Orwell G., 1989, “1984”, trad. di G. Baldini, Milano, Mondadori
Platone, 1994, La Repubblica, a cura di Sartore e Vegetti, Bari, Laterza
Platone, 1997, Tutte le opere – vol. IV, a cura di E. V. Maltese, Roma, Newton & Compton
Salinari C. e Ricci C., 1970, Storia della letteratura italiana, vol. III, Bari, Laterza.
Stenzel, 1966, Platone educatore, a cura di F. Gabrieli, Bari, Laterza
Meligrana Editore Via della Vittoria, 14 – 89861, Tropea (VV) Tel. (+ 39) 0963 600007 – (+ 39) 338 6157041 www.meligranaeditore.com [email protected]
Scopri tutti i nostri ebook su
Smashwords.com
Note
1 Platone, 1994, pag. 201. 2 Platone, 1994, pag. 4 3 Stenzel, 1966, pag. 258 4 Lucrezio, 2006, pag. 157 5 Aristotele, 2001, I, 3-4, 1095 a 5 – 1095b 6, pag. 55 6 H. Arendt, 2004, pag. 649 7 Arendt, cit., pp. 650 - 651